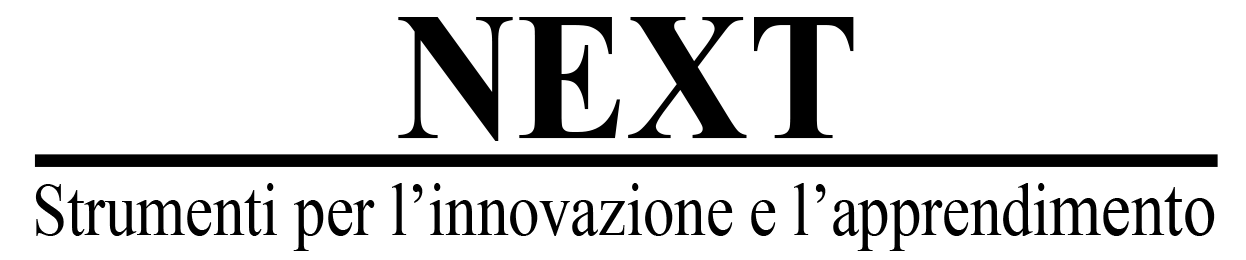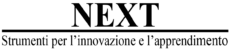di Massimo Fargnoli
Damnatio Memoriae
Pars destruens. La damnatio memoriae scientemente perpetrata nei confronti delle sue Orchestre storiche ha il sinistro intento di far rimuovere dalla coscienza collettiva il fatto che quella Nazionale di Torino – al netto della sua alta qualità e professionalità – sia stata fondata trent’anni orsono su uno dei più efferati crimini culturali dall’unità d’Italia: la disintegrazione di tre Orchestre e tre Cori ai danni di altrettante città, Milano, Roma e Napoli, con contraccolpi di diversa entità sui rispettivi tessuti artistico-professionali. Una destrutturazione del sistema musicale nazionale che vedeva nelle quattro orchestre della Rai, civilmente pagate con il canone degli abbonati – oltre agli interventi degli sponsor a seconda della capacità manageriale delle sedi – una sorta di spina dorsale strategica per la divulgazione della musica cosiddetta classica nel nostro Paese, dove la nomenclatura stessa del linguaggio musicale è stata concepita e dunque da dover tutelare come o più di qualunque altro bene culturale. Attese le grandi tradizioni di ciascuna e soprattutto la facoltà di produrre e trasmettere nel circuito radiotelevisivo nazionale, con una diffusione capillare nel raggiungere pluralmente tutti i cittadini italiani da tre macroaree del Paese e non autocraticamente da una sola città.
Fino al 1990, la tenace direzione generale di Biagio Agnes scongiurò quella catastrofe riuscendo a resistere alle imperiose pressioni interne che trovarono però arroganti sponde politiche nelle governance successive, così che la furia devastante di quel provvedimento, come ebbi modo di esprimermi al tempo, fu paragonabile all’abbattimento con la ruspa di tre pinacoteche o tre biblioteche o tre musei, nel soffocare espressioni immateriali che solo la musica tra le arti può realizzare: «Per la musica, l’esecuzione è la vita, un’opera non ha il respiro perenne di un quadro: nascosta, essa è polvere» come ci avvertiva il buon Gnecchi agli inizi del secolo scorso. Il crudele annientamento di tre+tre strutture sociali endogene, quali a tutti gli effetti risultano le Orchestre e i Cori in ogni latitudine (pensiamo solo al Venezuela!) determinò il trasferimento coatto di centinaia di professori, al netto di qualche eccezione dolorosamente svèlti dalle loro sedi naturali, con decine di valenti prime parti compresse nella sola struttura di Torino in una sorta di catena di montaggio, insieme ai loro percorsi artistici, emotivi, di decennali condivisioni con i colleghi, il pubblico e gli stessi giovani vincitori di concorso pronti a ereditarne il ruolo, nella secolare consuetudine di tramandare dell’arte generosa e spesso sottovalutata del musicista d’orchestra, il miracolo di un’esecuzione sapientemente concertata e poi rappresentata dal vivo, con celebri direttori o bravi professionisti, ancora si auspica… La vita musicale stessa di tre comunità, insomma, in altri Paesi mediamente più civili protetta dallo Stato – in Germania vengono pubblicamente finanziate 130 orchestre – in Italia invece mutilata in un sol tratto da quel provvedimento anche antropologicamente delittuoso, che sancì simbolicamente la trasformazione della Rai da prima industria culturale italiana a nemmeno prima azienda di prevalente intrattenimento radiotelevisivo.
La produzione musicale classica considerata una zavorra improduttiva e quindi da tagliare con pretestuose ragioni di budget, laddove nella scellerata concorrenza alla tv commerciale purtroppo equiparata a quella pubblica da un decreto, una sola puntata di uno spettacolo di varietà dell’epoca costava quanto un’intera stagione di una delle orchestre. Invocando l’esigenza di ridurre ad ogni costo il personale – anche attraverso trattative «rappresaglia» atte a indurre al prepensionamento con incentivi da capogiro ottimi dirigenti vieppiù privandosene o il più collaudato metodo dello scambio genitore/figlio tra i dipendenti – parallelamente si incrementavano le assunzioni di nuovi giornalisti (oggi sono quasi 1.900) spesso anche bravi e indipendenti, ma in alcuni casi scelti per accrescere la «produzione» di interpretazioni dei fatti, secondo il volere dei partiti politici di riferimento. Nel contempo si iniziavano a esternalizzare gli appalti di interi programmi televisivi, show del sabato o della domenica, fiction e chi più ne ha più ne metta, nei variopinti e cartilaginei palinsesti succedutisi negli ultimi tre decenni, dovendo rinunciare alle ormai smantellate professionalità interne anche sul piano ideativo e di indirizzo artistico.
Una Rai light, dunque, dal cui avvio ebbe buon gioco lo stratega del brutale assassinio culturale, al tempo vicedirettore generale per la radiofonia, col quale ebbi un durissimo scontro al settimo piano di Viale Mazzini, quando in un’agitatissima riunione con i vertici della Rai emerse definitiva l’intenzione di sopprimere l’intera attività musicale della sede napoletana della Rai, attiva dagli anni ’60. Non avrebbero più avuto luogo la Stagione Sinfonica pubblica, il Luglio Musicale a Capodimonte e l’Autunno Musicale dell’Orchestra Alessandro Scarlatti – autentico bene culturale assimilato negli anni ’50 alla città di Napoli e mai più restituito – unitamente alle nuove rassegne Giugno Barocco, Festival Pianistico, ai due storici Concorsi Internazionali della città di Napoli, quello pianistico Alfredo Casella e quello violinistico Alberto Curci, oltre al festival di musica contemporanea «Musical Networks». E soprattutto la fine di prime esecuzioni assolute o nazionali come la Sinfonia Rendering di Luciano Berio da egli stesso diretta come altri compositori, oppure in tempi moderni (i due Oratori di Pergolesi) per non citare gli straordinari debutti di giovani talenti oggi in carriera internazionale, dei quali voglio citare soltanto i pianisti Roberto Cominati, Jean Yves Thibaudet, Benedetto Lupo, i violinisti Leonidas Kavakos e Joshua Bell (in Italia) e molti altri. Tra i direttori d’orchestra Fabio Luisi (La Daunia Felice di Paisiello 28/10/1988) oggi direttore emerito proprio dell’Orchestra della Rai.
All’indomani della riforma del 1975, per le quattro orchestre precedentemente gestite dal compositore Mario Labroca e poi dal grande Francesco Siciliani – della cui stima molto ancora mi onoro – si successero altrettanti direttori artistici del calibro di Roman Vlad, Giorgio Pestelli, Luciano Chailly, Enzo Restagno a Torino; Mario Messinis e Giorgio Vidusso a Milano; Gianluigi Gelmetti, Gabriele Ferro e Gioacchino Lanza Tomasi a Roma, Mario Bortolotto e il sottoscritto Massimo Fargnoli a Napoli (Dizionario Utet). Al netto delle rispettive specificità di programmazione che trovavano un’efficacissima sintesi nei palinsesti televisivi della Raitre diretta da Angelo Guglielmi – con il capostruttura Giovanni Tantillo e la responsabile per la musica classica Lucia De Laurentis – le conseguenze della chiusura delle Orchestre della Rai sulla vita musicale di Milano e Roma, attesa la presenza della Filarmonica della Scala e dell’Orchestra Verdi nel primo caso e dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia e della nascente Orchestra Regionale del Lazio nel secondo, non furono devastanti come apparvero invece subito quelle di Napoli e anche della Campania, ancora oggi dopo trent’anni senza un’Orchestra stabile, caso unico in Europa per un’area metropolitana di tre milioni di abitanti in una regione altrettanto densamente popolata.
Ricordo e forse conservo ancora la bozza di un documento della direzione generale al tempo di Biagio Agnes – che nonostante le furiose pressioni dei «cospiratori», riuscì a mantenere la schiena dritta e lo status quo delle quattro Orchestre – nel quale si ipotizzavano come extrema ratio almeno due sedi, quella di Torino, che avrebbe accorpato l’orchestra milanese e quella di Napoli che avrebbe assorbito quella romana, proprio in virtù della mancanza in queste due città di un consistente presidio orchestrale. L’ultima epoca in cui i grandi dirigenti ragionavano, non commettevano atti d’imperio, con la complicità talvolta codarda dei partiti.
Proprio ciò che avvenne nel 1992, approfittando della caccia alle streghe generato dalla cosiddetta tangentopoli che faceva d’ogni erba un fascio nel picconare la classe politica dominante, purtroppo maggioritaria in Campania, il cui presidente dell’epoca fu deriso dal famigerato vicedirettore generale, per aver osato difendere la vita stessa dell’Orchestra Scarlatti, trovando invece una sponda formidabile nella ex Sede regionale Rai per la Campania, ormai derubricata dalla cosiddetta Rai «dei professori» a un meramente esecutivo Centro di produzione, il quale prendeva disposizioni da Roma e pur di far sopravviverne legittimamente le maestranze – impiegabili peraltro in altri enormi spazi di cui è dotato – non vedeva l’ora di appropriarsi dell’Auditorium per farcirlo di un pubblico più adatto alle produzioni televisive di intrattenimento lezioso, fino alla comicità guittesca dell’avanspettacolo attuale.
Novum Organum
Pars construens. Come non evocare l’opera filosofica dalla quale si dipana l’assunto metodologico delle due Pars per introdurre questa seconda, centrata sulla riconquista civile di un bene culturale monumentale? Infatti è proprio anche simbolicamente un Novum Organum – col suo autore Francis Bacon che ha la stessa radice nel cognome del più grande compositore di musica organistica di tutti i tempi J. S. Bach – che vorremmo rinascesse dalle ceneri musicali dell’Auditorium Domenico Scarlatti della Rai di Napoli, come esempio nazionale di contrappeso culturale ai modelli imperanti di una «musicheria» tribale, svuotata di ogni archetipo linguistico ed espressivo.
Inaugurato nel 1963 dal pianista Arturo Benedetti Michelangeli e dall’organista Ferdinando Germani con l’Orchestra Alessandro Scarlatti diretta da Franco Caracciolo alla presenza del presidente della Repubblica Segni, esso fu intitolato nel 1985 dall’allora direttore Giulio Patrizi, anche dietro mio suggerimento, all’immenso Domenico Scarlatti, figlio di Alessandro, nel trecentesimo anniversario della nascita.
Centro di ogni genere di energia musicale, insieme alle stagioni sinfoniche pubbliche dell’Orchestra Scarlatti e alle altre numerose manifestazioni sopra citate, aveva ospitato anche la migliore produzione televisiva di musica leggera negli anni ’60 e ’70 con Senza Rete – Mina, Battisti e tutti i big – , il Festival Internazionale «Nuova Musica e oltre» e nell’ampio foyer alcune pregevoli mostre celebrative, come quella per i 50 anni della radio. Io stesso vi organizzai quella su Stradivari nel 250° della nascita (esponendo l’unica piccola arpa costruita dal liutaio cremonese), la Mostra sulla Costruzione del Pianoforte, in collaborazione con la Steinway&Sons di Amburgo, quella su Giovanni Paisiello, in collaborazione col Museo Teatrale della Scala, e buon ultima TerraeMotus, riallestita personalmente da Lucio Amelio, esponendo per alcuni anni il prezioso pianoforte Erard appartenuto a Sigismund Thalberg e la «Tastiera sensitiva controllo multiplo» che il mitico Robert Moog venne espressamente dall’America a presentare. Un luogo magico che sarebbe stato poi definitivamente sconsacrato alla grande musica per realizzarvi per lo più programmi d’intrattenimento comico e di avanspettacolo.
Laddove, seppellito tra scenografie, cavi e telecamere, ancora giace – silente da trentuno anni e forse ormai in rovina – uno tra i più imponenti organi laici d’Europa, con i suoi cinque manuali e novemila canne «… che in quel triste autunno 1993 feci appena in tempo a far risuonare per l’ultima volta attraverso le prodigiose mani di Daniel Chorzempa, al quale espressamente chiesi di eseguire come bis la “Toccata” di Charles Marie Vidor, particolarmente adatta a esprimerne tutte le maestose potenzialità sonore e infatti l’intera sala iniziò a vibrare spaventosamente, come stesse divenendo l’epicentro di un apocalittico terremoto che sul piano sociale, morale, culturale e ambientale la città di Napoli avrebbe amaramente conosciuto negli anni a venire…» (come ho scritto in Pergolennon o l’Arte della Sincronicità, Zecchini Editori 2019).
Per l’eventuale ri/inaugurazione di questo gioiello ho già mobilitato i miei amici, tra i più celebri organisti del mondo, da Cameron Carpenter in giù, raccontando loro l’assurdità di questa vicenda che vede «sequestrare» alla comunità un bene culturale pubblico e alcuni di loro si sono dichiarati pronti a incatenarsi simbolicamente ai cancelli di Viale Marconi per reclamare la restituzione di questo incredibile strumento, tuttora simbolo di modernità e di progresso, nonostante siano trascorsi sessant’anni dalla sua costruzione.
Attenzione, la restituzione di un Auditorium e di un Organo alla collettività non è un’emergenza culturale solo napoletana: alla stregua dell’istruzione, o della sanità, la musica d’arte deve essere considerata un pilastro culturale in tutte le aree del Paese – ma soprattutto al Sud per ovvie carenze endemiche – sottraendola al lenocinio feudale o assessorile di chi dispensa contributi pubblici nella speranza di incassare un ritorno elettorale, senza alcuna politica prospettica e strutturale. Risorse pubbliche che evaporano nella distribuzione di eventi effimeri, senza investire un euro sul futuro delle nuove generazioni. Una riforma legislativa dell’intero sistema, che istituisca un’orchestra professionale in ogni Comune al di sopra di cinquantamila abitanti, pianificando e armonizzando ogni intervento con tutti i possibili attori a cascata, dovrebbe costituire il primo atto di questa vera e propria rivoluzione culturale.
Tanta occupazione artistica, per garantire l’ormai incerta sopravvivenza in Italia della musica classica scongiurandone l’irreversibile svilimento, in connessione vitale con le scuole – nei primi anni e durante tutto l’iter formativo – con tutti i possibili indotti che passano attraverso altre professionalità di supporto logistico, gestionale e amministrativo, formando specialisti del terzo settore, ma anche manager più spinti verso l’attrazione di sponsor creando reti nazionali di interscambio.
Sul piano sociologico le ricadute sarebbero innumerevoli: dal miglioramento delle espressioni comunicative, ingentilite dapprima dalla conoscenza di un repertorio musicale armonioso nell’infanzia e poi dallo studio di uno strumento nell’adolescenza, stati d’animo creativi che incrementano la positività delle relazioni sociali e di riflesso il buon andamento dei meccanismi produttivi, a tutti i livelli, poiché quasi ogni famiglia avrebbe al suo interno un figlio o una figlia che vi si dedica, relazionandosi all’esterno in una virtuosa progressione «neuronale» e rafforzando il senso di appartenenza a una struttura sociale circoscritta. Senza scomodare Rudolf Steiner ma l’applicazione costante a una disciplina, appena incoraggiata nell’infanzia, produce esiti che la mia antica esperienza di insegnante mi rivelò miracolosi. Non costruiremo delle «città del sole» ma almeno cercheremo di contenere il degrado rivoltante delle nostre periferie, grandi e piccole, dominate dalla cronaca nerissima, peraltro opportunamente rilanciata dai media come merce tanto lucrosa per l’audience – nel torbidume dei telegiornali e delle compiaciute trasmissioni criminologiche – quanto sub liminalmente gravida di istinti emulativi.
Ciò vale per tutta l’Italia, ma in special modo nella contraddittoria immagine internazionale della città metropolitana di Napoli, turistica e criminogena, l’istituzione di un’orchestra professionale stabile, con tutte le garanzie sindacali e di livello almeno nazionale sul piano qualitativo insieme a quelle delle altre province della regione, in un potente sistema musicale interconnesso, potrebbe costituire forse il big bang iniziale per arginare la criminalità dilagante, anche nei comportamenti individuale – proprio un giovanissimo cornista ne fu tristemente vittima lo scorso anno – offrendo passioni alternative a quelle «gomorroidi», che proprio una certa romanzeria incoraggia attraverso fiction televisive, con immancabili commissari/e, questurini, carcerati e piccoli delinquenti «emotivi», tanto per vellicare le pulsioni più retrive del subconscio partenopeo, secondo un oscuro «piano di rinascita comunale» della città attraverso le sue interiora, piuttosto che la sua interiorità.