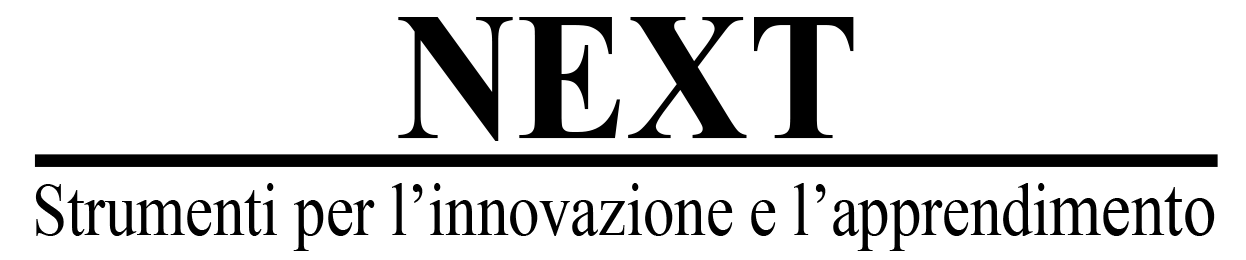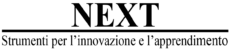Intervento di Natale Forlani al Workshop di Capri (15-16-17 maggio 2025)
Devo dire che esco da queste giornate molto confortato, soprattutto dalla qualità e dalla profondità delle restituzioni emerse dai gruppi di lavoro. Mi sembra evidente che ci siano tutte le premesse per compiere un vero salto di qualità nell’approccio condiviso alle politiche attive del lavoro e alla formazione. Un salto che nasce da una percezione comune, finalmente matura, circa l’urgenza di superare modelli frammentati e statici, per costruire insieme un sistema realmente convergente.
Ciò che emerge chiaramente è una crescente consapevolezza: non possiamo più limitarci a sommare interventi, ma dobbiamo integrarli. E questo vale per le istituzioni pubbliche, per i fondi interprofessionali, per le Regioni, per il mondo produttivo. Il Net Forum, in questo senso, si conferma non solo come un luogo di confronto, ma come un vero e proprio laboratorio di co-progettazione sistemica.
Ma, con altrettanta franchezza, dobbiamo dirci che così non si può andare avanti. L’attuale assetto, frutto di una stratificazione di storie e approcci – talvolta giustificati, talvolta meno – ha ormai esaurito la sua spinta propulsiva. Anch’io, personalmente, ho attraversato questi processi fin dagli anni Duemila, e porto con me un marcatore profondo: l’esperienza del Libro Bianco di Marco Biagi.
Una vicenda che mi ha toccato non solo professionalmente ma anche umanamente, per la perdita tragica di un amico e di un’intelligenza rara. Biagi era un giuslavorista atipico, un economista del lavoro capace di ribaltare l’approccio tradizionale tra struttura e sovrastruttura. La sua visione anticipava molte delle convergenze di cui oggi discutiamo: la necessità di costruire sistemi adattivi, capaci di dialogare con il cambiamento senza subirlo, e di fondare l’azione pubblica non su vincoli ideologici ma sull’analisi dei bisogni reali e sull’innovazione istituzionale.
Il metodo di Biagi ci insegna una lezione ancora oggi attualissima: prima di normare, bisogna comprendere. Occorre cooperare, osservare, studiare i fenomeni nella loro complessità e solo dopo elaborare le norme. E non basta scrivere buone leggi: serve verificarne l’efficacia in base ai risultati prodotti. Come? Attraverso il confronto, il metodo comparativo, osservando chi ha raggiunto certi obiettivi e comprendendo perché e come ci è riuscito. È questo approccio basato sulle evidenze che dovrebbe guidare le politiche pubbliche, anche – e soprattutto – nel campo del lavoro e della formazione.
Quella proposta da Marco Biagi fu una vera rivoluzione culturale rispetto all’approccio tradizionale italiano. In Italia, infatti, il baricentro è sempre stato il rapporto di lavoro in senso stretto, e l’intervento normativo ha rappresentato la leva principale per affrontare qualsiasi problema. Io stesso, come giuslavorista, ho partecipato attivamente a questa stagione normativa – ho scritto norme, sono stato parte di quella “squadra di giuristi” che credeva che la legge potesse risolvere tutto. Era un approccio basato su un principio quasi militare: si fa la norma e l’intendenza si adegua. Ma oggi sappiamo che non basta.
Vedete, in quel mondo – che potremmo definire “il mondo di prima” – tutto si muoveva con una certa lentezza. L’innovazione era lineare, prevedibile: le novità si succedevano una dopo l’altra, ed erano per lo più implementabili all’interno dei sistemi esistenti. Le professioni erano stabili, codificate: ricordo che, quando si entrava nel mercato del lavoro, c’erano 17-18 profili professionali di riferimento, strettamente connessi ai percorsi scolastici. Il lavoro era visto come un percorso valoriale, da intraprendere con serietà, da costruire e conquistare con il tempo. Era un modello in cui identità professionale e crescita personale coincidevano.
Tutto quel mondo ha generato una rivoluzione nel sistema dei diritti, che si fondava su un principio chiaro e lineare: “ho fatto il mio dovere, ora ho diritto a qualcosa in cambio.” Era una visione coerente con la storia sociale e civile del nostro Paese, una storia bellissima, fondata sull’idea di un patto generazionale e di uno scambio tra impegno e riconoscimento.
Ma questa visione si è andata progressivamente frantumando. Le grandi fratture prodotte dall’apertura dei mercati globali prima, e poi dall’irrompere di Internet e delle tecnologie digitali, hanno scardinato quel modello. E queste fratture non hanno riguardato solo l’economia, ma hanno inciso profondamente anche sui processi educativi, sui percorsi formativi e, naturalmente, su quelli lavorativi. Le traiettorie si sono fatte disordinate, frammentate, non più lineari. E il vecchio patto si è incrinato.
L’Italia ha un “buco alle spalle”, un vuoto strutturale e culturale che si riflette in molteplici ambiti: nella percezione del lavoro, nel senso dei diritti e dei doveri, nel modo in cui si sta nel mercato del lavoro e, soprattutto, nella capacità di capitalizzare i processi formativi. Questo deficit storico ha inciso profondamente sul modo in cui il nostro Paese ha affrontato — e affronta — la trasformazione del lavoro.
Va riconosciuto, però, che l’Italia ha saputo valorizzare, soprattutto in passato, anche i percorsi informali. L’informalità, spesso vista come una debolezza, è stata in realtà una leva fondamentale: ha avuto un ruolo enorme nel mercato del lavoro e nella costruzione di competenze reali. Proprio da lì, da esperienze pratiche e non formalizzate, è emersa una parte consistente della nostra classe dirigente. È su questa tradizione che dobbiamo riflettere oggi, per connettere l’apprendimento formale con quello esperienziale e ripensare un modello integrato, capace di leggere i bisogni reali del lavoro e della società.
Io stesso ne sono un esempio vivente: sono partito come carpentiere saldatore, poi progettista, studiando la sera e il sabato. Ho costruito il mio percorso professionale lavorando e frequentando l’università, valorizzando i crediti acquisiti sul campo. Ma non sono un’eccezione: quello era un modo comune, quasi naturale, di vivere la crescita personale e professionale. Era un tempo in cui si passava dall’esperienza alla formalizzazione, dal lavoro allo studio, in un percorso fluido e riconosciuto socialmente.
Oggi, però, siamo davanti a fratture di diversa natura. E il vero problema è che negli anni ’90 non siamo riusciti a ricostruire un sistema educativo e formativo capace di guidare le persone verso il lavoro in una società in trasformazione. Questo è il vuoto che ci portiamo dietro: un’interruzione nel collegamento tra formazione, esperienza e occupazione, proprio nel momento in cui avremmo dovuto rilanciare un modello flessibile, continuo e inclusivo. Un buco che oggi, con l’avvento delle nuove tecnologie e delle trasformazioni globali, dobbiamo colmare con urgenza e visione sistemica.
Attenzione: non si tratta di dire “torniamo a quel modello”, non è più possibile, né auspicabile. Quel percorso lineare che per decenni ha strutturato il rapporto tra teoria e pratica — con una gerarchia prestabilita in cui l’innovazione nasceva nei centri del sapere per poi calarsi nei contesti operativi — non esiste più.
Il futuro dell’innovazione
Oggi ci troviamo nel pieno di un cambiamento radicale del paradigma: l’innovazione non nasce più necessariamente nei luoghi della riflessione teorica, ma si origina spesso nei contesti produttivi, sociali, tecnologici e territoriali. Si è verificata una sorta di “inversione copernicana”: l’innovazione è diventata diffusa, distribuita, ibrida, e non raramente arriva prima dalla prassi che dalla teoria.
Giorgio Ruffolo, già nei decenni scorsi, aveva colto questa dinamica, parlando di una progressiva esternalizzazione dei processi di innovazione, che sfuggivano alla regia tradizionale dei centri di ricerca per manifestarsi nei luoghi più imprevisti della società e dell’economia. Questo ribaltamento rende inadeguato ogni approccio che voglia mantenere compartimentato il sapere teorico da quello pratico: oggi servono interazioni continue, dispositivi di convergenza, contaminazioni tra luoghi, linguaggi e funzioni.
Ecco perché dobbiamo abbandonare la nostalgia per modelli passati e concentrarci invece sulla costruzione di un nuovo ecosistema educativo e professionale, capace di valorizzare l’apprendimento in ogni sua forma e di accompagnare persone e territori in una trasformazione che non è episodica, ma sistemica.
Stiamo parlando degli anni in cui la programmazione economica divenne uno strumento centrale dell’azione del centrosinistra, un periodo in cui si tentò di coniugare lo sviluppo con l’equità, e in particolare di correggere gli squilibri territoriali del paese. In quel contesto, il centrosinistra fece un’autocritica importante: riconobbe che la programmazione, intesa solo come allocazione razionale degli investimenti pubblici, non era sufficiente. Serviva qualcosa di più: un’azione politica e culturale capace di tenere insieme indirizzo, visione e coesione sociale.
In questo orizzonte si inserisce la riflessione di Giorgio Ruffolo, economista socialista di grandissima statura, più volte ministro e figura centrale del dibattito pubblico tra anni ’60 e ’90. Ruffolo non fu solo un tecnico o un intellettuale, ma un pensatore sistemico. Una delle sue elaborazioni più profonde fu proprio quella sul rapporto tra potere e potenza.
Per Ruffolo, la “potenza” è la capacità di agire, di trasformare, di generare effetti reali; il “potere” è invece l’autorità legittimata a decidere. Nelle fasi di crescita economica e di progresso tecnico, accade spesso che la potenza — cioè la capacità di modificare il reale — si sposti fuori dalle istituzioni, verso luoghi meno regolati, come il mercato, le multinazionali, o le tecnologie. Questo crea una frattura, un’incoerenza tra chi detiene il potere e chi esercita la potenza. Il rischio? Che la politica perda il controllo degli strumenti del cambiamento, e quindi la capacità di orientarlo in modo democratico.
Questa riflessione è oggi più attuale che mai. La sfida dell’intelligenza artificiale, della transizione ecologica, della globalizzazione dei mercati e dei saperi, ci pone esattamente davanti alla stessa tensione: la potenza dell’innovazione sta correndo più veloce del potere delle istituzioni. E allora, per evitare che la società venga travolta, serve ritrovare un equilibrio. Non tornando a vecchie formule, ma costruendo nuove convergenze, nuovi dispositivi di governo condiviso, nuove architetture istituzionali capaci di orientare la trasformazione.
La distinzione di Giorgio Ruffolo tra potenza e potere è fondamentale per comprendere le tensioni strutturali che viviamo oggi.
La potenza è ciò che muove il mondo: è l’insieme delle forze vive che generano cambiamento — l’innovazione tecnologica, la spinta dei mercati, le scoperte scientifiche, i comportamenti collettivi, le grandi transizioni economiche, energetiche, digitali. È una forza spesso caotica, non sempre prevedibile, che nasce da molteplici attori, dal basso e dall’alto, e che procede con un’intensità propria.
Il potere, invece, è la capacità delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni collettive, delle politiche, di regolare quel cambiamento, cioè di incanalarlo, orientarlo, metterlo al servizio del bene comune. Il potere non è il freno, ma la regia. Il suo compito è fare in modo che la potenza non sfoci in squilibri ingestibili, che non aumenti le disuguaglianze, che non lasci indietro territori o persone.
Questa dicotomia è oggi particolarmente evidente. La potenza dell’intelligenza artificiale, della trasformazione dei lavori, della globalizzazione digitale è sotto gli occhi di tutti. Ma il potere – inteso come governo democratico della transizione – spesso arriva in ritardo, o si frammenta, o si limita a rincorrere.
Ed è qui che entra in gioco il concetto di convergenza, su cui il Net Forum ha posto così tanta attenzione: convergenza tra politiche, tra istituzioni, tra pubblico e privato, tra territori e centro, per costruire dispositivi agili, intelligenti, condivisi, capaci di governare la potenza trasformativa del nostro tempo. Per evitare che l’innovazione produca solo vincenti e perdenti, e invece generi valore inclusivo, partecipazione, coesione. In queste giornate capresi attori diversi — pubblici, privati, sociali — hanno potuto interrogarsi non solo su “come fare”, ma su dove vogliamo andare.
In definitiva: la potenza senza potere genera caos. Il potere senza potenza diventa irrilevante. Solo insieme possono produrre un cambiamento giusto e sostenibile.
Ed è proprio da questa intuizione di Giorgio Ruffolo — la sproporzione crescente tra potenza (cioè la forza autonoma dei cambiamenti economici, tecnologici, sociali) e potere (cioè la capacità istituzionale di governarli in modo equo) — che nasce l’esigenza di ripensare profondamente i modelli di governance.
Nel modello precedente — quello della programmazione economica classica — il sistema si reggeva su due pilastri:
- la produzione della ricchezza, affidata all’impresa e alla dinamica economica;
- la redistribuzione della ricchezza, affidata alle istituzioni pubbliche e ai sistemi di welfare.
Era un equilibrio fragile, ma funzionante, perché i tempi dell’economia e della politica erano ancora compatibili. Oggi non è più così.
La potenza del cambiamento — pensiamo alla transizione digitale, all’intelligenza artificiale, alla globalizzazione dei mercati del lavoro — procede troppo velocemente rispetto alla capacità di reazione dei modelli tradizionali di regolazione e redistribuzione. Questo squilibrio produce nuove disuguaglianze, esclusioni, e una diffusa perdita di fiducia nelle istituzioni.
Ecco perché Ruffolo suggeriva già decenni fa che non bastano più modelli verticali, burocratici, autoreferenziali: serve coinvolgimento, condivisione, governance cooperativa.
Questo ci riporta al cuore del Net Forum: costruire soluzioni insieme, in una logica funzionale e partecipativa. Condividere informazioni per costruire una base comune di analisi (ad es. sui fabbisogni, le competenze, le transizioni). Coinvolgere gli attori, non solo nel recepire le politiche, ma nel progettarle insieme: regioni, fondi interprofessionali, imprese, enti formativi, terzo settore.
È questo il passaggio cruciale che oggi serve per ricucire il rapporto tra potenza e potere, tra cambiamento e giustizia sociale. Solo una governance multilivello e co-progettata può rendere efficace e legittima l’azione pubblica in un mondo che cambia così rapidamente.
Ed è anche ciò che distingue il lavoro fatto in questi giorni: non un semplice luogo di confronto, ma una piattaforma operativa di convergenza, dove si esercita quel “potere partecipato” di cui parlava Ruffolo.
Negli anni ’70 e ’80, il modello di governance partecipativa delineato da studiosi come Giorgio Ruffolo era ancora compatibile con i tempi dell’economia e della politica. Ma oggi, con l’irrompere dell’Internet e della finanziarizzazione estrema dell’economia, quella stessa teoria deve fare i conti con fratture di scala e di velocità che mettono in crisi ogni possibilità di regolazione tradizionale.
Oggi assistiamo a tre velocità diverse che raramente si allineano:
- la velocità della finanza, che è istantanea. In pochi clic si possono spostare miliardi di euro, investire, disinvestire, manipolare mercati. L’esempio della borsa che precipita e poi risale nel giro di ore per un tweet o una decisione geopolitica — come nel caso di Trump — è emblematico. Dietro questi movimenti rapidissimi ci sono sempre interessi che vincono e interessi che perdono, spesso in modo asimmetrico;
- la velocità dell’innovazione tecnologica, che sebbene non sia immediata come la finanza, è comunque accelerata rispetto ai tempi della formazione e della cultura. Le tecnologie si impongono prima che la società abbia il tempo di capirle, regolamentarle o adattarsi;
- la velocità delle persone, che è la più lenta. Per riqualificarsi, per riconoscere i propri diritti e doveri in un mercato del lavoro mutato, per rientrare nei circuiti produttivi e sociali, ci vuole tempo, accompagnamento, investimento educativo e formativo.
Questa disconnessione delle velocità è oggi una delle principali sfide del nostro tempo.
Ed è qui che torna in gioco il senso più profondo del lavoro che abbiamo svolto un questo workshop: Come costruire strategie di convergenza che ricompongano queste fratture? Come dotarsi di strumenti di governance adattiva, capaci di restituire coerenza, equità e direzione all’interno di un sistema che sembra premiare solo i più veloci?
La risposta non può venire da un unico centro, né da una sola categoria di attori. Serve un sistema informativo condiviso, capace di leggere i trend reali (non solo i dati ex post); una formazione continua e certificabile, per dare alle persone la possibilità concreta di “tenere il passo”; una governance multilivello e intersettoriale, dove pubblico e privato non si guardano da lontano, ma agiscono insieme con regole condivise e obiettivi comuni.
Solo così possiamo restituire potere regolativo alla società, riportando in equilibrio ciò che oggi la finanza e l’algoritmo rischiano di spostare troppo velocemente e unilateralmente.
Quando capitano queste operazioni – come ad esempio le manipolazioni finanziarie rapidissime, le fluttuazioni di borsa innescate da scelte politiche o tecnologiche – i capitali si muovono a una velocità infinitamente superiore rispetto a quella con cui le persone possono reagire o adattarsi.
Ed è proprio qui che si innesta la novità dirompente dell’intelligenza artificiale. L’IA non fa che moltiplicare questa asimmetria, perché accelera i processi decisionali, automatizza le scelte, riduce (o addirittura annulla) i tempi di risposta, rendendo ancora più distante la capacità del sistema umano – fatto di formazione, educazione, consapevolezza – di tenere il passo.
Un nuovo modello di governance
L’intelligenza artificiale scardina la linearità con cui, in passato, l’innovazione tecnologica si innestava nel ciclo economico e sociale: prima si produceva l’innovazione, poi la si trasferiva lentamente nel lavoro, infine, si costruiva un sistema normativo e formativo per accompagnarla.
Oggi, quella sequenza è saltata. L’innovazione non chiede più il permesso: irrompe, trasforma, disintermedia, spesso disarticola. E a cascata produce effetti su occupazione, competenze, diritti.
Per questo è urgente un nuovo modello di governance e di convergenza che sappia leggere i segnali deboli prima che diventino crisi; che permetta alle persone di orientarsi nei nuovi contesti prima che ne siano espulse; che promuova una formazione intelligente, continua, certificabile, vicina al lavoro reale e non al lavoro ideale.
Il metodo utilizzato in questo workshop sta cercando di disegnare proprio questo spazio di convergenza: dove la velocità della tecnologia non lasci indietro la dignità del lavoro. Dove la trasformazione digitale sia accompagnata da una trasformazione sociale e culturale altrettanto forte. Dove, in fondo, potenza e potere non siano più distanti, ma possano ricomporsi in una nuova alleanza tra sviluppo e coesione.
La potenza – intesa come capacità di innovazione, velocità di trasformazione, forza dei mercati e delle tecnologie – ha raggiunto oggi un livello superiore persino a quello che abbiamo conosciuto durante la fase espansiva della globalizzazione.
Questa sproporzione crescente tra “potenza” e “potere” – ovvero la capacità degli Stati, delle istituzioni, delle comunità di governare e indirizzare questi fenomeni – ha generato un aumento dei tassi di incertezza. Ed è questa incertezza, pervasiva, che oggi troviamo nei volti e nelle domande dei nostri giovani.
Quando un ragazzo ti chiede: “Cosa devo fare nella vita?”, è difficile dare una risposta. Perché anche noi – dirigenti, studiosi, policy makers – ci troviamo di fronte a scenari che mutano troppo rapidamente per offrire percorsi lineari e prevedibili.
Massimo Temussi, nel suo intervento, ha parlato di tassi di cambiamento che sfidano i modelli precedenti. E ha ragione: ciò che vediamo oggi è che questa frattura sta portando a un ripensamento profondo del ruolo degli Stati nazionali e dei modelli di governance.
Le tecnocrazie globali, che per decenni hanno dominato lo scenario, stanno arretrando. E persino i grandi modelli di corporate governance sovranazionale – da Colmar ai fondi Pictet – sono sempre più messi in discussione. Non tanto perché sbagliati in sé, ma perché non si sono radicati nei bisogni dei territori, nelle istanze locali, nelle identità culturali e sociali delle popolazioni.
Abbiamo inseguito per anni il mantra della delocalizzazione: “Andiamo dove conviene”. Ma a quale prezzo?
Abbiamo trasferito tecnologie, competenze e know-how verso paesi che – come nel caso della Cina – non hanno mai condiviso pienamente l’idea di un’economia integrata, ma hanno costruito con intelligenza e determinazione strategie di internalizzazione e controllo dei saperi.
E così ci siamo ritrovati a dover fronteggiare una nuova geografia del potere industriale e tecnologico, dove le grandi imprese globali sono sempre più “nazionali” nei loro interessi strategici. Dove “vieni a produrre da me, ma i brevetti restano qui, e la tecnologia me la lasci” è diventata prassi.
Il risultato? Una parte dell’Occidente – e l’Italia in particolare – ha perso il controllo su intere filiere produttive, lasciando andare via valore, intelligenza, futuro.
La vera sfida, allora, è ricostruire un modello di governance che sappia tenere insieme potenza e potere.
Che parta dalla consapevolezza che le transizioni – digitali, ecologiche, produttive – non si governano solo con la finanza o con gli algoritmi, ma con istituzioni forti, intelligenti, partecipate.
Con comunità capaci di progettare il proprio futuro, e non di subirlo. E con luoghi di confronto strategico, come questi, in cui questa visione comune possa prendere forma.
Perché la vera sfida del nostro tempo non è solo adattarsi. È immaginare, e costruire, un nuovo equilibrio tra il fare e il governare.
In questo momento siamo immersi in un profondo processo di ridisegno delle architetture di governance, che si stanno ricomponendo intorno a nuovi equilibri tra interessi strategici e identità nazionali. È una dinamica che riguarda tutti i livelli: geopolitico, economico, istituzionale.
Da qui nasce una domanda cruciale: di fronte a questo scenario, come stiamo affrontando il rapporto – sempre più squilibrato – tra produzione e distribuzione della ricchezza? E ancora: dove siamo posizionati oggi, con le nostre politiche attive del lavoro, all’interno di questo nuovo contesto globale?
È la domanda che ho cercato di porre ieri, consapevole che non si tratta di un’intuizione individuale, ma del risultato di un lavoro collettivo, sviluppato e maturato in un percorso di confronto, riflessione, e sintesi.
Mi sono preso la libertà – forse per l’età, essendo tra i più anziani del gruppo – di provare a sistematizzare questo lavoro, facilitandone la lettura. Chi ha scritto la relazione forse avrebbe potuto anche leggerla a voce, ma credo sia importante – ogni tanto – che qualcuno si prenda la responsabilità di mettere nero su bianco, capitalizzare ciò che è emerso, renderlo fruibile anche per chi non era presente.
Solo così possiamo costruire continuità, memoria e orientamento. Ed è ciò che cerco di fare, non tanto per me, quanto perché me lo chiedono quelli che credono nel valore del pensiero condiviso.
Eh sì, inizialmente non pensavo che questo esercizio di scrittura fosse davvero necessario. Ma poi mi è stato detto: “Tu mettila giù, poi vediamo come farla andare avanti”. E hanno avuto ragione. Perché se non partiamo da una presa di coscienza reale, non si va da nessuna parte.
Dove siamo posizionati oggi? Siamo indietro, spaventosamente indietro. Tutti gli indicatori ce lo dicono chiaramente: abbiamo una scarsa percezione dell’interesse nazionale.
I nostri modelli organizzativi, decisionali, politici sono ancora imprigionati in logiche frammentate, nella cultura del “tocca a te, tocca a me”, delle competenze divise, della rincorsa all’autonomia territoriale. L’autonomia differenziata, ad esempio, rischia di rallentarci proprio nel momento in cui il mondo accelera.
Se ci incamminiamo in quella direzione senza un progetto coerente e condiviso, rischiamo di perdere anni preziosi, mentre altri Paesi corrono con una velocità di trasformazione e permeazione che può travolgerci.
Ecco perché oggi abbiamo bisogno di una riflessione spietata: dobbiamo guardare con lucidità dove sono i nostri punti di forza e, soprattutto, dove sono le nostre debolezze. Non è tempo di diplomazie: è tempo di verità, se vogliamo davvero costruire un sistema che regga l’urto del futuro.
No, così non va. Non possiamo accontentarci. Se il rapporto tra scuola e lavoro non funziona, va affrontato con decisione. Perché da lì passa la costruzione della classe dirigente del futuro. Non possiamo permetterci di perderla. E invece la stiamo perdendo.
È vero, da qualche parte miglioriamo: la formazione continua si rafforza, l’apprendistato tiene, ci sono segnali incoraggianti sul Sistema Duale. Ma poi guardi i numeri complessivi, i fenomeni reali, e la verità è che perdiamo molte più competenze di quante ne generiamo. E non sono solo competenze che svaniscono: sono posizionamenti strategici che non riusciamo a conquistare, sono spazi nei mercati, nella tecnologia, nell’innovazione che altri occupano mentre noi stiamo fermi.
Nel frattempo, ci illudiamo che basterà rivolgerci all’intelligenza artificiale per risolvere i problemi. Ma, come ci ha mostrato il Direttore di Sviluppo Lavoro Italia, se chiedi all’IA: “Mi si è rotto il tubo dell’acqua, cosa devo fare?”, l’IA risponde: “Cerca un idraulico.” Cioè: torna alla realtà. L’IA è un supporto, non un sostituto della competenza umana reale. E senza quella, nessuna transizione sarà davvero possibile.
Per l’intelligenza artificiale, la risposta è semplice: “Vai a cercare l’idraulico.” E magari sarà proprio l’idraulico a usare l’IA per fare la diagnosi del guasto, così come oggi il meccanico collega l’auto elettrica alla centralina. Forse l’elettricista installerà sistemi domotici gestiti da algoritmi. Ma se perdiamo l’idraulico, allora sono guai seri. Perché la verità è che non hai dove andare a cercarlo.
Questo è il punto: stiamo perdendo un’intera classe di mestieri, anche tra quelli a medio-alta qualificazione, figure consolidate, fondamentali per la tenuta del sistema produttivo e sociale. E il problema è che non stiamo riuscendo a ricostruire la base: non formiamo abbastanza, non trasmettiamo i saperi, non rendiamo attrattive queste professioni. L’errore è pensare che la transizione digitale e tecnologica potrà sostituire tutto. Invece ci mostra che, senza fondamenta, la trasformazione si sbriciola.
Ecco cosa abbiamo cercato di dire, anche nei nostri documenti e analisi: non è solo un problema quantitativo, è un problema strutturale. Se non ripartiamo dai mestieri, dai percorsi di ingresso, dalle motivazioni, dalle filiere formative, perdiamo il contatto con la realtà concreta del lavoro. E con esso, perdiamo anche la capacità di innovare.
Abbiamo dei punti di forza che spesso sottovalutiamo, e uno dei principali è il nostro umanesimo. Le facoltà umanistiche italiane possiedono un patrimonio unico, che non ha eguali altrove. Ed è proprio da lì che possiamo ripartire per ricostruire il legame profondo tra coscienza, scienza, tecnologia e innovazione sociale.
Più l’intelligenza artificiale assorbirà capacità di calcolo, risoluzione e automazione, più diventeranno cruciali le capacità tipicamente umane: discernimento, creatività, sensibilità emotiva e capacità di relazione. Questo è il punto cruciale: il valore della persona nel sistema lavoro del futuro non sarà nei compiti sostituibili, ma in quelli insostituibili.
Da qui discende una considerazione strategica: l’orientamento assume una funzione decisiva in una società in trasformazione. Non può più essere inteso come una funzione accessoria, ma come strumento cardine per aiutare le persone a collocarsi nella complessità, nelle transizioni occupazionali e identitarie.
Parallelamente, dobbiamo correggere la governance delle politiche attive così come l’abbiamo ereditata. Perché la loro funzione non è solo quella dell’intermediazione o dell’assistenza, ma di rimediare alle asimmetrie tra produzione culturale, formazione, tecnologie e organizzazione del lavoro. Queste politiche devono diventare leve di riconnessione tra sistema educativo e realtà produttiva, tra territorio e reti nazionali, tra le aspirazioni individuali e le traiettorie occupazionali possibili.
E allora — diciamolo con franchezza — se ci limitiamo ai classici tavoli di coordinamento Stato-Regioni-Ministero, dove ci ritroviamo quattro funzionari (compreso il sottoscritto) a cercare di rattoppare servizi non erogati dieci anni fa, a rimettere in pista utenti di cui si sono perse le tracce, a incanalare corsi decisi altrove senza analisi di impatto… allora non funziona più. Perché poi i dati delle comunicazioni obbligatorie ci dicono che molti di quelli che trovano lavoro lo avrebbero trovato comunque, anche senza i programmi. E questo dimostra quanto sia ancora debole la nostra capacità di incrociare il bisogno con l’offerta, l’informazione con l’azione, l’individuo con un progetto di vita e lavoro sostenibile.
Ma abbiamo gli strumenti, le intelligenze e la cultura per fare un salto di qualità. A patto di avere il coraggio di riconoscere i limiti dell’attuale modello e lavorare con determinazione sulla convergenza tra umanesimo, innovazione e governance efficace.
L’informale ha un suo compito. L’informale, inteso come insieme di apprendimenti e competenze che si maturano fuori dai circuiti strutturati, ha rappresentato per molto tempo una risorsa importante per il sistema lavoro italiano. Ma l’informale vive delle fratture: vive di ciò che il sistema non riesce a trattenere e trasformare. Il punto è che, se non siamo in grado di riprodurre le esperienze virtuose su una scala più ampia e sistemica, rischiamo che anche ciò che ha funzionato si esaurisca.
Non possiamo, ad esempio, riprodurre il modello GOL semplicemente aumentando i volumi, come se potessimo risolvere tutto incrementando la quantità di pellicole fotografiche in un’epoca in cui si scatta con lo smartphone. È inutile cambiare il processo se è il prodotto a essere superato. Dobbiamo invece lavorare su una nuova coerenza tra prodotto e processo, tra finalità e strumenti.
Questo ci porta a una riflessione sul nostro ruolo come istituzioni — Ministero, Regioni, enti attuatori — e sull’urgenza di costruire un sistema di trattamento e condivisione delle informazioni realmente interoperabile. Non basta raccogliere informazioni, serve una circolazione condivisa delle informazioni tra soggetti funzionali, cioè tra chi partecipa davvero al processo: chi subisce l’impatto dell’innovazione, chi deve adeguarsi, chi può contribuire a informare il sistema dall’interno.
Non si tratta più di un’informazione verticale che parte dal centro e cala sui territori, ma di un’informazione circolare e integrata. E allora la vera domanda è: chi sono i soggetti funzionali? I servizi per l’impiego, ad esempio, non possono più limitarsi a essere semplici osservatori o gestori di procedure. Devono diventare parte di una rete viva di scambio, in connessione con imprese, fondi, enti formativi e istituzioni. Devono essere messi in condizione di attivare circuiti virtuosi di informazione e azione. Il primo passo è creare questa rete. E un’opportunità concreta, come già discusso, è il Fascicolo del lavoratore, che può rappresentare il cambio di scala necessario. Allo stesso modo, valorizzare sistematicamente la formazione aziendale significa costruire un’infrastruttura informativa e strategica più avanzata.
Solo così potremo passare da un sistema frammentato a un ecosistema coerente, dove conoscenza e decisione camminano insieme. E dove, finalmente, l’innovazione è guidata, orientata e condivisa.
Abbiamo finalmente compreso — insieme — che non si può più andare avanti così, con un sistema frammentato, lento, inefficace nel rispondere ai cambiamenti. E questa presa di coscienza non è affatto poca cosa. Solo un anno fa, quando cominciammo a discutere della valorizzazione della formazione aziendale e della possibilità che i fondi interprofessionali potessero contribuire direttamente alla certificazione delle competenze, la proposta venne bocciata in Conferenza Stato-Regioni. Non c’era la visione condivisa che oggi comincia a emergere.
Abbiamo dovuto lavorare in profondità. Dobbiamo ringraziare persone come Paolo Mora, Simone Cappelli e altri che, con lucidità e coraggio, hanno compreso che qualcosa non stava funzionando e che occorreva cambiare approccio. E oggi, proprio per questo, non possiamo permetterci di disperdere il patrimonio di conoscenza e collaborazione che abbiamo faticosamente costruito. È il momento di consolidare: costruire un’idea forte e operativa di cooperazione, perché — è bene dirlo — non siamo stati fermi. Anzi. Abbiamo avviato un lavoro importante di semina e rigenerazione del sistema: le certificazioni delle competenze, il ripensamento dei Fondi Nuove Competenze, l’analisi dei dispositivi di tirocinio e apprendistato per adeguarli ai bisogni reali, la revisione dell’Atlante del Lavoro come strumento di interoperabilità e linguaggio condiviso, l’evoluzione dei modelli informativi per rendere le decisioni più fondate, tempestive, condivise.
Tutto questo è già una nuova infrastruttura culturale e operativa che stiamo costruendo. Adesso tocca a noi farla funzionare insieme, perché non è più tempo di tentativi isolati, ma di alleanze strutturate, interoperabilità e responsabilità condivise. Abbiamo tanti tasselli, ma manca ancora il disegno complessivo. Abbiamo tante azioni corrette, tanti strumenti validi, ma se non li inseriamo in un processo coerente, rischiano di non produrre il risultato atteso. È questo il nodo cruciale: passare da un insieme di buone pratiche frammentate a un puzzle compiuto, capace di restituirci una visione di sistema. Per questo si impone oggi l’urgenza di elaborare un’ipotesi di governance integrata e di misure coordinate, che siano in grado di affrontare le due grandi sfide del presente:
- rendere gestibili le transizioni lavorative, sempre più frequenti, rapide e profonde;
- rigenerare la popolazione attiva, in un contesto in cui assistiamo a una drastica perdita demografica e all’emersione di colli di bottiglia anche in segmenti del mercato del lavoro teoricamente più stabili.
Oggi, anche i segnali positivi rischiano di rimanere parziali se non inseriti in una visione integrata: il contratto a tempo indeterminato resiste, la componente senior della forza lavoro è ancora presente e attiva, ma la fascia più giovane fatica a entrare, e quella matura sta per uscire, con un effetto domino che è strutturale e ambientale, non congiunturale.
Serve allora un nuovo sistema coerente, che leghi politiche attive, formazione, orientamento, certificazione, inclusione, innovazione e sostegno alla natalità e all’occupabilità. Un ecosistema rigenerativo capace di mettere ordine, senso e direzione in ciò che già abbiamo — perché non basta avere gli strumenti giusti se manca la regia comune che li faccia dialogare, interagire e moltiplicare il loro impatto.
Le trasformazioni non dipendono dalle scelte individuali dell’imprenditore. Sempre più spesso, è il contesto che cambia così rapidamente da costringerci ad affrontare nuove sfide e a ripensare radicalmente le nostre risposte. Il punto, quindi, non è se cambiare, ma come farlo in modo consapevole, tempestivo e sistemico. Serve perciò un approccio capace di leggere la realtà in modo evolutivo, dotandoci di indicatori di sistema, non solo per valutare ex post l’efficacia delle misure, ma per comprendere se le traiettorie intraprese stiano davvero contribuendo a una trasformazione sostenibile, equa e condivisa. Indicatori che ci dicano non solo cosa funziona, ma anche chi contribuisce e in che misura al bene collettivo.
Veniamo da vent’anni di cultura rivendicativa — e va bene così: è giusto che le nuove generazioni reclamino una vita più giusta, dignitosa, sostenibile. Ma non basta rivendicare: bisogna anche contribuire. Perché — senza retorica, ma con lucidità — non si vive per lavorare, certo, ma senza qualcuno che lavori, la società non regge. La coesione sociale, la protezione, i diritti, i servizi pubblici, tutto ciò che garantisce dignità e libertà alle persone, si fonda sul lavoro di chi produce, di chi innova, di chi costruisce ogni giorno valore reale.
Per questo motivo è urgente costruire un nuovo patto generazionale, produttivo e sociale, in cui diritti e doveri, aspirazioni e responsabilità, libertà individuale e interesse collettivo si tengano insieme. Solo così possiamo affrontare davvero il tempo della convergenza, che è prima di tutto un tempo di ricostruzione del senso del vivere insieme. Attenzione, però: non si può estremizzare il discorso pensando che tutto debba essere automatizzato, che ci saranno solo robot, chip e intelligenze artificiali a decidere per noi. Non possiamo e non dobbiamo accettare un modello di società disumanizzato, in cui il controllo e la standardizzazione soffocano libertà e partecipazione.
Il nostro modello è un altro. È quello della libertà individuale coniugata con la responsabilità sociale. È una scommessa alta e ambiziosa, che richiede coinvolgimento consapevole, partecipazione attiva, corresponsabilità tra cittadini, istituzioni, imprese e territori. Non un’idea delegata né assistenzialista, ma una costruzione collettiva e solidale. E non dimentichiamolo: veniamo da 25 anni in cui si è chiesto allo Stato di risolvere tutto. E quando non ce l’ha fatta — perché non ce la può fare da solo — ha pagato per non risolvere, ha risarcito invece di trasformare.
Il costo? Oltre 505 miliardi di euro in trasferimenti statali in soli 15 anni. Un costo enorme, che non ha generato il cambiamento necessario, ma spesso solo una gestione dell’emergenza permanente, un tappare falle invece di rimettere in moto l’ingranaggio.
È tempo di cambiare schema!
Non più attesa passiva, ma progettualità condivisa. Non più risarcimenti a posteriori, ma investimenti anticipatori in competenze, lavoro, coesione, e innovazione sociale. Solo così possiamo dare un futuro al nostro modello di sviluppo — umano, sostenibile e giusto.
Quindi quei numeri non nascono per caso, e non sono semplicemente il frutto di errori contabili o tecnici. Sono il risultato di un impianto culturale profondo, in cui si è smarrita la capacità di costruire un modello partecipativo coerente con i cambiamenti in atto.
Quali sono le nuovi sfide da affrontare?
La sfida, allora, è duplice: ricostruire un modello partecipativo alle condizioni attuali, e, farlo tenendo conto che oggi abbiamo un livello di tecnologia molto più avanzato, che ci offre strumenti concreti per trattare, condividere, e valorizzare le informazioni. Perché dovremmo continuare a lavorare a compartimenti stagni, a perderci in sovrapposizioni e duplicazioni, quando esistono già le piattaforme, i dati, le tecnologie per mettere in rete le informazioni e renderle disponibili ai diversi attori?
In secondo luogo, abbiamo ancora un tessuto sociale e produttivo vivo, fatto di corpi intermedi — associazioni, fondi, parti sociali — che, seppur indeboliti, non sono scomparsi. Hanno bisogno di aggiornarsi culturalmente, di rimettersi in dialogo col presente, di superare logiche difensive o identitarie superate. Ma sono ancora una risorsa preziosa, soprattutto se riorientati verso l’interesse collettivo e la costruzione di senso nei territori.
In sintesi: abbiamo gli strumenti tecnologici e abbiamo ancora le strutture relazionali e istituzionali. Quello che serve è la volontà politica e culturale di connetterli, di mettere ordine, di superare la frammentazione, e di costruire insieme un sistema intelligente e inclusivo per affrontare le transizioni del lavoro e della società. Attenzione: ci sono, non è che non ci siano. I sindacati ci sono. Gli enti bilaterali ci sono. Le organizzazioni del lavoro autonomo ci sono. Quello che manca non è la presenza degli attori, ma una chiave costruttiva comune, una visione capace di valorizzare le risorse che già abbiamo. Se restiamo ancorati a logiche autoreferenziali, perdiamo tutti. Nessuno oggi è autosufficiente. La sfida non è dominare l’informazione, ma condividerla, attivarla in reti permanenti, in modelli cooperativi stabili e inclusivi.
E qui arriva il punto cruciale: le soluzioni sono e devono essere personalizzate. Non esiste, e non può esistere, un modello astratto calato dall’alto — nemmeno con l’intelligenza artificiale — che valga per tutti e orienti i comportamenti collettivi in maniera meccanica. Sarebbe un grave errore.
Perché?
Perché la personalizzazione vive di relazione, umanità, creatività, capacità di ascolto e adattamento. La tecnologia — anche la più potente — deve essere uno strumento al servizio di queste dimensioni. Se si rovescia questa gerarchia e si affida all’algoritmo il compito di normare l’umano, è un’intera generazione che va in tilt. E infatti, quanti giovani oggi vivono già in uno stato di disorientamento profondo, di ansia esistenziale? Non perché manchino le opportunità, ma perché manca un sistema capace di accompagnarli in modo autentico e umano, che riconosca la loro unicità e che non li costringa ad adattarsi a modelli preconfezionati e disumanizzanti.
Questa è la sfida vera: costruire insieme un ecosistema cooperativo, orientato alla persona, supportato dalla tecnologia, e fondato sulla fiducia e sulla corresponsabilità. Quindi, dobbiamo recuperare un processo radicalmente diverso, che non è solo tecnico o amministrativo: è un processo culturale, sociale, e politico. Su questo si gioca, né più né meno, il destino della democrazia.
E non dobbiamo illuderci che tale destino sia scontato. Non lo è affatto.
Ci sono segnali chiari e preoccupanti che ci dicono che la tenuta del modello democratico occidentale è sotto pressione, minacciata da modelli alternativi, eterodiretti e organici, che si presentano come più “efficienti” perché basati su verticalità, controllo e definizione centralizzata dei valori collettivi.
Basti pensare a un fatto cruciale: due anni fa, un mese prima dell’invasione russa dell’Ucraina, Cina e Russia firmano un documento congiunto in cui si afferma che l’idea di democrazia occidentale è sbagliata, perché si fonda su due pilastri considerati deboli: la libertà individuale e la responsabilità sociale. Secondo quel documento, al contrario, la democrazia “vera” è quella organica, quella in cui il potere decide cos’è giusto, definisce quali valori debbano orientare la collettività e pretende adesione e conformità.
Questo è il punto: il nostro modello democratico — fondato su partecipazione, pluralismo, responsabilità personale e libertà — è in discussione. E lo è non solo all’esterno, ma anche all’interno, se non siamo in grado di renderlo efficace, di adattarlo alle nuove sfide, e soprattutto di farlo vivere nelle pratiche quotidiane delle istituzioni, del lavoro, dell’educazione, dell’innovazione. La vera posta in gioco, oggi, non è solo occupazionale o formativa. È civile e democratica: riguarda il tipo di società in cui vogliamo vivere e crescere. O sapremo costruire un modello di sviluppo che tenga insieme libertà e coesione sociale, o rischiamo di lasciare spazio a logiche autoritarie che promettono ordine, ma negano dignità e autonomia.
Ecco perché tutto ciò che stiamo facendo nel quadro del Net Forum, della convergenza delle politiche attive, della valorizzazione delle competenze, non è un semplice lavoro tecnico: è un presidio democratico. Un modo concreto per dire che la libertà, la responsabilità e la partecipazione sono ancora possibili, se sappiamo renderle efficaci … e coerente con le sfide del nostro tempo.
Tre quarti del mondo oggi privilegia modelli autoritari o centralizzati, perché in quei contesti la governance garantisce rendita immediata, standardizzazione delle risposte, sacrificando però libertà e pluralismo. È il modello della “riga dritta”, dove si abbandonano i “colori” della complessità sociale in nome dell’efficienza apparente. Ma a quale prezzo? All’idea stessa di persona, di dignità, di scelta.
In questo modello — dove persino l’intelligenza artificiale è messa a servizio della conformità e non dell’autonomia — i problemi della vita vengono risolti, sì, ma da altri, non da te. E questa è l’antitesi della democrazia. Ecco perché, nel nostro piccolo, dobbiamo promuovere un cambiamento culturale. Un cambiamento che modifichi le griglie partecipative, rendendole più inclusive e crei vasi comunicanti reali, tra pubblico e privato, tra istituzioni e cittadini, tra apprendimento e lavoro. Che valorizzi soggetti e sedi capaci di personalizzare le risposte, senza perdere in visione sistemica e, soprattutto, sviluppi un processo educativo continuo, che ponga al centro l’occupabilità come espressione della persona, non solo come adeguamento a una domanda esterna.
Serve un nuovo patto tra etica, discernimento, educazione, formazione e lavoro. Un patto in cui l’etica orienta la direzione; il discernimento ci aiuta a leggere i contesti complessi; l’educazione prepara la mente e il cuore; la formazione sviluppa le competenze necessarie e il lavoro diventa espressione di sé e contributo alla collettività.
Questa è la sfida che ci attende: non solo formare per lavorare, ma formare per scegliere, per comprendere, per co-creare il futuro. Ed è qui che ciò che abbiamo fatto in questi giorni si inserisce, come luogo generativo di connessioni, consapevolezze e soluzioni, in grado di contribuire a un nuovo modello sociale, partecipativo e democratico. La strada che ci deve orientare, oggi più che mai, non può essere quella dell’autoreferenzialità. Se continuiamo così — ognuno nel proprio recinto, ciascuno con il proprio linguaggio e la propria agenda — non risolveremo i problemi tecnici né quelli strutturali, né daremo risposte efficaci ai cambiamenti in corso. Questo è il vero passaggio che dobbiamo compiere: portare a maturazione ciò che abbiamo seminato in questi anni. Dimostrare, con fatti concreti, che le riflessioni, i modelli, gli strumenti messi a punto possono incidere davvero e trasformare il sistema. Per farlo, serve ricostruire un dialogo sociale vero, non formale. Un dialogo che vada riportato negli ambiti costruttivi, dove si condividono dati, visioni, obiettivi e strumenti, non dove si negoziano posizionamenti.
Non possiamo più permetterci 34 fondi che si muovono in ordine sparso, e non parlo solo dei fondi interprofessionali: all’INPS ce ne sono altri 16, promossi dalle parti sociali, che restano senza una regia, senza una visione di sistema. Non possiamo continuare a vivere un conflitto sterile tra Stato e Regioni, tra pubblico e privato, tra mondo del lavoro e formazione. Non serve a nulla. Non serve a nessuno. L’unica via è la convergenza reale, basata su governance condivisa, multilivello, che valorizzi le specificità senza perdere l’unità di visione; interoperabilità dei sistemi, per far parlare banche dati, piattaforme, attori istituzionali e produttivi; un linguaggio comune, per affrontare insieme le transizioni e, soprattutto, una corresponsabilità diffusa: tra ministeri, regioni, fondi, imprese, terzo settore e cittadini.
Il Net Forum si candida a essere il luogo di questo dialogo generativo, in cui le diversità si incontrano per produrre orientamento strategico, non frammentazione. Solo così possiamo passare dai tasselli al disegno, dalla somma di azioni alla costruzione di un modello condiviso. E affrontare, da protagonisti, le sfide che l’epoca della complessità e dell’intelligenza artificiale ci impone. Le competenze che abbiamo a disposizione vanno valorizzate all’interno di un quadro cooperativo, non competitivo. Dobbiamo smettere di trattare le politiche attive del lavoro come una somma di interventi frammentati: serve una strategia unitaria, multilivello, coerente con i divari territoriali e sociali che attraversano il nostro Paese.
Nel Nord c’è un problema di aggiornamento delle competenze, di specializzazione avanzata, di attrazione e tenuta dell’innovazione. Ma nel Sud il nodo cruciale è l’inattività, la rassegnazione sociale, lo scoraggiamento diffuso. Due terzi degli inattivi e degli scoraggiati risiedono nel Mezzogiorno: pensare che la risposta sia semplicemente spostarli altrove, magari verso il Nord o l’estero, è un errore strategico e civile. Bisogna costruire un’idea di politica attiva che sia funzionale a questi contesti: servono interventi radicati nei territori, che valorizzino le persone, le reti, le potenzialità locali.
Politiche che puntino a “non farli andare via”, ma a restituire fiducia, opportunità, dignità e strumenti a chi è rimasto escluso dai processi di sviluppo e di innovazione. Questa è la vera sfida per una convergenza generativa: non portare tutti nello stesso punto, ma far crescere ciascun territorio nel rispetto delle proprie specificità, favorendo mobilità circolare, ma soprattutto coesione sociale e sviluppo inclusivo.
La domanda pubblica di servizi da parte della pubblica amministrazione rappresenta una leva fondamentale per riequilibrare gli squilibri strutturali del Paese. Ma per essere davvero efficace, questa leva va declinata con intelligenza strategica, orientando una quota rilevante della spesa pubblica verso ambiti cruciali e ad alta intensità di lavoro: sanità, cura della persona, servizi territoriali, manutenzione urbana e ambientale. Non si tratta solo di creare occupazione, ma di farlo costruendo un’economia più coesa e resiliente, fondata su bisogni reali e su un approccio territoriale. Questo richiede modelli di intervento e di governance nuovi, adattabili, flessibili, capaci di coinvolgere attori diversi in base ai contesti e alle risorse disponibili. Per questo è fondamentale capitalizzare quanto emerso finora e costruire una regia sistemica.
Come INAPP, possiamo offrire un contributo concreto nell’aggiornare i modelli di valutazione dei fenomeni – sia sociali che economici – e degli impatti delle politiche pubbliche. Ma è Sviluppo Lavoro Italia che ha il compito chiave di ricostruire i modelli di governance operativa, promuovendone la condivisione tra attori diversi, adattandoli alle peculiarità dei territori e sostenendo, dove necessario, anche forme di accompagnamento e supporto per mobilitare i soggetti che oggi restano ai margini. Non bastano più schemi rigidi o modelli centrali da replicare ovunque: serve una capacità di lettura e di intervento dinamica, adattiva, fondata sulla cooperazione tra livelli istituzionali, territori e sistemi produttivi. Nel Mezzogiorno, la fragilità strutturale non riguarda solo il settore privato, ma anche il sistema pubblico. Questa debolezza incrociata rende ancora più urgente intervenire: spesso il privato si trova a supplire le funzioni che il pubblico non riesce a garantire, con il rischio di aggravare le disuguaglianze e accentuare gli squilibri territoriali.
Non abbiamo anni davanti a noi: abbiamo qualche mese. Se vogliamo davvero imprimere una svolta, dobbiamo lavorare fin da ora per definire, entro la fine dell’anno, un’idea concreta di riforma delle politiche attive del lavoro, capace di generare convergenza tra Nord e Sud, tra pubblico e privato, tra centro e territori. Servono contributi forti e credibili anche dal “sistema esterno”, dai corpi intermedi e dagli attori della società civile ed economica.
Io ho vissuto intensamente gli anni Novanta, ricordo bene il periodo degli accordi sulla politica dei redditi, e la crisi che ne seguì. Una stagione in cui un’intera classe dirigente fu travolta. Nel biennio 1992-1993 bastava incontrare un interlocutore il lunedì per scoprire che il martedì era finito sotto inchiesta. In quel contesto così drammatico, fu la tecnocrazia pubblica, sobria e determinata, a salvare la tenuta istituzionale del Paese, insieme alle parti sociali.
Parliamo di figure come Carlo Azeglio Ciampi, Lamberto Dini, Antonio Maccanico, Giuseppe Mazzella, Gino Giugni: personalità che, pur nella diversità dei ruoli, seppero interpretare un’idea alta e responsabile di servizio allo Stato e alla collettività. Oggi ci serve quello stesso spirito. Una convergenza istituzionale forte, coraggiosa, generativa. Non è il tempo delle rendite di posizione, ma della ricostruzione intelligente e condivisa. Ho citato cinque nomi, e non a caso.
Quando andavo in quei ministeri, ai tempi della concertazione sulla politica dei redditi, non ci si poteva permettere leggerezze. Prima di parlare, facevo due giri intorno all’edificio. Lì dentro non si improvvisava nulla. Se non eri preparato, se non avevi visione, rigore e senso delle istituzioni, in cinque minuti eri fuori da ogni ascolto. Non c’erano pranzi di rappresentanza: c’era il senso dello Stato.
Quella era tecnocrazia pubblica nella sua forma più alta. Una tecnocrazia che sapeva interpretare un ruolo fondamentale: tenere insieme un Paese in un momento drammatico, con sobrietà, competenza e consapevolezza. Oggi dobbiamo ricostruire un tessuto analogo, ma in un contesto più complesso, attraversato da transizioni molteplici e rapide.
Il problema non è solo tecnico, è anche politico e culturale. Dobbiamo ripensare un modello nuovo di cooperazione tra istituzioni e parti sociali, in grado non solo di governare, ma di influenzare le decisioni politiche. Questo richiede che i corpi intermedi ritrovino un protagonismo costruttivo, e che la pubblica amministrazione riacquisisca un ruolo strategico e non meramente esecutivo.
Il quadro politico oggi è in movimento, ma è aperto. Proprio per questo è il momento di riportare in campo modelli di riforma ispirati alla concretezza e alla responsabilità di quella stagione degli anni ’90, ma aggiornati al tempo presente, tenendo conto della velocità delle trasformazioni, dell’urgenza delle risposte e della fragilità delle coesioni sociali. Dal 2010 in poi abbiamo assistito a un approccio frammentario alle politiche sociali e del lavoro. Un bonus per le famiglie, un sussidio per i figli, qualche misura per la formazione … tutto sommato, interventi spot. Ma manca una visione organica, un’idea strutturale di come rigenerare la popolazione attiva. E se non abbiamo un progetto per generare nuova forza lavoro, l’intero sistema produttivo si indebolisce, si restringe.
Nel frattempo, si avvicina una crisi silenziosa ma devastante: quella della non autosufficienza. La figura della “nonna non autosufficiente” rischia di diventare un fardello insostenibile per intere famiglie, e di riflesso per le comunità. Non parliamo di scenari futuri: questa emergenza è già in atto. Ci sono milioni di persone anziane che vivono isolate, escluse dalla partecipazione sociale, prive di un sistema assistenziale strutturato. E a questo si somma una povertà crescente, che si sta espandendo in modo preoccupante. Come presidente del Comitato per la valutazione delle misure, posso dirlo con dati alla mano: il 40% delle misure di contrasto alla povertà oggi attivate è assorbito da persone anziane. Non stiamo parlando quindi solo di marginalità, ma di un problema strutturale, che tocca il cuore demografico, sociale ed economico del Paese.
Vorrei chiudere con una riflessione che va oltre l’ambito tecnico, toccando una dimensione etica che, credo, oggi ci accomuna tutti. Il tema che abbiamo affrontato – quello della rigenerazione delle politiche attive, della costruzione di un ecosistema fondato sulla convergenza tra pubblico e privato, tra territori e istituzioni centrali, tra impresa e persona – è una questione che interpella profondamente il nostro senso di responsabilità.
Non è più solo un tema organizzativo o regolativo. È un impegno che dobbiamo assumerci in quanto cittadini, dirigenti, tecnici, formatori, policy maker. Perché ciò che è in gioco è la capacità del nostro Paese di affrontare le fratture del presente e preparare un futuro in cui ogni persona sia messa nella condizione di partecipare, apprendere, lavorare e contribuire.
Vi ringrazio sinceramente per i contributi preziosi che avete portato in questi due giorni. Tutti, in modo differente, sono andati nella direzione giusta. Ci avete restituito analisi lucide, esperienze concrete, proposte operative e anche spiragli di visione. Personalmente, esco da questi lavori molto arricchito, sia sul piano professionale che umano. E spero che anche voi abbiate vissuto un’esperienza piacevole, utile e, perché no, anche stimolante.
Per rivedere l’intervento di Natale Forlani al Workshop di Capri 2025
clicca qui
Scopri le proposte per il futuro del lavoro e della formazione. Clicca qui per prenotare la tua copia del Libro Bianco 2025.