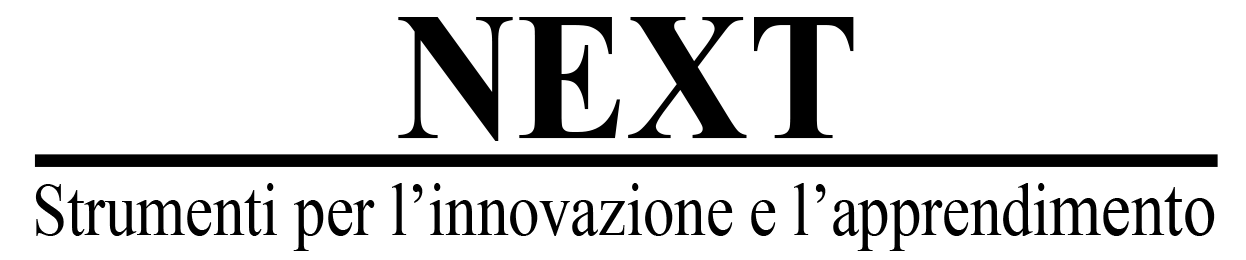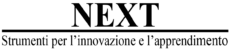Intervento di Susanna Camusso al Workshop di Capri (15-16-17 maggio 2025)
Per poter costruire delle missioni, per avere consapevolezza delle strategie da mettere in campo, è necessario prima soffermarsi su cosa intendiamo quando parliamo di “cornici istituzionali”. Che cos’è un’istituzione? È qualcosa di distante da noi? Di estraneo?
Forse è arrivato il momento di cambiare prospettiva. E per farlo, possiamo usare un portolano. Io l’ho immaginato così: come la mia mappa di Capri. Perché quando decidiamo di metterci in gioco in prima persona, quando scegliamo di esserci davvero, allora l’istituzione non è più “altro” da noi. Diventa parte di noi. Non nel senso del possesso, ma della partecipazione: “mio” non perché mi appartiene, ma perché io ne faccio parte.
Essere parte di un’istituzione significa riconoscersi in essa, agire al suo interno, sentirsi responsabili. E Capri, con il suo sguardo che si apre sull’orizzonte, ci offre proprio questa possibilità: cambiare punto di vista. È un luogo che può davvero aiutarci ad immaginare una visione diversa della società futura.
Con alcuni di voi ci siamo già incontrati durante la prima edizione di questa “maratona” che ci accompagnerà anche quest’anno per tre giorni. Alcuni di voi quindi già hanno familiarità con lo schema di ragionamento che Net Forum propone per trattare in modo alternativo molte delle cose che quotidianamente vengono dette.
E allora, permettetemi di partire da una metafora — mi sembra inevitabile, visto dove siamo. Capri oggi rappresenta un’ancora nella tempesta. Un appiglio per chi, magari, non è abituato a navigare, ma ha bisogno di ritrovare un punto fermo.
Ma quell’ancora nella tempesta non è ancora – nel senso temporale – ma un’ancora vera e propria, uno strumento concreto, anche se inizialmente invisibile, che serve ad allentare la corsa fino a fermare una barca, quando intorno non ci sono più le condizioni per navigare.
A quel punto si può scegliere: si può decidere di ripartire, di cambiare rotta rispetto alla situazione attuale; oppure si può restare in una calma solo apparente, in una bonaccia con la barca ferma.
Noi ci riconosciamo in questa immagine di sosta, di riflessione, perché è questo il senso del momento che stiamo vivendo: un tempo che spesso definiamo “di transizione”, ma che oggi, più che mai, sta davvero accadendo sotto i nostri occhi. E con esso, anche i parametri di riferimento che eravamo abituati a considerare stabili vengono profondamente messi in discussione.
La prima certezza messa in discussione è se la nostra consueta lettura del mondo, costruita secondo schemi multipolari, sia ancora valida oggi e se sarà in grado di sopravvivere al prossimo futuro.
Ma cosa c’entra tutto questo con le nostre riflessioni?
Ha a che fare eccome con le nostre vite. Perché quando poniamo al centro il tema della costruzione di un ecosistema, stiamo parlando di un modello che influenza la nostra visione del mondo. Un modello che si ripercuote direttamente su ciò che tendiamo a dare per scontato: la transizione digitale, l’evoluzione tecnologica che ci circonda. Ma siamo sicuri che sia davvero così scontata come ci sembrava solo pochi mesi fa? Le stesse caratteristiche che attribuivamo a questi processi, con una certa sicurezza, forse oggi non ci appaiono più così evidenti.
L’impatto dell’IA sul nostro futuro
Le nuove trasformazioni pongono sfide importanti anche per noi, come Paese membro dell’Unione Europea, che dovrebbe saperle leggere all’interno di una visione europea. Ovviamente ci sono soggetti che dispongono di strumenti e competenze molto più avanzati, ma resta il fatto che c’è una percezione collettiva – spesso veicolata anche dalla comunicazione – secondo cui saremmo già nel pieno dell’era dell’intelligenza artificiale. Ebbene, questa è un’affermazione completamente falsa.
È vero che tutti noi abbiamo ormai in tasca uno strumento che utilizza forme di intelligenza artificiale – basti pensare agli aggiornamenti dei nostri telefoni o di WhatsApp – e che ci viene spiegato che, grazie a questi aggiornamenti, possiamo “usare” l’intelligenza artificiale.
Poi può anche succedere che ti venga spiegato, ad esempio, se c’è stata o no una “strage dei bianchi” – come sta accadendo con l’intelligenza artificiale promossa da Musk – ma questo non significa davvero essere immersi nel paradigma digitale.
Avere accesso a un frammento di tecnologia con cui si può giocare e sperimentare, che sembra consentire molte cose, non implica di per sé che siamo davvero nel pieno dell’era digitale.
Intanto, va detto che noi apparteniamo comunque a un’élite mondiale – e anche se così non fosse – bisogna guardare al sistema nel suo complesso, a partire da quello produttivo, che per un Paese come il nostro include manifattura, servizi, turismo, insomma tutto ciò che è legato alla produzione e all’organizzazione economica. Ed è proprio lì che occorre chiedersi quanto sia effettivamente diffusa e integrata l’intelligenza artificiale.
Parlando del nostro Paese, la diffusione effettiva dell’intelligenza artificiale è molto inferiore a quanto vorremmo o a quanto immaginiamo dovrebbe essere. I dati continuano a dirci che gli investimenti in tecnologia sono ancora al di sotto delle aspettative – sia rispetto a ciò che sarebbe necessario, sia rispetto a ciò che ci eravamo prefigurati.
Allo stesso tempo, però, circola un’idea molto diffusa – che viene ripetuta quasi come un mantra – secondo cui “tutte le imprese ormai utilizzano strumenti di intelligenza artificiale”. Ecco, credo che prima o poi qualcuno dovrà mettersi seriamente a verificare la fondatezza di questa affermazione.
Se guardo ai numeri sugli investimenti e, banalmente, al ritorno che questi generano nei bilanci delle aziende, è evidente che qualcosa non torna. Siamo di fronte a una stratificazione profonda nell’adozione e nell’impatto delle tecnologie: da un lato, si afferma e si diffonde uno strumento in modo pervasivo, ma questa diffusione non è sinonimo di democratizzazione della tecnologia.
C’è una relazione diretta tra questa apparente ubiquità e il fatto che la tecnologia sia in realtà detenuta da pochi: si tratta infatti di strumenti prodotti e controllati da un numero ristretto di grandi aziende hi-tech. Non si tratta di un prodotto realmente diffuso: e questa, ad esempio, è una domanda che dovremmo porci, perché orienta le scelte da compiere sul piano formativo. Oggi ci troviamo di fronte a una realtà in cui la Cina ha dimostrato capacità produttive e innovative che non ci si aspettava. Al di là del dibattito su quanto ci sia di copiato o meno — dibattito che in fondo è poco rilevante — resta il fatto che loro un prodotto ce l’hanno.
L’Europa non dispone di un proprio modello tecnologico autonomo, e l’Italia ancor meno. Siamo in una stagione in cui diamo per scontata la diffusione di una tecnologia di cui, in realtà, non possediamo né gli strumenti né le capacità per intervenire in modo autonomo. Se ci pensiamo bene, questa è una situazione profondamente diversa rispetto alle precedenti rivoluzioni industriali, in cui l’affermazione definitiva delle tecnologie avveniva quando queste diventavano patrimonio di molti, anche sotto il profilo della progettazione, della personalizzazione — diremmo oggi customizzazione — e della loro adesione a determinati modelli culturali e di vita.
E allora, anche nel contesto dell’Unione Europea, dobbiamo porci una domanda cruciale: non potendo dare per scontato che diventeremo protagonisti nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, dobbiamo chiederci se per noi sia più importante formare le persone all’uso e all’interazione con l’IA, oppure se non sia altrettanto fondamentale sviluppare una capacità critica verso questa tecnologia.
Questa è l’altra grande domanda che inevitabilmente condiziona i percorsi formativi: una cosa è saper maneggiare un algoritmo o partecipare all’addestramento di un’intelligenza artificiale, altra cosa è essere formati per interagire in modo consapevole e critico con questa tecnologia. E questo ci costringe a riflettere sul fine ultimo: perché formiamo le persone a interagire con l’intelligenza artificiale? A quale scopo?
Non si offenda nessuno, ma a volte l’intelligenza artificiale somiglia più a una “stupidità artificiale”, perché è la semplice somma delle informazioni che le sono state fornite, e non possiede una vera capacità di interpretare il contesto in cui viviamo. E questo, se lo pensiamo in termini assoluti, è pericoloso. Gli esseri umani, uomini e donne di questo mondo, hanno già combinato un sacco di guai, e quei guai si stanno già manifestando anche là dove l’intelligenza artificiale è stata introdotta.
Gli effetti derivanti dall’uso acritico di strumenti basati esclusivamente sull’accumulo di dati si stanno già facendo sentire, con tutti i loro limiti e difetti. Faccio un esempio classico, che è coerente con il nostro tema di oggi, perché stiamo parlando di formazione — e quindi anche di personale e di mercato del lavoro.
Se utilizzi l’intelligenza artificiale per la selezione del personale, senza prima verificare quali fonti informative le hai fornito, puoi stare abbastanza certo che selezionerà soprattutto uomini, e possibilmente anche con determinati tratti o caratteristiche. Perché? Perché questi sono i dati dai quali l’intelligenza artificiale ricava le sue regole, e quindi tende a riprodurre ciò che ha “appreso” dai modelli passati, anche se distorti o discriminatori.
Questo tema, ovviamente, diventa ancora più complesso se si affronta in termini di “intelligenza predittiva”, ad esempio nella giustizia, o in altri ambiti delicati, dove le conseguenze non sono solo problematiche, ma potenzialmente gravi.
Non possiamo considerare l’intelligenza artificiale come qualcosa a cui delegare la definizione del nostro contesto, del nostro sistema di diritti, che è e deve restare frutto delle scelte e delle responsabilità umane.
Non possiamo immaginare un mondo in cui l’intelligenza artificiale sostituisce le relazioni tra le persone, perché sono proprio le relazioni a fondare la nostra vita sociale, democratica e giuridica.
In particolare, non possiamo accettare che sia l’intelligenza artificiale a determinare i luoghi dell’incontro umano, come anche i luoghi della giustizia, e via dicendo. Ci sono ambiti che richiedono presenza, consapevolezza, responsabilità umana – e non possono essere ridotti a una mera elaborazione automatica di dati.
Eppure, noi continuiamo a dire che le politiche attive — in primo luogo quelle formative — sono quelle su cui siamo più avanti, quelle di cui abbiamo maggiore consapevolezza rispetto alla loro utilità.
Le politiche attive del lavoro sono, per definizione, inclusive: hanno come obiettivo quello di non lasciare nessuno fuori dal mercato del lavoro, di non escludere persone che, per le ragioni più diverse, si trovano in condizioni di marginalità o esclusione. Allora, una prima domanda da porsi è questa: gli strumenti di intelligenza artificiale sono in grado di orientare e guidare questi processi di inclusione? E se sì, quali informazioni devono contenere per farlo in modo corretto?
E torno al punto di partenza: possiamo pensare che l’intelligenza artificiale svolga queste funzioni senza una finalizzazione chiara, senza un’intenzionalità da parte nostra? Possiamo davvero accettare di usarla come una scatola preconfezionata, senza interrogarci sulla sua direzione e sul suo scopo?
Perché sì, la potenza dell’intelligenza artificiale risiede nella somma degli algoritmi che la compongono, ma è nostra responsabilità definire l’utilizzo, gli obiettivi e i criteri di impiego di quella potenza. Ma soprattutto serve avere delle banche dati.
Oggi l’intelligenza artificiale si regge sulla combinazione di grandi capacità di investimento, una forte presenza di progettisti e una enorme quantità di dati. Ma nessuno di questi fattori, preso singolarmente, è sufficiente a garantire un vero processo di digitalizzazione a servizio della collettività.
Ed è qui che si apre un ventaglio molto ampio di problemi, perché i dati rappresentano la nostra vita, parlano delle nostre caratteristiche, dei nostri comportamenti, delle nostre relazioni. E quindi il tema dei dati richiederebbe un’attenzione specifica e approfondita. Dobbiamo tenerlo sempre presente: i dati possono essere usati per includere, ma possono anche essere usati per escludere. Di per sé, i dati non hanno un orientamento etico o politico: sono gli usi che ne facciamo a determinarne il valore e l’impatto.
Ci troviamo con l’ancora gettata nella tempesta, o forse in una situazione di apparente tranquillità, che però ci serve per riflettere. E in questa riflessione emergono interrogativi sempre più grandi, che riguardano non solo che cosa dobbiamo fare, ma anche quale approccio dobbiamo adottare.
Possiamo scegliere un approccio individuale, oppure un approccio collettivo.
Il diritto del lavoro da sempre è costruito su questa dialettica: da una parte, i diritti individuali, che sono inderogabili; dall’altra, i diritti collettivi, che prendono forma attraverso la contrattazione e la dimensione collettiva.
Ebbene, la formazione segue esattamente la stessa dinamica: può essere vissuta come un processo puramente individuale, oppure può essere un processo collettivo, costruito insieme, orientato da una visione comune. Di fronte a una trasformazione che è già in atto e che continuerà a svilupparsi, possiamo scegliere se affrontarla con un’impostazione che accentua l’individualizzazione, oppure costruire una dimensione collettiva, che trovi nei forum, nei luoghi di confronto, nelle certezze istituzionali e normative le sue basi solide.
Tutto ciò che abbiamo detto finora conferma che dobbiamo andare in una direzione collettiva. Non possiamo affrontare questa trasformazione da soli, in una dimensione puramente individuale, e non possiamo affidarla alla logica dell’autoformazione. Certo, ci sarà sempre qualcuno che si auto-forma, che ha una curiosità personale sconfinata. Ma dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista del quadro pubblico e collettivo, la formazione va pensata e affrontata come un processo condiviso.
E quando si entra nella dimensione collettiva, la formazione acquista un altro valore: diventa non solo un luogo dove si acquisiscono competenze, ma uno spazio di progettazione, in cui si disegna ciò che si immagina per il futuro.
La formazione come dimensione permanente: molti dei soggetti presenti oggi non sarebbero qui, non farebbero ciò che stanno facendo, se non esistesse l’idea stessa di formazione continua. È questa la chiave che tiene insieme il senso del nostro agire. In sintesi, la dimensione formativa è uscita dall’idea di essere confinata a una sola fase della vita. Ha iniziato ad assumere la forma di un percorso che deve accompagnare le persone per tutta la vita, ovviamente con modalità diverse a seconda delle fasi dell’esistenza.
Abbiamo costruito il concetto di formazione permanente in un’epoca che era ancora fortemente orientata all’addestramento, in cui c’era la necessità di adeguare le competenze esistenti ai processi di innovazione tecnologica. Ma si trattava di processi che modificavano principalmente gli strumenti utilizzati nel lavoro. Siamo passati dai torni meccanici alle macchine a controllo numerico, dalle macchine a controllo numerico a sistemi più complessi; abbiamo sostituito carta e penna con i computer per l’inserimento dei dati. Abbiamo, insomma, cambiato gli strumenti. Questo, naturalmente, richiedeva nuove competenze per interagire con quei nuovi strumenti.
Oggi, invece, siamo davanti a qualcosa di diverso: la prima cosa che cambia non è tanto lo strumento, quanto il flusso di informazioni che ti inserisce nel contesto di lavoro. Dunque, il primo bisogno che emerge è il bisogno di relazione: un bisogno che si traduce nella capacità di interfacciarsi e interloquire con processi relazionali, cosa per nulla semplice, che spesso tende a essere affrontata in termini individuali, anziché come una questione da pensare collettivamente.
Ma quei processi relazionali sono inseriti in un’organizzazione del lavoro, e quindi appartengono a pieno titolo alla dimensione collettiva. Possiamo davvero affrontare tutto questo in chiave individuale? Possiamo, affrontarlo ritenendo che i nostri livelli di istruzione, così come li abbiamo codificati nel tempo, siano sufficienti?
Osservazioni di chiusura
Chiudo con due osservazioni.
La prima: stiamo assistendo a un fenomeno di analfabetismo di ritorno. Abbiamo conosciuto un processo di estensione dell’istruzione — a partire da quella dell’infanzia — ma oggi stiamo assistendo a un andamento esattamente opposto, paradossalmente favorito anche dagli strumenti digitali che portiamo in tasca. C’è una contraddizione profonda in questo: stiamo discutendo da tempo sulla questione dei tempi scolastici, e l’idea che si possa continuare ad accorciarli, senza anticiparne l’inizio, significa ridurre la base comune di istruzione. E invece, proprio in questa fase storica, servirebbe investire il più possibile su questa base collettiva di conoscenza, pur sapendo che comunque non sarà sufficiente a garantire tutto ciò che serve. Serve costruire una relazione positiva tra le persone, i cambiamenti e l’avanzare dell’età, specialmente in riferimento a come le tecnologie potranno modificare e ridefinire il lavoro.
Questo implica un nuovo ruolo per la formazione e, conseguentemente, una revisione degli assetti istituzionali. La formazione, infatti, sarà sempre meno finalizzata alla sola acquisizione di competenze specifiche e dovrà invece sviluppare una maggiore capacità di orientamento — una capacità che, ad oggi, nessuno ha ancora saputo definire pienamente, né dal punto di vista dei contenuti, né da quello degli strumenti.
Per affrontare la sfida che abbiamo davanti, non basterà più solo un buon portolano — forse ci vorrà anche un libro dei fari, perché non sempre le mappe sono aggiornate o precise.
Ma, soprattutto, quegli strumenti un tempo erano affidati a equipaggi che navigavano in modo collettivo. Oggi dobbiamo costruire nuovi equipaggi, equipaggi consapevoli che senza una dimensione collettiva non sarà possibile navigare.
Per concludere queste giornate della mia esperienza ai lavori della seconda edizione del Net Forum partirei dalla parola gruppo. Posso partire dall’esperienza del gruppo, e poi provare a guardare un po’ tutto a tutto tondo. Ho colto – perché c’ero, perché ci sono stata dentro – che è stato molto interessante, al di là dell’autoironia che stiamo usando, anche un po’ per stemperare il peso dei ragionamenti. È stato interessante perché quel gruppo ha tradotto nel proprio lavoro una serie di parole che, in realtà, hanno attraversato tutti i gruppi e che – soprattutto – attraversano profondamente l’attività concreta, sia delle istituzioni impegnate sul tema, sia dei soggetti operativi. La prima parola è ‘linguaggio comune’
Parole comuni, un lessico condiviso, un vero e proprio glossario: se non erro, era anche uno degli obiettivi di Net Forum. E qui, permettetemi di passare all’interpretazione, ovvero a quello che ho percepito nel gruppo.
Quando questo elemento – cioè la condivisione del linguaggio – passa dal piano della riflessione sulla formazione al livello della pratica, cioè dell’applicazione concreta dentro le regole delle istituzioni, accade qualcosa: i linguaggi smettono di comunicare. È come se calasse una barriera che rende tutto più difficile. Certo, questa difficoltà si può esprimere in modi più o meno conflittuali, ma resta una difficoltà profonda: quella di far dialogare approcci, mondi, ruoli diversi attorno a una stessa finalità.
Ma quella è la difficoltà che esiste. E io non ho mai pensato che il conflitto, di per sé, sia un problema. Anzi, il conflitto fa progredire il mondo. Non va confuso con la guerra: il conflitto relazionale e la guerra sono due cose ben distinte. Quindi no, il conflitto non mi preoccupa. Il gruppo ha scelto un’altra chiave, anche ironica, quasi autoironica, prendendosi un po’ in giro rispetto alle evidenti difficoltà nel costruire un linguaggio e una visione comuni. E ha fatto bene, perché le difficoltà non riguardano più soltanto il tema della formazione. In realtà, la formazione si intreccia con una complessa architettura istituzionale, che ovviamente impatta anche sulle pratiche quotidiane. C’è sempre la tentazione di un “regista”, ma …
C’è poi un tema che si chiama “Regioni”. Un giorno, forse, qualcuno ci spiegherà come si possa conciliare l’autonomia differenziata con l’essere, al tempo stesso, nazionalisti su alcune questioni. Mettere insieme le due cose non è affatto semplice — ma questo sarebbe un altro capitolo. La questione centrale, invece, è l’interpretazione dei ruoli delle istituzioni. Soprattutto quando queste entrano in conflitto tra loro, finiscono per mettere in difficoltà tutti gli altri attori che, in qualche modo, dipendono da quell’architettura istituzionale.
Allora, la prima parola chiave è proprio quella — e la seconda, emersa dal gruppo, non è “quantizzare”, sebbene l’abbiamo usata spesso. La questione centrale riguarda invece: come si può immaginare una regolazione rigida — ovvero norme molto vincolanti — in un contesto che ha come tema centrale il cambiamento? Più si tenta di normare in modo rigido un sistema, più si rischia di introdurre una rigidità incompatibile con la natura evolutiva di ciò che si sta regolando. E questo è uno dei problemi principali che si pongono. Allora la domanda è: le istituzioni — nel senso più ampio — e tutti gli attori che compongono questo ecosistema, sono in grado di immaginare forme di regolazione effettivamente flessibili?
Perché il rischio è che ciò che oggi individuiamo come un “gap” da colmare, domani diventi un elemento cristallizzato, che non solo non si colma ma si trasforma in una frattura. Cioè: cerchiamo di cambiare delle cose, e nel frattempo rischiamo di irrigidirle proprio mentre sono già cambiate.
Capisco bene che, per qualunque istituzione si parli, produrre una norma capace di reggere il cambiamento è una sfida pressoché impossibile — soprattutto in un Paese dove facciamo già fatica ad applicare un processo ordinario di valutazione di impatto, e ancor di più una valutazione d’impatto ex post. L’idea stessa di riuscire a modificare una norma in tempo reale, rendendola flessibile, mi appare davvero complessa. Eppure, mi verrebbe da dire, parafrasando un famoso leak: siamo qui proprio per questo. Perché da qualche parte bisogna pur cominciare, da qualche parte bisogna iniziare a sollecitare un cambiamento.
E allora, guardando anche alle forme che abbiamo già sperimentato — come l’esperienza dell’anno scorso, questa seconda edizione del Net Forum — la domanda è: cosa possiamo attenderci in prospettiva? Cosa possiamo effettivamente fare, a partire da tutto ciò che è emerso, non solo nei lavori formali ma anche nelle conversazioni più informali, come quelle che accadono camminando per le strade di Capri o incontrandosi a cena? Perché, tutto quello che succede qui poi si decanta — e in quella decantazione, come accade con il vino buono, si ritrova il sapore vero delle cose.
Possiamo anche fermarci ad aspettare, ma senza affidarci troppo a Calvaruso — che, lo sappiamo, troverà senz’altro una nuova chiave per raccontarci quello che faremo. Ma, battute a parte, la sensazione finora è questa: siamo nello stesso luogo, ma in un momento diverso. Molte delle persone che sono qui c’erano già l’anno scorso. E molti dei temi sono gli stessi, ancora presenti. Tuttavia, è come se, nel frattempo, fosse accaduto molto. Le questioni che l’anno scorso si stavano appena delineando come processi in accelerazione, oggi ci appaiono già velocizzate, già trasformate in nuove domande. Ci troviamo di fronte, ad esempio, al fatto che ormai diamo per scontato che l’intelligenza artificiale sia entrata nella nostra cassetta degli attrezzi quotidiani. Non ci chiediamo più se usarla, ma come. Quindi, da un lato siamo gli stessi — soprattutto come attori, come persone coinvolte — ma, dall’altro, siamo cambiati, perché il tempo in cui ci muoviamo è cambiato. E se il tempo della transizione continua ad accelerare …
Già un anno fa c’era questa sensazione, e oggi credo sia confermata: abbiamo bisogno di costruire reti, network, o comunque li si voglia chiamare — ma soprattutto luoghi informali. Perché, se c’è una caratteristica che questo spazio ha, è proprio quella di essere un luogo informale. Un luogo in cui si partecipa al di là dei ruoli istituzionali, nonostante le difficoltà maggiori che spesso questi ruoli comportano. Ma è proprio la forza dell’informalità — che non va confusa con mancanza di rigore o di impegno — a generare uno spazio di libertà.
Libertà di maturare un cambiamento d’opinione nel tempo del lavoro: cioè la possibilità di arrivare con un’idea e, quando si va via, averla già trasformata. Che sia nel gruppo di lavoro, durante una cena, o magari mentre ci fate camminare in salita — ci sono diversi momenti in cui questo può accadere. Ma è evidente che si gode di una libertà: quella di valutare, di cambiare, e — soprattutto — di cambiare opinione.
La seconda libertà è quella di poter alzare il livello del confronto. Nessuno di noi qui è vincolato dall’obbligo che, alla fine di questi giorni, debba necessariamente accadere qualcosa di preciso, che un certo ente debba produrre un certo atto. Abbiamo di fronte un tempo che ci consente di trasformare quanto emerso in un cambiamento: nell’organizzazione di cui facciamo parte, in una proposta normativa, in un nuovo atteggiamento. Ognuno, ovviamente, nella forma che gli è propria.
C’è un tempo che consente la sedimentazione, cioè la possibilità di far maturare quanto emerso e tradurlo in opzioni, in percorsi possibili. Ed è questa, secondo me, un’altra ragione per cui scegliere un approccio come quello del Net Forum è strategicamente vincente — passatemi il termine. Viviamo in un’epoca in cui ci sono troppi “filosofi da sala” che parlano di filosofia senza mai mettersi davvero in discussione. Questo spazio, invece, consente di immaginare, di andare oltre la mera valutazione della singola esperienza o della singola connessione, per provare a intuire un’evoluzione. Un’evoluzione che ciascuno di noi può ricavare anche da una riflessione più ampia sulla propria esperienza. Scusate la digressione, ma il punto è proprio questo: avere la possibilità concreta di continuare ad alimentare una discussione autentica.
Ovviamente tutto questo funziona anche perché — e va riconosciuto — i Calvaruso hanno un’abitudine preziosa: non dimenticano ciò che è stato fatto. Riescono a tradurlo nel Libro Bianco, fissando degli appuntamenti che danno continuità al percorso. Perché quel filosofeggiare, quell’alzare lo sguardo, si traduce poi in uno strumento concreto, in una sintesi delle riflessioni e delle azioni intraprese. E poi — non so voi — ma io sono molto curiosa di vedere che piega prenderà tutto questo.
Nel frattempo, devo dire che dal punto di vista degli strumenti legislativi è successo molto poco. Un anno, ormai, è un tempo quasi inesistente dal punto di vista normativo, e lo è sempre di più. E questo perché, con assoluta chiarezza, siamo su un crinale. Viviamo in un mondo che si sta confrontando — più di altri — con la presenza dell’intelligenza artificiale, con il modo in cui possiamo utilizzarla, e con ciò che essa comporta. E devo dirvi la verità: questo crinale continua a farmi davvero molta paura.
Questo crinale — se lo si affronta nel modo sbagliato — rischia di produrre danni molto più gravi rispetto ad altri ambiti. Perché qui stiamo parlando di istruzione, di formazione, e di tutte le sue articolazioni. Stiamo parlando di ciò che contribuisce a costruire lo spirito critico, la partecipazione, l’atteggiamento delle persone. E parliamo, troppo spesso, della formazione rivolta ai soggetti più fragili, non di quelli già attrezzati. Ed è proprio questo che mi porta a una riflessione su una mancanza che ho percepito fortemente nella discussione che abbiamo condotto. Noi, in generale, parliamo dei soggetti che rivendicano il bisogno di formazione, di coloro che chiedono accesso alle competenze. Ma diamo per scontato che i lavoratori abbiano meno bisogno di formazione. Certo, ci sono i fondi interprofessionali, che questo tema continuano a riproporlo. Ma dentro le logiche di programmazione, dentro le logiche istituzionali, questa necessità non emerge con sufficiente forza.
Eppure, abbiamo milioni di lavoratori che non hanno fatto i conti con l’innovazione, che non stanno facendo quei conti ora. Loro quegli strumenti non li hanno. Non li hanno, e questa non è una questione astratta: è una questione di concreta attuazione. Viviamo in un mondo che si è frammentato, che si articola in luoghi piccoli, dispersi, sparpagliati. E in questa frammentazione riusciamo a vedere solo alcuni gap, mentre ne trascuriamo altri — come questo — che invece rappresentano una fragilità reale. Una fragilità legata all’impossibilità di partecipare, e dunque di sviluppare quello spirito critico che oggi è più necessario che mai.
Forse è proprio questo uno dei motivi fondamentali per cui serve un Forum come questo: perché ci troviamo a dover affrontare alcuni dei nodi più delicati, in uno dei punti di svolta in cui sbagliare l’impostazione può significare creare danni molto seri.
Possiamo essere ottimisti o pessimisti. Possiamo decidere che l’intelligenza artificiale è la nuova, straordinaria meraviglia del mondo, oppure che sia una disgrazia piovuta addosso senza sapere il perché. Ma una cosa è certa: l’intelligenza artificiale c’è. Attraversa tutto il lavoro che stiamo costruendo. Non possiamo far finta che non esista. Non possiamo saltarla. Dobbiamo farci i conti. Dobbiamo farci i conti, sì. E dobbiamo usarla, certo. Ma questo comporta una responsabilità enorme.
Perché, se davvero riconosciamo che dobbiamo confrontarci con l’intelligenza artificiale, allora dobbiamo essere consapevoli del peso che questo porta con sé. In questi tre giorni ci sono state affermazioni che mi hanno molto colpito.
Una in particolare mi ha profondamente preoccupata: l’idea — data per scontata — che potremo disimparare certe cose. Che sarà la macchina a farle al posto nostro. Ma smettere di fare delle cose non significa solo che non le facciamo più: significa che non le sappiamo più fare. E questo cambia tutto. Cambia il nostro cervello, cambia il nostro processo evolutivo, cambia gli uomini e le donne che costruiscono questo Paese.
Ecco perché, tra le grandi responsabilità che abbiamo oggi, c’è anche quella di proteggerci da ciò che rischia di sparire: parole che spariscono, gesti che spariscono, atti che spariscono. E con essi, ciò che più conta: la nostra capacità di immaginare. Per questo, prima di dare tutto per scontato, serve una riflessione profonda. Dialettica. Necessaria.
Mi piacerebbe concludere con una frase. Ne abbiamo cercata una anche nel nostro gruppo… ed è venuta fuori una frase che, in realtà, dice molto — e dice molto anche del nostro disorientamento: “Bisogna sempre partire dalle intelligenze naturali — perché non ce n’è una sola, ma tante — e la formazione è il nostro straordinario strumento per riconoscerle, valorizzarle e orientarle.”
Guarda l’intervento completo della Senatrice Susanna Camusso al Workshop di Capri 2025
clicca qui
Scopri le proposte per il futuro del lavoro e della formazione. Clicca qui per prenotare la tua copia del Libro Bianco 2025.