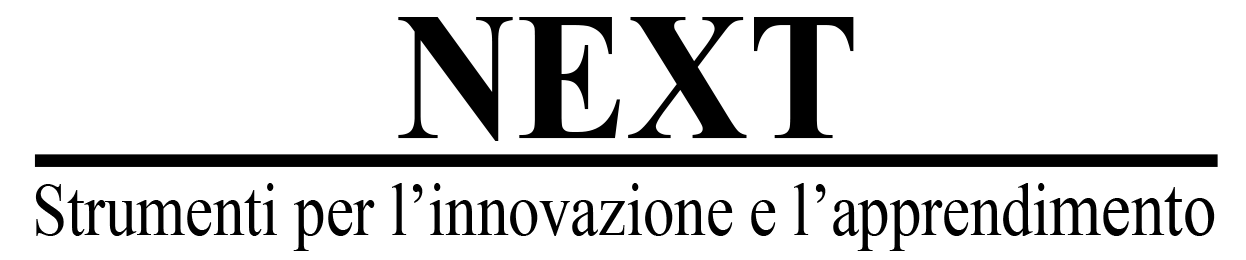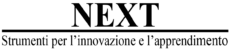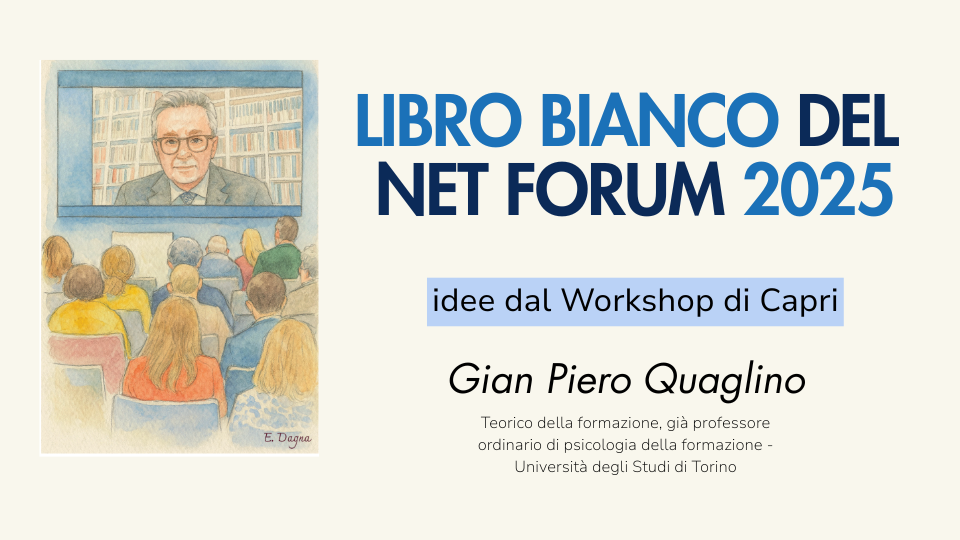Intervento di Gian Piero Quaglino al Workshop di Capri (15-16-17 maggio 2025)
Vi parlo da un luogo lontano, quasi simbolicamente remoto, vista la cornice tecnologica del tema che ci accompagna oggi. Vorrei avviare con voi una riflessione – per quanto breve – sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza naturale, e sul destino che potrebbe attendere la formazione in questo scenario in rapido mutamento.
Molto brevemente, potrei partire da un tempo remoto, perché la mia storia nella formazione inizia nella seconda metà degli anni Settanta. Per ragioni anagrafiche, dunque, si tratta di un percorso lungo … forse anche troppo. Se faccio un salto avanti di qualche decennio, posso dire che, dopo questo viaggio iniziato negli anni ’70 e protrattosi fino – potremmo dirlo con un po’ di enfasi – alla fine del secolo scorso, mi sono ritrovato, una ventina d’anni fa, in uno stato d’animo piuttosto demoralizzato rispetto al futuro della formazione.
Mi sembrava, all’epoca – ripeto, una ventina d’anni fa – che la formazione si fosse irrigidita su alcuni schemi predefiniti. Aveva, a mio avviso, scelto una strada di eccessiva semplificazione, sia nel modo di pensarsi sia nel modo di operare. Non parlerei propriamente di un processo di sclerotizzazione, ma certamente si avvertiva una preoccupante tendenza a riproporre modelli e metodi già noti, senza un vero investimento nell’innovazione.
Nello stesso periodo, cominciavano a emergere anche i primi segnali di quella rivoluzione tecnologica che avrebbe finito per investire anche il mondo della formazione: l’e-learning, la formazione a distanza, le prime piattaforme digitali. Non era ancora il tempo della realtà aumentata, che sarebbe arrivata di lì a poco, e certamente non era ancora il tempo dell’intelligenza artificiale così come la conosciamo oggi.
Accanto a questa sensazione, per certi versi sconsolata, di vedere la formazione perdere slancio sul piano dell’innovazione – ma anche della capacità di orientare i processi organizzativi o di proporre visioni sul cambiamento – si accompagnava un’altra preoccupazione, forse ancora più profonda.
Era il timore che l’avanzare della tecnologia potesse, se non sopprimere del tutto, quantomeno ferire in modo serio, forse irreversibile, la formazione. Un pensiero che oggi potremmo giudicare eccessivamente pessimista, ma che allora si imponeva con forza e urgenza.
Devo dire che, non essendo particolarmente incline alle tonalità depressive, nel giro di un paio d’anni ho fortunatamente cambiato prospettiva. Mi sono convinto, anzi, che fosse vero l’esatto contrario: quel rinnovamento che attendevo dalla formazione – in termini di energia, pensiero, creatività – e che avevo percepito come carente nell’ultimo periodo, avrebbe potuto essere proprio la tecnologia a stimolarlo.
E continuo a esserne convinto, per almeno un paio di ragioni che proverò a riassumere brevemente. Ma per farlo, devo tornare a un tempo ancora più remoto di quello della mia esperienza anagrafica.
Dovrei dire che, negli ultimi due o forse tre secoli, il nostro modo di pensare si è orientato verso una forma dominante: quella della razionalità. Un pensiero fondato sull’ordine, sulla logica, sulla costruzione lineare delle idee. Il che, intendiamoci, è un bene: ci ha permesso di raggiungere traguardi straordinari, di produrre le meraviglie di cui oggi disponiamo.
Tuttavia, questa impostazione ha avuto un piccolo effetto collaterale: ha finito per oscurare, o comunque trascurare, il fatto che la nostra intelligenza naturale non è fatta solo di rigore logico e pensiero analitico. Al contrario, è una dotazione molto più ricca e articolata di quella di qualunque altra specie.
Qualcuno ha parlato di intelligenze multiple, e credo si possa essere d’accordo: forse non possiamo dire con certezza quante siano – una decina, per restare sobri – ma certo non possiamo ridurre tutto al solo pensiero razionale. La nostra mente è capace di molteplici forme di pensiero, che andrebbero riconosciute e valorizzate.
Abbiamo, ad esempio, a disposizione forme di pensiero tutt’altro che lineari. Un pensiero divergente, come è stato definito, o associativo: capace di muoversi in modo fluido e imprevedibile, di vagare tra strade tortuose, sentieri poco battuti, luoghi oscuri. Un pensiero che ha il fascino della scoperta improvvisa, dell’incontro inaspettato.
Come è stato ricordato anche questa mattina, possiede il fascino del caso, dell’accadere fortuito — che a volte si rivela più interessante e fertile di ciò che era stato meticolosamente progettato.
E poi c’è il pensiero dell’immaginazione, della fantasia, della visione libera. Anch’esso genera conoscenza, produce idee, costruisce immagini. È la matrice profonda della creatività, in ogni sua forma: dall’arte all’innovazione, passando per le soluzioni più sorprendenti ai problemi più complessi.
Esiste anche un pensiero fatto di sensazioni, di impressioni, di eventi che ci attraversano e ci toccano, talvolta senza mediazioni, semplicemente perché li vediamo, li ascoltiamo, li percepiamo. È un pensiero che nasce dallo sguardo, dal suono, dal contatto con ciò che ci circonda.
E poi c’è il pensiero dell’intuizione: un lampo che improvvisamente si accende, senza che si sappia bene da dove provenga. Un “eureka” che irrompe nella mente senza preavviso, una scoperta istantanea che ci sorprende e ci guida. Anche se non ne conosciamo l’origine, è comunque qualcosa che appartiene alla nostra intelligenza naturale, ed è una risorsa preziosa che possiamo coltivare e utilizzare.
C’è anche un pensiero che nasce dal sentimento, un pensiero che potremmo chiamare “del cuore”, come lo definivano menti ben più autorevoli della mia. È un pensiero che sgorga spontaneamente dagli affetti che proviamo, che si nutre delle relazioni, della cura, dell’empatia, e che spesso guida le nostre riflessioni in modo profondo e autentico.
C’è anche un pensiero della narrazione, che forse è il più originario, il più profondamente umano. È quello che ci caratterizza e ci distingue: il bisogno di dare senso al mondo attraverso storie. Raccontare è il nostro modo naturale di pensare, che si tratti di un evento personale o di un concetto astratto, persino di una formula matematica. Qualunque contenuto, anche il più tecnico o arido, può essere trasmesso attraverso una storia, una parabola, una favola, una metafora. È questa la forza del pensiero narrativo.
Senza voler fare un elenco esaustivo, è evidente quanto sia ampia e articolata la nostra dotazione di modalità di pensiero, ben oltre la logica e l’ordine razionale. Una ricchezza che non possiamo permetterci di dimenticare, tanto meno oggi.
Il valore dell’intelligenza naturale
Tutto questo appartiene all’intelligenza naturale: una risorsa che la formazione non può ignorare, se vuole davvero contribuire a costruire il futuro.
La riflessione che possiamo trarre da tutto questo è che, se la formazione ha finito per assumere prevalentemente la forma del pensiero ordinato e razionale, forse dovremmo chiederci che cosa abbiamo perso per strada.
Forse abbiamo smesso di allenare — o almeno trascurato — quelle altre forme di pensiero di cui parlavo prima: il pensiero intuitivo, quello narrativo, il pensiero emozionale, immaginativo, sensoriale.
E questo è particolarmente rilevante se consideriamo che la formazione è, prima di tutto, una questione di apprendimento. E l’apprendimento, lo sappiamo, è ancora oggi un grande mistero, che non si lascia ridurre né spiegare completamente attraverso le sole lenti del pensiero lineare e razionale.
Si apprende per caso, per incidente, lungo percorsi spesso labirintici: l’apprendimento non segue sempre linee rette o prevedibili.
A volte impariamo perché qualcosa ci convince — per la chiarezza, la logica, l’ordine con cui è esposto. Altre volte, invece, apprendiamo perché qualcosa ci avvince: ci cattura, ci incuriosisce, risuona con la nostra storia personale, si innesta nella nostra esperienza, la riformula, ce la mostra da un’altra prospettiva.
Per questo, se l’apprendimento — che è il cuore della formazione — non è del tutto predeterminabile, allora la formazione può al massimo predisporre le condizioni perché qualcosa accada. Può favorire, provocare, risvegliare, ma non sempre può decidere a priori in quale forma il sapere prenderà vita dentro ciascuno di noi.
Allora, ciò che oggi si sta giocando nel rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza naturale potrebbe davvero rappresentare una grande opportunità.
Perché?
Perché se consideriamo che l’intelligenza artificiale è costruita essenzialmente attorno a quella forma di pensiero logico, ordinato, algoritmico di cui parlavo prima, allora potremmo concludere che una buona parte della formazione — quella che ancora oggi si limita alla trasmissione lineare di contenuti e saperi — potrebbe essere tranquillamente affidata alla tecnologia.
Non ci sarebbe più reale bisogno di un’intelligenza naturale, di un docente in carne e ossa che espone, trasferisce, trasmette: tutto questo potrebbe essere supportato — o addirittura sostituito — da strumenti digitali, piattaforme e sistemi automatizzati creati appositamente per questo scopo.
Questo, in fondo, rappresenterebbe un secondo vantaggio: liberare molto più spazio per tornare a valorizzare e coltivare i fili di una formazione basata sull’intelligenza naturale — quella che, a ben vedere, corrisponde con maggior precisione alla vera natura e vocazione della formazione stessa.
Qual è, infatti, la vera natura della formazione?
Sappiamo che la formazione ha a che fare con la costruzione di conoscenze e di saperi. Questo è, da sempre, il suo compito principale. Certo, oggi denominiamo queste conoscenze in modi diversi: le traduciamo nella formula delle competenze, che racchiude saperi più o meno specialistici, utili per affrontare mestieri, professioni, ruoli nei contesti organizzativi più vari.
Ma la formazione non è mai stata solo trasmissione di nozioni: la sua missione più profonda riguarda soprattutto un sapere incarnato, esperienziale. È quel saper fare, o meglio ancora, saper agire che accompagna la costruzione dell’identità professionale e personale. È qui che la formazione può esprimere il suo massimo potenziale.
E infine, per richiamare una triade ormai classica — nota sin dagli albori della riflessione pedagogica — accanto al sapere e al saper fare, occorre includere anche il saper essere. Si tratta della qualità delle relazioni, dei comportamenti, della capacità di stare con gli altri e di contribuire alla costruzione di legami significativi. È un aspetto essenziale nello sviluppo di ogni relazione, soprattutto quando si opera per il raggiungimento di obiettivi comuni, in una dimensione corale e, auspicabilmente, armoniosa.
Ho sempre pensato — e mi rendo conto che potrebbe suonare tautologico — che, al di là del sapere, del saper fare e del saper essere, il compito più profondo della formazione consista innanzitutto nel saper pensare. È il pensiero, infatti, che precede e orienta l’azione. È da lì che prende forma ogni apprendimento autentico. Perché possiamo insegnare molte cose, trasmettere saperi tecnici e costruire competenze operative anche solide, ma se tutto questo è sorretto da un pensiero fragile, confuso o povero, il rischio è di generare un saper fare privo di consapevolezza e di direzione.
In fondo, possiamo osservare che esistono molte cose fatte benissimo, che si sanno fare con grande competenza tecnica, ma che sono state pensate malissimo. Non è necessario fare esempi: ciascuno di noi ne conosce almeno uno. E se questo è vero, allora il compito più nobile della formazione dovrebbe essere proprio quello di riflettere sulle nostre dotazioni di pensiero, arricchirle al massimo, orientandole verso un uso consapevole e responsabile nei contesti in cui quel sapere si applica. Solo così la formazione può essere non solo efficace, utile e significativa, ma anche — in senso collettivo — necessaria e indispensabile.
Per questo vedo come auspicabile un’alleanza tra intelligenza artificiale e intelligenza naturale, a vantaggio della formazione. Un’alleanza che, alleggerendo una parte rilevante dei compiti formativi — dai contenuti più trasmissivi alla gestione dei materiali — possa liberare energie per coltivare ciò che è più profondamente umano: pensare, discernere, interpretare, scegliere.
In fondo, tutto questo si applica perfettamente anche all’iniziativa che ci vede coinvolti. Oggi, per certi obiettivi formativi, non è più strettamente necessario istituire lo spazio fisico dell’aula: esso può diventare uno spazio virtuale, uno spazio mediato dalla tecnologia. Lo abbiamo già sperimentato, del resto, con esiti interessanti.
Se l’obiettivo principale è l’aggiornamento, inteso non in senso riduttivo, ma come approfondimento, arricchimento, o acquisizione di nuove conoscenze su un tema in continua evoluzione, allora la formazione può tranquillamente affidarsi a modelli tecnologicamente mediati. Ma è proprio da qui che si apre una riflessione più ampia su che tipo di formazione vogliamo coltivare.
Tutto questo, in effetti, può essere tranquillamente alleggerito dalla fisicità che impone la presenza contemporanea di un certo numero di persone nello stesso spazio, con un docente chiamato – talvolta suo malgrado – a tenere una lunga lezione, spesso accompagnata da una sequenza altrettanto estesa di slide.
Questo modello tradizionale, che ha dominato per molto tempo, oggi non è più necessario. Possiamo affidarci ad altre modalità, più leggere, più agili, più coerenti con i bisogni e i tempi di apprendimento contemporanei.
Non c’è più nemmeno bisogno, verrebbe da dire, dell’intervento umano in queste situazioni. Anzi, si apre uno spazio nuovo, in cui il tempo dell’apprendimento non è più fisso né imposto, ma diventa flessibile e personale: ciascuno può dettarlo e modularlo secondo le proprie esigenze, scegliendo quando e come dedicarsi a ciò che desidera apprendere.
E mentre questa parte della formazione – più standardizzata, più “ingegnerizzata”, diremmo oggi – si sviluppa in autonomia, accade qualcos’altro…
A quel punto, la formazione può tornare ad assumere il suo compito più nobile: lavorare con le persone, sui loro pensieri, attivando tutte le forme di intelligenza a nostra disposizione. Lavorare con l’immaginazione, con le sensazioni, con i sentimenti.
Non serve necessariamente un contenuto specialistico per fare formazione: si può apprendere qualunque cosa anche a partire da altro, perché l’apprendimento – quello vero – nasce spesso dallo scarto, dalla deviazione, dalla risonanza inattesa tra ciò che ci si propone e ciò che già abita dentro di noi.
Naturalmente, tutto dipende dal tipo di apprendimento che si riesce ad attivare, dal “gioco” formativo che si costruisce, e da quello spazio che resta insostituibile, irriducibile, indispensabile: lo spazio condiviso dell’esperienza, in cui per un tempo – breve o lungo – le persone si trovano insieme.
Poi ciascuno andrà per la propria strada, certo. Ma è proprio in quel momento condiviso, in quell’occasione unica di contatto e relazione, che qualcosa comincia ad accadere.
E qui mi avvio alla conclusione, ricordando un altro fatto noto (ma ancora oggi poco spiegabile): l’apprendimento, spesso, inizia senza una ragione precisa, in modo inatteso, misterioso persino.
Il vero valore di un corso
Si comincia davvero ad apprendere solo quando un corso è finito.
Durante il corso si ascolta, si prendono appunti, si riflette, si ragiona. Si attivano connessioni, ciascuno secondo il proprio modo di pensare, secondo la propria storia personale e le esperienze formative precedenti. Ma, in fondo, ognuno viaggia per conto proprio.
Poi accade qualcosa.
Se il tema affrontato ha davvero colpito nel segno – se ha stimolato, incuriosito, mosso qualcosa dentro – allora si verifica quel momento tanto sottile quanto decisivo: il ripensamento a posteriori.
Si torna su ciò che si è ascoltato, su ciò che si è pensato. Lo si rielabora. E lì, in quel movimento interiore che avviene dopo, comincia il vero apprendimento.
È proprio questo che rappresenta il vero apprendimento. Ed è questo che continuerà a rappresentarlo in futuro.
Ogni attività formativa, ogni contenuto offerto durante un corso o un seminario, viene proposto a persone diverse, che non sono affatto contenitori vuoti da riempire.
Ciascuno porta con sé un proprio bagaglio di sapere: una formazione pregressa, esplicita o implicita, occasionale o sistematica, formale o informale. Una formazione che è frutto dell’esperienza, maturata nel tempo.
È con questo patrimonio individuale che il nuovo contenuto entra in relazione.
E proprio nell’interazione tra ciò che si offre come tema del corso e la storia personale di ciascuno rispetto a quell’argomento — nel modo in cui ciascuno lo ha incontrato, elaborato, vissuto — nasce l’apprendimento.
Un processo che ha quasi del misterioso, dell’alchemico, e che non può essere pienamente programmato, ma solo favorito, evocato, reso possibile.
E poi, soprattutto, c’è quell’apprendimento continuo che proseguirà anche dopo la fine del corso, una volta che il tempo formale dell’aula si sarà concluso.
È lì che comincia, spesso, il vero apprendimento: quando ciascuno ripensa, rielabora, connette quanto emerso con la propria esperienza e con ciò che è pronto a diventare.
Per questo, in chiusura, posso dire che oggi guardo all’intelligenza artificiale — che rappresenta l’ultima, potente espressione della rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo — con uno sguardo molto più positivo rispetto a qualche tempo fa.
Non solo non la temo, ma ne riconosco il valore trasformativo.
Credo anzi che proprio nel confronto con l’intelligenza artificiale, la formazione possa ritrovare le sue vie più autentiche. Quelle della curiosità, dell’incontro, dell’immaginazione, piuttosto che solo quelle della tecnica e dell’addestramento. E poi ci sono le strade della pazienza, che sappiamo essere indispensabili per ogni vero apprendimento.
Perché, spesso, ciò che ci viene offerto in un tempo breve – un corso, un seminario, una lezione – richiede molto più tempo per essere realmente compreso, elaborato, interiorizzato. A volte, serve un tempo più lungo, un tempo silenzioso, fatto di meditazione, di rilettura, di sedimentazione. Un tempo che non può essere né previsto né accelerato.
E allora sì, posso dire con convinzione che l’intelligenza artificiale, anziché mortificare la formazione, può rappresentare un’opportunità per ritrovarne l’anima. Perché può alleggerirla da ciò che può essere delegato alle macchine, restituendole il compito più alto di stimolare, coltivare, far crescere il sapere — quel sapere personale, vivo, complesso, in continua evoluzione che è l’espressione più profonda della nostra intelligenza naturale.
E forse, proprio per questo, anche del nostro futuro.
Guarda l’intervento completo di Gian Piero Quaglino al Workshop di Capri 2025.
Clicca qui
Scopri le proposte per il futuro del lavoro e della formazione. Clicca qui per prenotare la tua copia del Libro Bianco 2025.