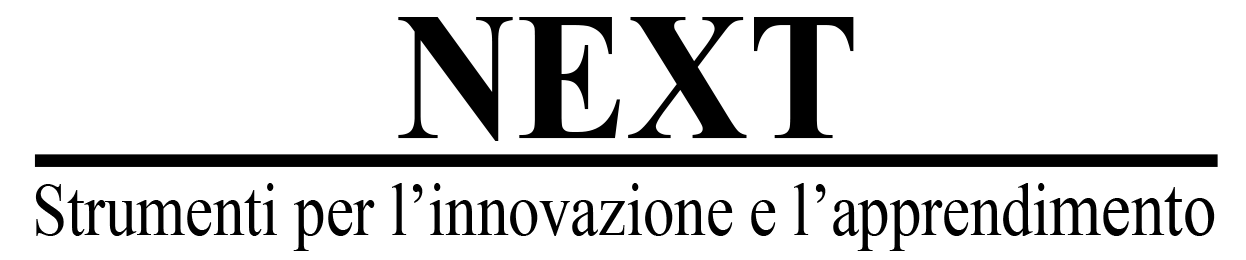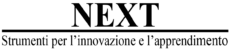Intervento di Vincenzo Caridi al Workshop di Capri (15-16-17 maggio 2025)
Vorrei aprire il mio intervento con un’affermazione che si legge o si sente ripetere spesso: «L’intelligenza artificiale è stupida». Una provocazione che condivido in parte. La riformulerei così: a volte l’intelligenza artificiale è stupida, così come, a volte, lo è anche l’intelligenza naturale. Dico “a volte sì, a volte no” — sia per l’intelligenza artificiale che per quella naturale — perché è evidente che ci troviamo in un momento storico profondamente diverso rispetto al passato. Non rendersene conto significa, per un Paese come l’Italia, condannarsi. L’Italia, terzultima in Europa per investimenti in ricerca, deve invertire questa tendenza per restare competitiva»
Condannarsi a cosa? A salari bassi — e lo dico da Capo Dipartimento del Lavoro. A un mercato del lavoro povero. A un sistema formativo che fatica a formare le persone con le competenze realmente richieste dalle imprese. Abbiamo un mismatch che ormai sfiora il 50%. Solo pochi anni fa era al 27%.[da confermare] Significa anche accettare una forza lavoro che, anno dopo anno, si riduce in termini assoluti. Ci condanna anche alla denatalità — un fenomeno che non dipende da qualcuno in particolare, ma che è certamente legato alla crescente difficoltà di mettere al mondo dei figli in una società sempre più individualistica.
Ma allora, perché non cogliere l’opportunità di fare dell’intelligenza artificiale un vero supporto? A condizione, però, che sia governata dall’intelligenza umana, da quella naturale.
E invece non investiamo. Lo sappiamo tutti: l’Italia è tra gli ultimi Paesi in Europa per investimenti in ricerca e innovazione. Siamo terzultimi, con un investimento pari all’1,31% [da confermare] del PIL. Peggio di noi solo la Grecia e l’Ungheria. È evidente che, se vogliamo essere competitivi come Paese, dobbiamo investire in innovazione e ricerca. Ma non basta. È necessario investire anche in un sistema affinché le cose si possano fare insieme. Ecco, questo è il punto. Quando si parla di formazione, bisogna parlare anche di orientamento; quando si parla di lavoro, bisogna parlare anche di previdenza. Tutto deve avvenire in maniera integrata, fin dall’inizio.
Solo così, probabilmente, l’Italia potrà trovare la propria strada. Una strada che non può — e non deve — essere esclusivamente tecnologica. Perché la tecnologia, come è stato giustamente ricordato, è uno strumento. Nulla di più.
Oggi abbiamo l’opportunità di fare in modo che l’intelligenza artificiale diventi realmente uno strumento integrato nei processi, un mezzo al servizio delle attività svolte dall’uomo.
Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro
C’è un nodo urgente da sciogliere: il 50% del mismatch tra domanda e offerta di lavoro. È un problema strutturale, che va affrontato in maniera radicale. E con radicalità non intendo solo maggiore impegno o attenzione: serve un cambiamento di prospettiva, un intervento sistemico.
In questi ultimi tempi siamo riusciti a rafforzare la filiera del lavoro: dalle Regioni al Ministero dell’Istruzione e del Merito, al Ministero dell’Università e della Ricerca. Ma non basta. Dobbiamo coinvolgere anche i privati, ricordando naturalmente il ruolo fondamentale dei Fondi e degli enti di formazione. Serve un ragionamento collettivo, un’alleanza che ci veda coprotagonisti nella progettazione di attività concrete, mirate a raggiungere obiettivi condivisi e misurabili. L’obiettivo deve essere chiaro: formare persone con le competenze necessarie oggi e nel breve periodo, in linea con i reali bisogni del sistema produttivo. Se non riusciamo a farlo, parlare di occupazione rischia di diventare sterile.
È vero, oggi abbiamo raggiunto un record storico di occupati, oltre 24 milioni di persone. Ma è altrettanto vero che il tema del salario povero è sempre più centrale: lo dicono i dati ISTAT. I salari, pur in lieve crescita, non sono cresciuti quanto l’inflazione, e quindi in termini reali si sono ridotti.
È un paradosso: crescono le entrate fiscali, ma diminuisce il potere d’acquisto dei lavoratori, e ciò ha effetti sociali ed economici che non possiamo ignorare. Abbiamo salari bassi, un livello di occupazione al massimo storico, eppure non riusciamo ad aumentare la produttività né a essere realmente competitivi con gli altri Paesi. Questo è il nodo strutturale su cui dobbiamo intervenire. Ecco perché l’uso dell’intelligenza artificiale non deve essere demonizzato. Al contrario, va pienamente integrato come strumento strategico per rilanciare competitività e innovazione.
Naturalmente, non mi riferisco solo all’intelligenza artificiale di calcolo, agli algoritmi predittivi ormai consolidati. Oggi siamo nel pieno dell’era dell’intelligenza artificiale generativa. Si comincia perfino ad affrontare il tema dell’intelligenza artificiale generale, anche se c’è timore a nominarla esplicitamente. Non si parla ancora di coscienza artificiale, ma si stanno sviluppando avatar in grado di riprodurre il comportamento e la voce di una persona, come Vincenzo Caridi o chiunque altro, con performance potenzialmente migliori in alcuni compiti specifici.
Questo scenario ci impone di governare la trasformazione, non subirla, e di cogliere tutte le opportunità per rendere la macchina pubblica, il sistema educativo e quello produttivo più coesi, moderni e funzionali. Non è affatto una cosa negativa se Vincenzo Caridi riesce a governare il proprio avatar. Al contrario, è un’opportunità. L’importante è che l’elemento umano resti al centro, in una logica di governo consapevole e responsabile delle tecnologie. L’intelligenza artificiale deve essere un supporto, non un sostituto.
Cosa sta facendo il Ministero del Lavoro in questa direzione? Intanto, per la prima volta – o comunque in modo più sistematico – sta dialogando in chiave di coprogettazione con tutti gli enti che gravitano attorno alla sua sfera di competenza, come Sviluppo Lavoro Italia, INAPP e INPS. Questo dialogo riguarda la definizione condivisa dei servizi, delle priorità, delle azioni concrete da mettere in campo.
Ma non è sufficiente. È indispensabile coinvolgere anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca, e soprattutto le Regioni, per costruire un sistema integrato che tenga insieme formazione, orientamento, politiche attive e sviluppo territoriale.
Infine, è fondamentale rafforzare il ruolo dell’elemento umano nell’orientamento, nell’accompagnamento, nelle politiche di attivazione che richiedono presenza, ascolto, relazione, fiducia. Nessuna intelligenza artificiale potrà sostituire questa dimensione. Al massimo, potrà potenziarla, se usata bene.
I Centri per l’Impiego come centro della relazione umana
Credo che uno degli sforzi più importanti che stiamo portando avanti in questo periodo – soprattutto con le Regioni – sia quello di riportare i Centri per l’Impiego al centro della relazione umana nel sistema delle politiche attive del lavoro. Vogliamo che diventino presìdi di prossimità, capaci di accogliere, orientare, accompagnare concretamente le persone.
Accanto a questa azione di rafforzamento del ruolo umano dei servizi pubblici per l’impiego, stiamo lavorando per costruire una vera coprogettazione sistemica che coinvolga in modo integrato gli enti di formazione, le agenzie per il lavoro, le università, tutti attori chiave per un disegno di innovazione e ricerca condivisa. Solo unendo le forze tra pubblico e privato, tra istituzioni e territori, possiamo costruire un sistema capace di rispondere in maniera efficace e tempestiva ai nuovi bisogni delle persone e delle imprese
È questo il progetto – anzi, i progetti – che stiamo portando avanti con determinazione. Progetti che mettono al centro le persone, a partire dai giovani, perché non possiamo più permetterci una disoccupazione giovanile come quella attuale: siamo tra gli ultimi in Europa, e il dato è oggettivamente allarmante. A ciò si aggiunge il tasso di disoccupazione femminile, che ci vede purtroppo all’ultimo posto nel contesto europeo. E questo nonostante l’occupazione generale sia ai massimi storici degli ultimi trent’anni.
Il Ministero del Lavoro, oggi, ha preso pienamente coscienza di questa sfida. Lo stiamo facendo insieme ai colleghi di Sviluppo Lavoro Italia, di INAPP e con tutti i partner istituzionali e privati, per avviare una vera attività di coprogettazione delle azioni necessarie a risolvere questi problemi strutturali.
Perché l’analisi la conosciamo bene: occupazione giovanile critica, presenza di NEET – giovani che non studiano, non lavorano, non si formano – e un tessuto produttivo che ha bisogno di competenze nuove. Ma è proprio su questa consapevolezza condivisa che possiamo costruire politiche attive efficaci, con strumenti e percorsi su misura, capaci di ricostruire un ponte tra giovani e lavoro, tra formazione e impresa.
Che cosa si può fare, dunque, in modo concreto?
Prima di tutto, mettere a fattor comune le banche dati. E proprio in questa direzione è importante segnalare che proprio ieri, insieme alla collega della Direzione Generale del Ministero del Lavoro, abbiamo concluso il testo di una convenzione tra INPS, Ministero del Lavoro, MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) e MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca). Questa convenzione ha un obiettivo chiaro: mettere in rete le banche dati rilevanti per intercettare i giovani NEET, quei giovani che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. Oggi si stima che siano oltre due milioni in Italia, forse anche di più.
Conoscere è il primo passo per agire. E unendo queste informazioni, riusciamo finalmente a identificarli e raggiungerli con precisione. Ma questo non basta: una volta intercettati, dobbiamo essere in grado di offrire loro qualcosa di concreto, ovvero informazioni chiare, qualificate, su percorsi formativi, orientamento, lavoro e opportunità reali. Solo così possiamo avviare un processo di inclusione autentico e strutturato, che traduca l’analisi in azione.
Gli attori del Net Forum
Qui che entrano in gioco gli attori del Net Forum. Come si fa a comprendere quali sono le competenze realmente richieste dalle imprese per essere competitive e aumentare la produttività? Oggi abbiamo a disposizione una grande quantità di banche dati: quelle di Excelsior, dell’INPS, del Ministero del Lavoro, dell’INAPP, di Sviluppo Lavoro Italia, e molte altre ancora. Ma i dati da soli non bastano. Se non vengono letti correttamente, se non sono parte di un progetto strutturato con obiettivi chiari, non servono a nulla. Ed è proprio qui che si colloca il progetto che stiamo sviluppando per i NEET attraverso la convenzione di cui parlavo prima. L’obiettivo è intercettare queste persone e indirizzarle verso percorsi di attivazione, sia attraverso le politiche attive delle Regioni, sia attraverso la formazione, sia tramite l’incrocio mirato con opportunità occupazionali concrete.
In questo processo, la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti – istituzioni, enti formativi, agenzie del lavoro, stakeholder territoriali – è cruciale. Solo così possiamo trasformare i dati in azione, e l’azione in risultati. Nella precedente edizione di Net Forum accennai al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa – una piattaforma strategica sviluppata dal Ministero del Lavoro e realizzata da INPS. Questa piattaforma è nata con un obiettivo ben preciso: favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a partire dalla gestione degli ex percettori del Reddito di Cittadinanza, offrendo loro strumenti come l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Attiva da settembre 2023, nel tempo ha progressivamente ampliato la propria platea. A novembre 2024, ha iniziato a includere anche i disoccupati che escono dal mercato del lavoro per ragioni spesso indipendenti dalla loro volontà. E da gennaio 2025, il sistema è stato aperto a tutti i cittadini, diventando così un vero e proprio strumento universale di inclusione lavorativa.
Ma c’è un problema, ed è giusto evidenziarlo per affrontarlo insieme: il sistema da solo non basta. Serve che tutti gli attori coinvolti – centri per l’impiego, enti formativi, aziende, agenzie per il lavoro – lo riconoscano come infrastruttura comune e strategica, lo utilizzino concretamente e ne alimentino il funzionamento. Solo così il Sistema Informativo per l’Inclusione potrà realizzare pienamente la sua missione: accompagnare le persone, in modo personalizzato e mirato, verso il reinserimento sociale e lavorativo. Il problema, naturalmente, è che il sistema per funzionare ha bisogno di essere alimentato: devono esserci i dati, i curricula dei soggetti che man mano vengono inseriti nella piattaforma, e devono esserci i posti di lavoro, le offerte effettive, che devono essere caricate dalle aziende.
Ad oggi, sono i centri per l’impiego e le agenzie per il lavoro a poter inserire le vacancy. Ma, da gennaio, anche le singole aziende possono farlo. Tuttavia, convincere ogni singola impresa a utilizzare questo canale è un lavoro complesso e impegnativo.
Per facilitare questo processo, il Ministero del Lavoro ha siglato accordi con i principali aggregatori di offerte di lavoro, come Job rapido e Jooble; è stato già concluso un accordo con Zuna e a breve ne seguirà uno con Indeed. Questi aggregatori forniscono al sistema – e quindi all’intelligenza artificiale che lo alimenta – un flusso continuo di offerte di lavoro. In questo modo, il sistema sarà in grado di proporre all’utente non solo opportunità lavorative, ma anche eventuali percorsi formativi da intraprendere per raggiungere il livello di competenze richiesto per quei ruoli. È un passo importante per costruire un ponte concreto tra formazione e occupazione, sostenuto da una infrastruttura digitale e intelligente.
Perché ho parlato del SISL? Perché l’evoluzione naturale del SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa è quella di diventare uno strumento capace di supportare diverse categorie di utenti, a partire dai Neet, ma non solo. Possono beneficiarne anche coloro che già lavorano, ed è proprio qui che si apre un altro grande tema: la formazione continua. Perché è evidente che le competenze richieste nel nuovo mercato del lavoro – in continua trasformazione per effetto dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale – non riguardano solo chi cerca un impiego, ma anche chi già è occupato.
Il rischio altrimenti è di trovarsi rapidamente con competenze obsolete, e dunque è fondamentale aggiornare e mantenere nel tempo le professionalità già presenti nel mondo del lavoro. Anche su questo versante, il SIISL può rappresentare una piattaforma utile a indirizzare percorsi formativi mirati e tempestivi, sostenendo realmente l’occupabilità e la competitività del sistema Paese. C’è quindi un problema che riguarda anche il mantenimento del posto di lavoro da parte di chi è già occupato, in relazione all’evoluzione delle competenze richieste dalle imprese per restare competitive.
E allora, proprio qui l’intelligenza artificiale può offrire un contributo significativo. Vado verso la conclusione sottolineando che non si tratta di sostituire l’orientatore umano, figura comunque centrale nel processo di accompagnamento al lavoro, ma di fornirgli uno strumento in più. L’orientatore umano, infatti, può essere supportato da un sistema di intelligenza artificiale capace di analizzare non solo quanto indicato in un curriculum, ma anche di dialogare con l’utente – che sia un Neet, un disoccupato o un lavoratore in cerca di riqualificazione – per individuare un percorso formativo personalizzato, costruito sulle aspettative, sulle potenzialità e sulle esigenze reali del singolo.
L’intelligenza artificiale, dunque, può anche offrire un orientamento personalizzato, suggerendo possibili posizioni lavorative in linea con le competenze e le aspirazioni del candidato. Stiamo lavorando in questa direzione e prevediamo la costituzione di un gruppo di lavoro che includa le professionalità delle agenzie formative, dei servizi per l’impiego e anche degli psicologi dell’orientamento, per elaborare un modello capace di accompagnare le persone in modo efficace.
Le difficoltà dell’orientamento post – scolastico
Oggi, l’orientamento post-scolastico mostra dei limiti evidenti: spesso non riesce a intercettare i bisogni reali del giovane appena uscito dal percorso di studi, né a indicargli un percorso chiaro e coerente.
Per superare questa difficoltà, servono informazioni, dati e strumenti capaci di mappare i mestieri e le professioni realmente richiesti dal sistema produttivo. Le banche dati ci permettono oggi di fare questo. Così, anche chi non ha ancora le idee chiare sul proprio futuro professionale può essere messo in condizione di seguire un percorso formativo mirato, che lo renda competitivo e pronto ad assumere una posizione lavorativa concreta.
Vorrei concludere questo intervento presentando l’Osservatorio per la prevenzione dei rischi legati all’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro: sul sito del Ministero del Lavoro, attualemte, c’è una versione beta, già accessibile, che ha l’obiettivo di offrire uno strumento utile ai cittadini, alle aziende e a tutti gli stakeholder. All’interno dell’Osservatorio ci sono anche le Linee guida sull’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, ancora non firmate dal Ministro perché attualmente è in corso una fase di confronto e condivisione con tutte le parti interessate.
Concludendo credo che sia evidente il fatto che al Ministero del Lavoro crediamo fortemente che dal dialogo aperto e trasparente possano nascere strumenti migliori. Per questo, ogni contributo sarà utile a rendere l’ecosistema del lavoro più solido, inclusivo con soluzioni concretamente applicabili.
Rapporto tra politica e tecnostruttura
In qualità di tecnico, sento la responsabilità e l’opportunità di trasferire al decisore politico tutto ciò che ho ascoltato in questi tre giorni di confronto. Ho seguito con grande attenzione gli interventi, le riflessioni e le esperienze condivise, e porto con me una convinzione molto chiara: le politiche attive del lavoro in Italia devono cambiare.
Questo messaggio, con tutte le sue sfumature e sollecitazioni, lo riporterò con trasparenza al Ministro, al Sottosegretario e al Viceministro. Le politiche attive devono cambiare perché devono sapersi adeguare ai tempi. La normativa attualmente in vigore in materia di politiche attive del lavoro risale a circa dieci anni fa: un periodo in cui non avevamo ancora vissuto la pandemia, l’intelligenza artificiale non era uno strumento diffuso, e quella generativa semplicemente non esisteva.
Anche il contesto sociale era profondamente diverso da quello che viviamo oggi: più lineare, meno complesso, meno esposto alle tensioni demografiche, tecnologiche e occupazionali attuali.
Credo che, come Ministero del Lavoro, abbiamo oggi un dovere preciso: non arrivare dopo, ma, se possibile, concorrere attivamente – se non addirittura anticipare – il governo dei cambiamenti in atto.
In questi giorni si è parlato molto del governo dell’intelligenza artificiale, ma occorre chiarirne il significato: che cosa vuol dire, concretamente, governare l’IA? Qualcuno ha ricordato che a livello europeo esiste una regolamentazione: il nuovo AI Act. Inoltre, in Italia, è attualmente all’esame del Senato un disegno di legge sull’intelligenza artificiale, che contiene un articolo di straordinaria rilevanza, destinato a incidere direttamente sull’attuazione concreta di questi principi nel nostro Paese. L’articolo 11 di questo disegno di legge prevede l’istituzione di un Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di preparare cittadini, aziende e istituzioni ad affrontare le implicazioni dell’IA nei processi produttivi.
Abbiamo avuto modo, in questi giorni, di ascoltare testimonianze virtuose da parte di alcune imprese, che hanno dimostrato come – indipendentemente dalla presenza di una normativa specifica – si siano già poste concretamente il problema dell’impatto dell’intelligenza artificiale, non come un’innovazione episodica o occasionale, ma come un elemento strutturale capace di influenzare in profondità i processi produttivi e gestionali.
In un intervento precedente ho già avuto modo di menzionarlo, ma lo ribadisco: invito tutti a visitare il sito del Ministero del Lavoro, dove è disponibile una versione beta dell’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro. Si tratta di uno strumento prezioso che riguarda tutti noi: cittadini, imprese, operatori del settore. L’Osservatorio ci aiuta a comprendere come cambiano i mestieri, quali sono le competenze richieste oggi e, soprattutto, come orientarci in un mercato del lavoro che l’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente. Il tutto è affiancato dalle linee guida sull’impatto dell’IA nel lavoro, che offrono ulteriori elementi di riflessione e indirizzo.
Tutte le aziende possono già oggi consultare l’Osservatorio, che al momento si trova nella fase di consultazione pubblica. Una volta conclusa la valutazione, che verrà effettuata insieme a numerosi altri stakeholder, le linee guida sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro saranno ufficialmente emanate.
Spetta quindi a ciascuno di noi – istituzioni, imprese, cittadini – informarsi, leggere e utilizzare consapevolmente questi strumenti, che ci permettono di essere conformi a un uso etico e responsabile dell’intelligenza artificiale, come più volte è stato auspicato anche in questo contesto.
Io però ritengo importante riportare al decisore politico la necessità di avviare una riflessione strutturata sulle politiche attive del lavoro, perché è ormai evidente che una loro riforma è imprescindibile. Questa riforma non deve mettere in discussione gli strumenti che hanno già dimostrato di funzionare e di essere efficaci – quelli vanno preservati e valorizzati – ma deve concentrarsi su ciò che oggi manca, su ciò che non è più adeguato al contesto attuale, profondamente trasformato rispetto a dieci anni fa. Ad esempio, è emersa con forza – e più volte richiamata oggi – l’esigenza di una governance interistituzionale e multilivello. Una convinzione che personalmente mi porto dietro da questi giorni è che da soli, con le migliori intenzioni, non si riesce a costruire un cambiamento efficace. Credo che anche molti di voi condividano questa consapevolezza.
Lavorare insieme è una necessità, non un’opzione!
Ma perché questo accada in modo strutturato ed efficace, serve una governance che coinvolga realmente tutti gli attori istituzionali, a tutti i livelli, e che consenta un’integrazione reale delle politiche e delle azioni. Se parliamo di interoperabilità delle banche dati, ad esempio, è evidente che ciò è possibile solo attraverso una governance condivisa e rinnovata. Una governance che superi le frammentazioni, che valorizzi le responsabilità, e che renda possibile un’effettiva coprogettazione tra Ministeri, Regioni, Enti attuatori, sistema educativo e attori del mondo del lavoro.
Il mio impegno, come capo del Dipartimento che dirigo, è certamente quello di contribuire in modo concreto alla riflessione su una possibile riforma delle politiche attive del lavoro. È un obiettivo che considero prioritario, e intendo tradurlo in una proposta operativa da sottoporre al decisore politico entro tempi molto stretti. Naturalmente, sarà poi il decisore politico a valutarla, con la piena autonomia e responsabilità che gli competono.
La riforma delle politiche attive dovrà necessariamente coinvolgere tutti gli attori istituzionali e operativi. In questo quadro, vorrei soffermarmi brevemente anche sul Fondo Nuove Competenze. Lo strumento ha dimostrato una forte capacità attrattiva: la domanda di finanziamento ha largamente superato la disponibilità di risorse, segno evidente che c’è un grande interesse da parte del tessuto produttivo e formativo nazionale. Questo è un dato positivo, ma allo stesso tempo pone l’urgenza di valutare un ampliamento delle risorse disponibili, anche in tempi brevi, per poter rispondere adeguatamente alla domanda espressa da imprese e lavoratori.
Un’altra riflessione riguarda il divario occupazionale tra Nord e Sud del Paese.
In particolare, nel Mezzogiorno si registra una quota rilevante di disoccupati di lungo periodo, persone che hanno perso progressivamente contatto con il mondo del lavoro e con le competenze richieste oggi dal mercato. Questa situazione rende evidente che non si può applicare indistintamente un’unica tipologia di misura: serve un intervento mirato, capace di rispondere alle esigenze specifiche di una disoccupazione più strutturale e radicata, come quella che riguarda ampie fasce della popolazione meridionale.
La differenziazione delle misure in base alle caratteristiche dei disoccupati – ad esempio tra chi ha perso il lavoro recentemente e chi invece è escluso da lungo tempo – è un elemento che intendiamo portare al centro della programmazione. Stiamo già valutando, con i colleghi del Ministero e delle Regioni, la possibilità di attivare progettualità specifiche per favorire il reinserimento lavorativo di questi cittadini, tenendo conto delle reali condizioni di partenza e della necessità di un accompagnamento più intenso e personalizzato.
È vero che la disoccupazione di lungo periodo nel Mezzogiorno può celare anche fenomeni distorsivi che vanno affrontati e corretti. Tuttavia, gli ultimi dati ci offrono un segnale incoraggiante: in termini percentuali, l’incremento dell’occupazione è stato più marcato al Sud rispetto al Centro e al Nord. Un dato che ci fa ben sperare e che va sostenuto con misure mirate e continue. Questo conferma e rafforza l’idea che servano strumenti incentivanti: ad esempio, da ieri – 16 del mese – sono disponibili i moduli per le imprese che vogliono richiedere i bonus occupazionali per giovani e donne. Si tratta di incentivi contributivi significativi: per l’assunzione di giovani, è previsto un bonus di 500 euro mensili su tutto il territorio nazionale mentre, per le regioni del Mezzogiorno, il bonus sale a 650 euro mensili. Un contributo importante, soprattutto se consideriamo il livello medio delle retribuzioni in Italia.
Tuttavia, voglio sottolinearlo con forza: la strategia non può limitarsi a premiare chi assume. L’esperienza ci dimostra che questo da solo non basta. Serve un’azione più ampia, strutturata e integrata, che accompagni gli incentivi con politiche attive solide, orientamento efficace, formazione mirata e governance condivisa. Se vogliamo promuovere un’occupazione di qualità, dobbiamo necessariamente ragionare in un’ottica integrata, puntando con decisione su formazione, accompagnamento, orientamento. Investire su questi ambiti non è un’opzione accessoria, ma un elemento essenziale per la costruzione di un sistema del lavoro moderno ed efficace.
Vorrei ricordare anche quanto emerso durante la precedente edizione del Net Forum. Da quell’edizione sono scaturite alcune proposte di miglioramento che abbiamo voluto recepire e sviluppare in questa terza edizione. In particolare, ha riscosso grande interesse l’idea di ragionare per “sistemi”, come anche è stato ben illustrato nelle presentazioni dei colleghi che mi hanno preceduto: un approccio per filiere produttive e per imprese, capace di connettere le diverse componenti del mondo del lavoro in una logica integrata.
Un altro spunto molto significativo è stata l’esigenza, espressa in modo chiaro dalle imprese, di fidelizzare i potenziali nuovi assunti attraverso percorsi di formazione pre-assuntiva. L’obiettivo è favorire l’incontro tra domanda e offerta non soltanto tramite la selezione, ma tramite un investimento formativo mirato già prima dell’inserimento lavorativo, aumentando così le probabilità di un’assunzione stabile.
In questa terza edizione, infatti, abbiamo voluto ampliare la possibilità di coinvolgere anche persone che non sono ancora occupate, ma che le imprese hanno interesse ad assumere. Una scelta strategica, che va nella direzione di rendere la formazione uno strumento realmente attivo e funzionale alla costruzione di nuove competenze, in coerenza con i fabbisogni aziendali e territoriali.
Ci sono stati alcuni elementi, minimi ma comunque significativi, di evoluzione tra la prima e la seconda edizione del Fondo Nuove Competenze. È un processo di progressivo miglioramento che stiamo portando avanti, anche in collaborazione con il Ministero e con Sviluppo Lavoro Italia, e che intendiamo consolidare attraverso un confronto strutturato con i fondi interprofessionali.
È vero che il tema delle competenze è stato al centro delle discussioni, ma è altrettanto vero che abbiamo avviato – già prima della pubblicazione del bando – un dialogo attivo con i fondi interprofessionali, che voglio qui ricordare e valorizzare. Questo lavoro preparatorio ci ha permesso di calibrare meglio lo strumento e raccogliere preziose indicazioni dal territorio.
Oggi dobbiamo guardare oltre: non limitarsi a una “quarta edizione” del Fondo Nuove Competenze, ma puntare a renderlo uno strumento strutturale. Per farlo, tuttavia, sarà necessario intervenire sulla normativa di riferimento, che risale al 2020 – un periodo emergenziale, in piena pandemia – e che richiede ora un adeguamento per rispondere a un contesto economico, sociale e tecnologico profondamente mutato.
Abbiamo il tempo e la volontà per costruire un impianto normativo e gestionale solido, che permetta al Fondo di diventare parte stabile delle politiche attive del lavoro, al servizio della competitività delle imprese e della crescita delle competenze dei lavoratori.
I risultati dell’ultima edizione del Fondo Nuove Competenze
Sulla base dei dati dell’ultima edizione del Fondo Nuove Competenze – insieme a quelli raccolti nelle precedenti edizioni – ci confronteremo per capire come lo strumento possa essere migliorato. Tuttavia, già oggi appare evidente la necessità di intervenire sulla norma istitutiva del Fondo, anche per superare alcune rigidità che sono emerse chiaramente. Quelle che abbiamo di fronte non sono solo rigidità burocratiche, ma veri e propri elementi di contesto che dobbiamo saper ascoltare, perché il mondo del lavoro sta cambiando in profondità. E se cambia il lavoro, devono cambiare anche gli strumenti a supporto della formazione e dell’occupabilità, naturalmente nel pieno rispetto delle garanzie da assicurare ai lavoratori. Per questo motivo, sarà fondamentale coinvolgere le parti sociali in un processo di aggiornamento e di co-progettazione della norma. Serve uno sforzo condiviso per pensare a un Fondo Nuove Competenze che diventi strutturale, ben disegnato e allineato ai bisogni del tessuto produttivo. Uno strumento che possa contare non solo su fondi europei, ma anche su risorse nazionali, e che sia orientato in modo esplicito a sostenere la transizione tecnologica, in particolare l’inserimento concreto dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi.
Mi scuso se insisto su questo punto, ma sento di doverlo ribadire con forza. Questi giorni di confronto mi hanno consegnato una convinzione profonda: serve intervenire in modo deciso sulle politiche attive, in particolare su quattro assi fondamentali:
- la governance, che deve essere interistituzionale, multilivello, realmente condivisa;
- l’interoperabilità tra le banche dati, che non può più essere rimandata;
- il Fondo Nuove Competenze, che deve diventare uno strumento strutturale e flessibile;
- la consapevolezza piena dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro.
Su quest’ultimo punto occorre una forte chiarezza: l’intelligenza artificiale inciderà profondamente sul nostro modo di lavorare e di progettare le politiche pubbliche. Non possiamo più permetterci di considerarla un fenomeno marginale o futuro. È già qui, è già ora.
Per questo occorre attrezzarsi, aggiornare gli strumenti, ripensare processi e alleanze. E serve farlo insieme. Soprattutto inciderà sul lavoro di chi fa formazione. E io sono convinto che l’intelligenza artificiale sarà una risorsa preziosa per i formatori, non solo nel disegnare quella parte di formazione che può essere affidata all’automazione. Non si tratta semplicemente di delegare all’IA i contenuti più ripetitivi o, tra virgolette, “meno importanti”. Credo, invece, che l’intelligenza artificiale potrà contribuire anche alla formazione più critica, più complessa, più strategica. Ma non in sostituzione dei formatori: al contrario, come strumento di supporto al loro lavoro, per rafforzarne il ruolo, estenderne l’efficacia e liberare tempo ed energie da dedicare all’accompagnamento vero delle persone nei percorsi di apprendimento.
L’intelligenza artificiale non deve solo essere “governata”, ma va considerata a tutti gli effetti uno strumento di supporto al nostro lavoro quotidiano. Chi non la interpreterà in questo modo, temo — e scusatemi se sembro catastrofico — che in breve tempo sarà fuori mercato. Lo dico con realismo, sulla base di quello che sta già accadendo e che continuerà ad accelerare. Dobbiamo prenderne atto: è necessario integrare l’intelligenza artificiale nei nostri processi lavorativi, in maniera consapevole. Se non siamo in grado di farlo da soli, dobbiamo farci aiutare.
E qui entrano in gioco i formatori: la loro funzione sarà fondamentale.
Ma anche loro devono essere pronti a formarsi, a rivedere le proprie competenze, per poter accompagnare gli altri con efficacia in questa transizione. Per quanto riguarda i fondi, sarà necessario individuare e rafforzare gli strumenti che rendano tutto questo possibile in tempi rapidi e con impatto reale.
Come ricordavo poco fa, tutto fa sistema: lavoro, formazione, politiche attive e orientamento non sono comparti separati, ma quattro dimensioni interdipendenti, che devono essere trattate in modo unitario e coerente.
Ecco perché parlavo della necessità di una “riforma” delle politiche attive, intesa non come revisione tecnica, ma come ripensamento culturale e strategico: dobbiamo guardare al lavoro non come un ambito isolato, ma come il punto di arrivo di un processo integrato che parte dall’orientamento, passa dalla formazione, include l’accompagnamento e si concretizza nell’occupazione.
Una curiosità rapidissima: all’inizio di questi tre giorni di workshop avevo una percezione molto diversa del sistema degli ITS, forse influenzata da alcuni giudizi non del tutto positivi che avevo captato. Nel corso di questi giorni, ho capito che quel giudizio stava cambiando. Anzi, direi che si è proprio trasformato, grazie agli interventi che si sono susseguiti che hanno fornito un quadro completamente diverso. È emerso che il vero problema degli ITS sia la comunicazione di questo strumento potenzialmente molto utile, ma non ancora sufficientemente conosciuto né valorizzato.
Siamo in stretto contatto con il Ministero dell’Istruzione — con cui abbiamo già avuto due incontri — da cui è emersa la voglia di lavorare insieme. È in fase avanzata una convenzione che coinvolge non solo il Ministero del Lavoro e l’INPS, ma anche il Ministero dell’Istruzione e il MUR, con l’obiettivo di integrare le banche dati e intercettare più efficacemente i famosi Neet.
Ovviamente, introdurre l’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro non significa solo parlarne in astratto, ma renderla utile attraverso servizi concreti.
A questo proposito, stiamo portando avanti una sperimentazione con il Ministero del Lavoro, giunta ormai alla seconda fase, e ai primi di giugno partirà una terza sperimentazione che coinvolgerà 2.000 persone. Una sperimentazione che riguarda direttamente il lavoro degli enti formativi — non per sostituire i formatori, che non potranno mai essere sostituiti, ma per supportarli.
Vogliamo offrire strumenti che consentano ai formatori di prendere davvero in carico le aspirazioni, i bisogni, le potenzialità di quelle persone che oggi non hanno ancora le idee chiare e hanno bisogno di essere orientate.
Su questo punto, non dobbiamo avere paura. La tecnologia può e deve essere un alleato del nostro lavoro educativo. Bisogna osare, bisogna sperimentare. Come accade per tutte le cose nuove, i progetti vanno messi alla prova. Ecco perché siamo arrivati alla terza fase di sperimentazione: prima di lanciare ufficialmente questo strumento, vogliamo testarlo a fondo.
Si tratta di un prodotto che utilizza intelligenza artificiale generativa, multi-agente, e che ha come obiettivo — in questo caso specifico — quello di intercettare i Neet e aiutarli a costruire un percorso personale, a partire dalle loro aspirazioni.
Tutto questo sarà possibile: sapendo, grazie all’Osservatorio sull’IA nel lavoro, quali sono i mestieri del futuro; conoscendo le competenze richieste dalle imprese; integrando tutte le informazioni e i dati che l’intelligenza artificiale può mettere a sistema per offrire percorsi coerenti e mirati.
Posso fare una domanda? Forse un po’ scomoda, ma necessaria. È una domanda che riguarda il sistema-Paese, non i singoli governi. Quanto pesa, secondo voi, la mancanza di continuità politica in Italia, rispetto alla capacità di pianificare e realizzare strategie di medio-lungo periodo? Per capirci: dal 1994 ad oggi, nessun Presidente del Consiglio è mai stato riconfermato. Questa instabilità crea — inevitabilmente — una discontinuità nel disegno delle politiche pubbliche, specie quelle che richiedono tempo, come le politiche attive del lavoro, la formazione, l’innovazione.
È una riflessione di sistema, non una critica partitica.
La mia opinione è che oggi, finalmente, si sta consolidando una certa consapevolezza politica — trasversale — rispetto a ciò che va fatto. Al netto delle ovvie differenze tra una maggioranza di centrodestra o di centrosinistra, ci sono temi che non possono essere rimessi in discussione ogni volta: parliamo di lavoro, sanità, scuola, politiche sociali.
Sono problemi reali, profondamente condizionati dal momento di transizione che stiamo vivendo, e devono essere affrontati con pragmatismo, oltre le ideologie. Certo, la politica può avere visioni diverse su alcuni macrotemi, ma su scuola, sanità, lavoro, innovazione e competenze, servono politiche stabili, condivise e di lungo respiro.
Sta anche a noi — tutti noi — fare squadra. Non può esserci un approccio separato, dove il Ministero da una parte, la Regione dall’altra, l’ente formatore per conto proprio e il settore privato per conto suo lavorano ognuno in autonomia. Serve un’azione corale, un’alleanza operativa tra tutti gli attori in campo, per trovare soluzioni condivise e offrirle con chiarezza al decisore politico.
È proprio il compito del tecnico — cioè di chi opera nell’amministrazione o nei corpi intermedi — quello di aiutare il politico a capire. Capire quali sono le soluzioni disponibili, quali sono gli impatti attesi da ciascuna decisione, quali risorse sono necessarie, e soprattutto quali effetti avranno quelle scelte su occupazione, formazione, coesione sociale. Perché se il tecnico non è in grado di rappresentare chiaramente questi elementi, il rischio è che si prendano decisioni senza comprenderne a fondo le conseguenze: ad esempio, si potrebbe adottare una misura pensando di aumentare l’occupazione, e invece ottenerne una riduzione. Oppure si potrebbe lanciare un intervento positivo, ma senza valutare i costi effettivi, in un contesto dove le risorse sono limitate e non possono essere moltiplicate.
Ogni scelta comporta una rinuncia, un sacrificio, un riequilibrio in altri settori. Ecco perché serve visione, collaborazione e responsabilità condivisa. Questo è un punto fondamentale: le decisioni politiche devono essere accompagnate da una visione predittiva.
Una norma, una misura, è utile o non è utile solo se conosciamo in anticipo quali impatti produrrà una volta applicata. Altrimenti rischiamo di continuare a navigare a vista, a prendere decisioni “all’impronta”, senza un’adeguata valutazione preventiva.
E questo — oggi — non ce lo possiamo più permettere.
È quindi essenziale che a livello nazionale e territoriale si lavori insieme sin dall’inizio nella progettazione degli interventi.
Pensiamo, ad esempio, alle politiche attive del lavoro o alla formazione professionale: come si può pensare che il Ministero del Lavoro operi efficacemente su questi temi senza un coinvolgimento strutturato delle Regioni, che ne detengono la competenza diretta? Come possiamo immaginare di realizzare una presa in carico efficace delle persone, specie di quelle più fragili o lontane dal mercato del lavoro, se le Regioni non vengono coinvolte fin dall’inizio nel processo di progettazione e attuazione degli interventi?
L’integrazione istituzionale è la chiave, e va realizzata non solo a livello formale, ma attraverso una vera co-progettazione operativa e condivisa.
Per rivedere l’intervento completo di Vincenzo Caridi al Workshop di Capri
CLICCA QUI
Scopri le proposte per il futuro del lavoro e della formazione. Clicca qui per prenotare la tua copia del Libro Bianco 2025.