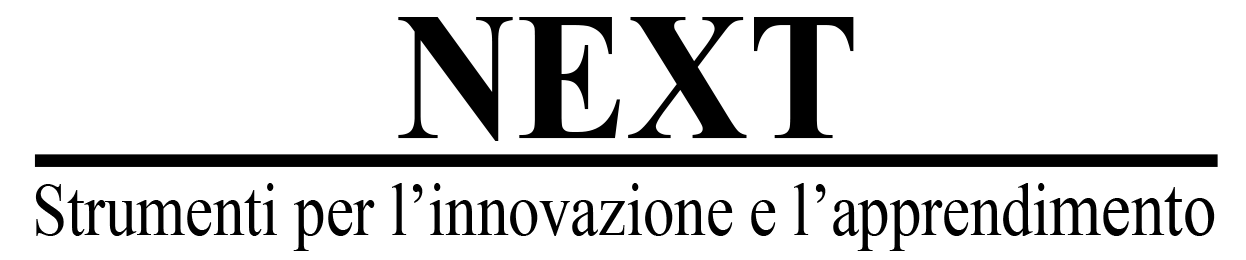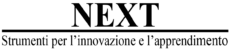Intervento di Romano Benini al Workshop di Capri (15-16-17 maggio 2025)
Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento che conosciamo ormai bene, e che abbiamo avuto modo di analizzare in profondità anche durante la giornata di ieri.
La nostra discussione si è svolta in un contesto particolarmente piacevole – un luogo ameno e stimolante – e la vera sfida è stata non lasciarsi distrarre. Ma possiamo dire che l’abbiamo vinta: ci siamo concentrati con serietà e partecipazione, arrivando a riflessioni utili e condivise.
Il primo nodo da affrontare riguarda ciò che non bisogna fare.
In generale, a mio avviso, dobbiamo evitare che il Fondo venga trattato come spesso accade per molte risorse pubbliche: non possiamo permettere che diventi un meccanismo automatico di spesa, svuotato di senso strategico, utilizzato in maniera episodica o disconnessa dai reali fabbisogni dei territori e delle imprese.
Il rischio è quello di replicare approcci burocratici o difensivi, dove la formazione si riduce a una voce di bilancio piuttosto che a un vero motore di cambiamento.
Il Fondo Nuove Competenze deve essere considerato, invece, un’opportunità per accompagnare i lavoratori e le imprese nei processi di trasformazione, e per costruire reti di apprendimento continuo collegate alla domanda reale di innovazione, produttività e benessere.
I fondi come strumenti di politica, non fini a se stessi
I fondi non hanno senso in quanto tali: acquisiscono significato solo se inseriti all’interno di una visione strategica, come strumenti di politiche pubbliche orientate da idee, obiettivi e cambiamento.
Essi devono essere considerati leve al servizio dell’evoluzione economica e sociale. Quando la realtà si trasforma – e oggi accade a ritmi accelerati – gli strumenti devono sapersi adattare. Restare ancorati a modelli superati o autoreferenziali significa perdere efficacia e occasione di impatto.
Un passo importante in questa direzione è stato compiuto con l’ultima edizione del Fondo Nuove Competenze, che ha introdotto elementi di riforma. È fondamentale proseguire su questa strada: non trattare i fondi come dispositivi statici, ma come architetture dinamiche, da rimodellare in base agli indirizzi delle politiche industriali, occupazionali e formative.
Questo vale in generale per tutte le misure di sostegno alla formazione e al lavoro: serve coerenza tra gli strumenti e le strategie, affinché il sistema sia realmente capace di accompagnare la transizione verso un’economia più intelligente, inclusiva e sostenibile.
Il Fondo Nuove Competenze: uno strumento al servizio di obiettivi in evoluzione
Il Fondo non è mai un fine in sé: è uno strumento, e come tale deve sempre essere messo al servizio di un obiettivo. Ma gli obiettivi possono cambiare, possono evolversi nel tempo, e con essi devono necessariamente aggiornarsi anche le modalità di accesso, di gestione e di impiego del fondo stesso.
È questo il principio che ha guidato la recente revisione del Fondo Nuove Competenze. Con la terza edizione, che si è conclusa da poco, sono state introdotte modifiche significative, frutto di un’attenta riflessione condivisa tra Ministero, Parti sociali e stakeholder del sistema.
Abbiamo ricevuto una precisa indicazione politica dal Ministro del Lavoro: aggiornare lo strumento per renderlo coerente con l’evoluzione del contesto produttivo, con i nuovi bisogni delle imprese e con la trasformazione dei processi formativi e organizzativi.
Questa evoluzione ha portato il fondo a rafforzarsi come leva strategica, non più solo misura emergenziale, e a sostenere modelli di formazione più radicati nelle realtà aziendali, capaci di attivare reti tra imprese, lavoratori e territori. La direzione è quella giusta, ma serve continuare con determinazione questo percorso di innovazione.
Un meccanismo virtuoso per sostenere la formazione e l’occupazione
Con l’ultima edizione del Fondo Nuove Competenze abbiamo cercato di rafforzare il collegamento tra il sostegno pubblico alle imprese e la valorizzazione dei percorsi formativi per i lavoratori. Il meccanismo è noto: la formazione è generalmente finanziata dalle imprese, anche tramite il supporto dei fondi interprofessionali; il Fondo Nuove Competenze interviene coprendo il costo orario dei lavoratori durante il periodo di formazione, permettendo così alle aziende di investire nella riqualificazione delle competenze senza gravare sui propri bilanci operativi.
Si tratta di un modello di co-progettazione pubblico-privata, che consente di sostenere la competitività del sistema produttivo e, allo stesso tempo, di garantire continuità occupazionale e crescita professionale ai lavoratori coinvolti.
Un Fondo per orientare comportamenti virtuosi e strategie collaborative
Con l’ultima edizione del Fondo Nuove Competenze abbiamo voluto stimolare cambiamenti strutturali nei comportamenti delle imprese, promuovendo modelli organizzativi più evoluti e collaborativi. In particolare, abbiamo introdotto un sistema premiale che riconosce risorse significative – fino a 12 milioni di euro – alle grandi imprese soltanto se queste coinvolgono in maniera attiva la propria rete di fornitori, le filiere e i territori di riferimento.
L’obiettivo è incentivare le grandi imprese italiane ad assumere un ruolo di traino nello sviluppo delle competenze lungo le catene del valore, favorendo così una maggiore integrazione con le piccole e piccolissime imprese con cui abitualmente collaborano.
Pur mantenendo il sostegno anche alle singole imprese, abbiamo potenziato le misure a favore delle reti di PMI, spingendo verso forme di aggregazione progettuale capaci di rafforzare la capacità di innovazione, adattamento e formazione continua del tessuto produttivo italiano.
Un Fondo più inclusivo, connesso alle politiche attive e orientato alla coesione produttiva
In questa edizione del Fondo Nuove Competenze abbiamo voluto rafforzare il collegamento tra formazione e politiche attive del lavoro, valorizzando le buone pratiche già avviate da alcuni fondi interprofessionali. In particolare, abbiamo promosso l’utilizzo del fondo anche per la formazione dei disoccupati e dei giovani preselezionati dalle imprese, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento lavorativo e ampliare l’impatto sociale del fondo.
Abbiamo inoltre ampliato l’accessibilità del fondo a settori stagionali e a segmenti produttivi meno strutturati, seguendo un principio fondamentale: i fondi pubblici non devono servire a premiare esclusivamente chi è già virtuoso, ma a sostenere chi fatica ad adottare comportamenti virtuosi ma necessari.
Il nostro tessuto produttivo è caratterizzato da forti polarizzazioni: circa il 40% delle imprese manifatturiere e il 30% di quelle dei servizi mostrano livelli elevati di competitività, ma il restante 60-70% arranca, fatica ad adattarsi ai cambiamenti e rischia l’esclusione. A queste imprese vanno offerte occasioni concrete di sviluppo e strumenti efficaci di accompagnamento, affinché possano rafforzare il proprio capitale umano e riposizionarsi nei mercati.
Il Fondo Nuove Competenze, in questa prospettiva, si configura come leva di inclusione economica e coesione sociale, non come uno strumento a vantaggio dei pochi già strutturati, ma come motore di un cambiamento diffuso e sostenibile.
Monitorare per migliorare: risultati e riflessioni per la messa in qualità del sistema.
Perché il Fondo Nuove Competenze e, più in generale, le politiche pubbliche del lavoro e della formazione, possano realmente incidere sullo sviluppo del Paese, è fondamentale che i fondi pubblici vengano utilizzati in modo strategico per accompagnare la messa in qualità del sistema produttivo, con particolare attenzione a chi oggi fatica di più ad affrontare i processi di transizione.
L’obiettivo non è solo finanziare la formazione, ma innescare un cambiamento culturale e organizzativo, promuovendo comportamenti virtuosi anche dove l’inerzia, la scarsità di risorse o l’assenza di visione strategica rischiano di frenare l’innovazione.
Proprio in quest’ottica, abbiamo ritenuto centrale monitorare in itinere i risultati, non solo in chiave rendicontativa, ma per comprendere dove il fondo sta funzionando bene e dove invece è necessario intervenire con aggiustamenti, accompagnamento o nuove strategie.
I risultati che possiamo considerare positivi:
- Una maggiore attenzione da parte delle imprese alla programmazione della formazione come leva di sviluppo;
- La nascita di reti e filiere formative tra grandi e piccole imprese;
- L’attivazione di percorsi di upskilling e reskilling coerenti con i cambiamenti tecnologici e organizzativi;
- L’apertura del fondo a target più deboli, come i lavoratori stagionali e i giovani in ingresso.
I nodi su cui riflettere:
- Ancora troppa disomogeneità territoriale nell’accesso e nella capacità progettuale;
- Difficoltà da parte di molte PMI ad integrare la formazione nei processi aziendali, limitandosi a interventi puntuali;
- Una certa resistenza culturale a considerare la formazione come investimento e non come costo;
La necessità di rafforzare il raccordo con le politiche attive e i sistemi di certificazione delle competenze, per rendere più efficace e tracciabile l’impatto degli interventi.
Il lavoro da fare, dunque, è ancora ampio. Ma abbiamo strumenti, conoscenze e alleanze per continuare a migliorare. A condizione di guardare al futuro con pragmatismo e condivisione, sostenendo soprattutto chi – oggi – rischia di restare indietro.
Primo risultato: le grandi imprese hanno creduto nel modello di rete e responsabilità sociale
Uno dei risultati più significativi di questa edizione del Fondo Nuove Competenze è stato il riscontro positivo da parte delle grandi imprese italiane rispetto alla proposta di coinvolgere le proprie filiere produttive, in particolare i soggetti più fragili della catena, in percorsi condivisi di formazione e riqualificazione
Abbiamo detto: “Ti diamo un contributo rilevante, se porti con te anche i tuoi fornitori più deboli.”
Un esempio concreto? I grandi brand della moda, anche quelli che spesso subappaltano in contesti critici, come piccoli laboratori o realtà semi-informali. Il messaggio era chiaro: “Non finanzieremo solo il vertice, ma chi si fa carico della qualità e della sostenibilità dell’intera filiera.”
Il risultato è stato straordinario: il numero di domande è stato più del doppio rispetto alle risorse disponibili, a conferma che il principio di corresponsabilità – quando ben strutturato – può diventare un potente motore di attivazione e inclusione.
Questo dato restituisce un segnale politico e culturale forte: il mondo produttivo è pronto a ragionare in termini di sistema, a condizione che le politiche pubbliche offrano strumenti coerenti e incentivanti.
Non si tratta solo di finanziare formazione, ma di ricostruire fiducia e alleanze per la qualità del lavoro e dei territori.
La forza delle grandi imprese è nella capacità di fare sistema
Quello che questa edizione del Fondo ci restituisce è una conferma importante: le grandi imprese italiane sono tali perché hanno saputo aggregare, costruire filiere solide, e diffondere la propria cultura organizzativa anche oltre i propri confini formali.
Il successo della misura ci dice che la catena del valore non è solo economica, ma sempre più spesso è una catena di competenze condivise. Oggi il valore si crea attraverso il sapere e il saper fare, e una grande impresa lo è davvero quando trasmette il proprio modello anche a chi lavora nella sua orbita produttiva: fornitori, terzisti, piccole realtà locali.
Le imprese che hanno aderito al Fondo portando con sé i soggetti più deboli della propria filiera hanno compreso che questa è una leva strategica per rafforzare la competitività complessiva, non solo per ricevere un incentivo. Hanno dimostrato che la formazione è un investimento condiviso, e che la qualità del lavoro cresce quando cresce insieme a tutta la comunità produttiva che vi ruota attorno.
Questo approccio ha funzionato. Ed è un modello che va sostenuto e replicato.
Le difficoltà delle piccole imprese nell’attivare percorsi formativi strutturati
Se da un lato il Fondo ha mostrato un forte impatto nella capacità delle grandi imprese di attivare meccanismi di inclusione lungo le proprie filiere, dall’altro lato ha funzionato meno sul versante delle piccole imprese. Non per colpa dello strumento in sé, che mantiene una sua coerenza e validità, ma per una serie di fattori strutturali e culturali che meritano una riflessione attenta.
La linea dedicata alle filiere formative – pensata per stimolare la progettazione condivisa tra piccole imprese, anche all’interno dei distretti produttivi – è stata l’unica a non raggiungere il plafond disponibile. Questo nonostante il potenziale enorme che rappresenta in termini di rafforzamento delle competenze nei territori.
Il dato ci suggerisce che permane una difficoltà concreta, sia al Sud che al Nord, nel costruire modelli di aggregazione tra piccole imprese. Le ragioni sono molteplici: mancanza di tempo, risorse progettuali, visione strategica, o semplicemente la fatica culturale di uscire dalla logica dell’intervento singolo per abbracciare un’ottica di collaborazione sistemica.
Questo rappresenta una delle principali sfide del futuro: aiutare le micro e piccole imprese, che costituiscono l’ossatura produttiva del Paese, a percepire la formazione non come un adempimento esterno, ma come un’opportunità concreta per crescere insieme e affrontare i cambiamenti in atto.
Aggregare per crescere: la sfida delle reti e il ruolo strategico della formazione condivisa
Questo è un dato che non possiamo permetterci di trascurare. Ne abbiamo discusso ampiamente ieri, ed è emersa con chiarezza la necessità di individuare soluzioni concrete per sostenere le piccole e medie imprese nei percorsi di aggregazione formativa. Servono nuove figure, come i manager di rete, capaci di progettare e coordinare percorsi condivisi, e sistemi informativi avanzati che consentano anche alle imprese prive di una Academy interna di accedere a progettualità formative comuni.
Serve inoltre un ruolo più attivo da parte delle istituzioni: è necessario che esse si pongano come facilitatori della collaborazione tra le imprese, creando condizioni che favoriscano la co-progettazione e l’adozione di standard condivisi.
Dall’artigiano caseario al produttore tecnologico, dal manifatturiero tradizionale al turismo esperienziale, tutto il tessuto produttivo del made in Italy ha oggi bisogno di un nuovo paradigma distrettuale, dove il valore non sta solo nel prodotto, ma nella capacità di rete, nell’integrazione delle competenze e nella condivisione di percorsi formativi.
Non possiamo più permetterci reti fragili, disomogenee o frammentate. Senza un livello di competenza condiviso, i distretti non funzionano. Si rischia di creare falle che rendono impossibile la cooperazione, e si genera una diffidenza strutturale all’ingresso in rete.
Crescere insieme significa dotarsi di strumenti per apprendere insieme. Occorre dunque costruire ambienti formativi condivisi, accessibili, dinamici, capaci di promuovere apprendimento continuo e sinergico. È questo il compito di una governance funzionale, ed è questa la sfida che dobbiamo raccogliere per il prossimo ciclo di programmazione europea.
Una sfida ancora aperta: sostenere le imprese nella transizione e valorizzare i risultati del Fondo Nuove Competenze
Con la nuova edizione del Fondo Nuove Competenze, abbiamo lanciato una sfida ambiziosa: trasformare uno strumento emergenziale in una leva strategica per accompagnare la transizione produttiva e formativa del sistema Paese. Non possiamo ancora dire di averla vinta, ma siamo consapevoli che l’obiettivo resta prioritario e deve guidare le scelte future.
In questa fase, occorre innanzitutto decidere come riassegnare i residui disponibili, valutando la possibilità di reimpiegare gli avanzi di spesa per integrare le risorse esistenti. Sono numerosi i progetti ammessi ma non finanziabili, non per mancanza di merito ma per esaurimento del budget: il successo della misura è evidente, con un incremento delle domande del 40% rispetto alle edizioni precedenti.
A valle di questa tornata, si impone una riflessione di sistema. I dati mostrano un paradosso crescente: le imprese più strutturate e con competenze consolidate stanno diventando sempre più forti e consapevoli, anche grazie alla disponibilità di informazioni e strumenti per affrontare la transizione. Questo è un dato positivo, che conferma l’efficacia della misura.
Tuttavia, una larga parte del tessuto imprenditoriale italiano – fatto di micro e piccole imprese – resta in affanno. Queste realtà hanno compreso l’importanza della formazione, ma non sono sempre in grado di attivarsi in autonomia: per loro servono strumenti di accompagnamento, figure di facilitazione, investimenti in managerialità di rete e servizi territoriali di supporto alla progettazione formativa.
Il Fondo Nuove Competenze, nel suo sviluppo futuro, dovrà tener conto di queste asimmetrie. Se vogliamo che la formazione diventi davvero leva di equità, competitività e resilienza, dobbiamo progettare una nuova generazione di politiche che favoriscano la partecipazione anche delle realtà più fragili, con meccanismi inclusivi e modelli organizzativi che rendano la cooperazione interaziendale una pratica quotidiana.
Dalla consapevolezza all’azione: il ruolo trasformativo della formazione nell’era dell’Intelligenza Artificiale
Le imprese, oggi più che mai, devono essere sostenute nel tradurre la consapevolezza in azioni concrete, in scelte strategiche e in investimenti mirati. Siamo in una fase cruciale, dove la transizione non è più una possibilità ma una necessità, e l’Intelligenza Artificiale rappresenta la chiave interpretativa della trasformazione in atto.
L’IA, che ha fatto da filo conduttore ai lavori di questi tre giorni, non è soltanto uno strumento tecnologico, ma un catalizzatore di cambiamento sistemico. Metaforicamente, essa pone “la pietra tombale” su un paradigma che ha dominato gli ultimi 30-40 anni: un’economia fondata sulla quantità, sulla standardizzazione e su modelli formativi basati sulla misurabilità tramite test.
In questo scenario, l’apprendimento stesso deve essere ripensato: non più orientato esclusivamente alla ripetizione di saperi codificati, ma capace di valorizzare le dimensioni creative, relazionali e adattive della conoscenza. La formazione continua, pertanto, non deve solo colmare un gap, ma alimentare un ecosistema culturale e produttivo pronto a gestire l’imprevedibilità e a generare valore nei contesti complessi e dinamici.
Se il passato ha premiato la riproducibilità e la specializzazione, il futuro premierà l’ibridazione, la flessibilità e la capacità di pensare in modo sistemico. Ed è proprio in questa direzione che i fondi, le politiche attive e i sistemi di certificazione delle competenze devono essere riprogettati: per sostenere non solo chi sa già cosa fare, ma soprattutto chi deve ancora imparare a muoversi nel cambiamento.
La sfida della formazione è la sfida della consapevolezza
La grande transizione che stiamo vivendo — tecnologica, economica e culturale — non si gioca solo sul piano delle competenze tecniche, ma prima di tutto su quello della consapevolezza. Se è vero che l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie ci offrono strumenti straordinari per trovare risposte, è altrettanto vero che il compito più urgente è quello di tornare a saperci porre le domande giuste.
Questo approccio va trasferito alle imprese, ai territori e alle istituzioni, perché oggi il rischio più grande non è l’obsolescenza tecnologica, ma l’aumento del divario tra chi ha visione e direzione, e chi resta privo degli strumenti per orientarsi.
La sfida è già in atto, e si giocherà nei prossimi mesi: o saremo capaci di attivare processi diffusi di consapevolezza, orientamento e partecipazione, oppure assisteremo a una frattura crescente tra un’élite attrezzata e un tessuto produttivo e sociale sempre più spaesato.
Per questo il Net Forum promuove una governance intelligente, condivisa e capace di generare senso, accompagnando il Paese nell’elaborazione di strategie fondate sull’ibridazione di saperi, sull’ascolto delle esigenze reali e sulla costruzione di strumenti funzionali all’inclusione e alla crescita di tutti.
Per rivedere l’intervento di Romano Benini al Workshop di Capri 2025
clicca qui
Scopri le proposte per il futuro del lavoro e della formazione. Clicca qui per prenotare la tua copia del Libro Bianco 2025.