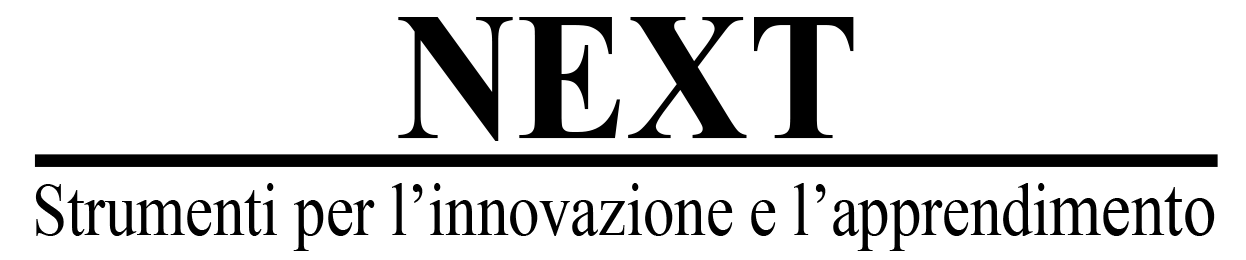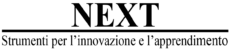Intervento di Amarildo Arzuffi al Workshop di Capri (15-16-17 maggio 2025)
Nell’affrontare il tema della formazione continua, vorrei partire da un punto un po’ più lontano nel tempo, facendo riferimento a una riflessione contenuta in un saggio del 1583 di Michel de Montaigne – filosofo e scrittore francese molto originale – che, a mio avviso, resta di straordinaria attualità. Un pensiero che è stato ripreso anche in un libro di Edgar Morin pubblicato nei primi anni 2000, e che oggi più che mai merita attenzione.
Montaigne scriveva che “è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena”. Da lì è nata una riflessione, che ancora oggi ci accompagna, sul valore del nozionismo. Montaigne è stato tra i primi a criticare l’idea di una conoscenza fondata sull’accumulo passivo di nozioni, paragonando la mente riempita di contenuti inutili a un basto da caricare sugli asini. Secondo lui, questo tipo di sapere non serve davvero. Una discussione che, a distanza di secoli, è ancora viva: la vediamo ripresentarsi ogni volta che si parla – anche sui giornali – di scuola, istruzione e formazione.
E allora, di fronte a queste riflessioni, mi sento di dire una cosa: oggi siamo davanti a una realtà innegabile. L’intelligenza artificiale è, a tutti gli effetti, una “testa ben piena”. Noi non possiamo competere con lei sul piano della quantità di informazioni. Non abbiamo più margini per pensare che la nostra forza risieda nell’avere una testa più piena della sua. E allora non ci resta che lavorare sulle “teste ben fatte”. Questo è il vero tema su cui dobbiamo concentrarci oggi.
Questo, secondo me, è il punto cruciale su cui devono poggiare tutte le riflessioni sull’educazione e sulla formazione, anche rispetto alla classica tripartizione del formale, informale e non formale che, lo dico sinceramente, non mi convince del tutto, pur essendo categorie consolidate nella pedagogia. In ogni caso, in tutte queste prospettive è ormai chiaro che abbiamo bisogno di formare “teste ben fatte”, non più “teste ben piene”. Perché la testa ben piena ce l’abbiamo già … ce la portiamo in tasca, dentro lo smartphone. Questa è la realtà. Ed è a partire da questo che dobbiamo cominciare a ragionare seriamente.
Dobbiamo renderci conto che tutto questo ci consegna, finalmente, un tempo da dedicare a qualcosa che finora è stato riservato a pochi: l’educazione alla complessità. Significa cominciare a pensare non più in modo lineare, sequenziale, riduzionista, ma ad abituarci a vedere le interconnessioni, le retroazioni, le variabili multiple. A riconoscere che i fenomeni non sono mai isolati, che ogni problema contiene più punti di vista e che ogni decisione ha conseguenze sistemiche.
Per millenni, l’umanità ha dovuto occuparsi principalmente di processi lineari, necessari alla sopravvivenza: mi alzo, cerco il cibo, trovo un riparo. Operazioni semplici, sequenziali, che – fortunatamente – oggi vengono sempre più spesso sostituite dalle macchine. E questo ci libera tempo e risorse mentali per occuparci di ciò che è complesso.
Quello che ci resta, oggi, è uno spazio molto ampio in cui possiamo – e dobbiamo – cominciare a occuparci dei problemi più complessi. Non solo per vivere meglio, ma perché ne siamo chiamati tutti in causa: è un compito collettivo. Ed è proprio qui che la formazione continua e l’educazione degli adulti entrano in gioco con forza.
Perché riguarda tutti?
Per una ragione molto semplice, che possiamo introdurre con una parola che arriva dal francese: sabotage. Una parola che ha origine da un gesto compiuto dagli operai tessili francesi nel Seicento. Quando comparvero i primi telai meccanici, questi operai iniziarono a gettare i propri sabot – i tradizionali zoccoli di legno – negli ingranaggi delle macchine, nel tentativo di bloccarle. Pensavano, con paura e rabbia, che quelle nuove tecnologie avrebbero distrutto il loro lavoro, la loro identità professionale, il loro ruolo nel mondo.
Questa è, a mio avviso, la situazione in cui ci troviamo oggi. Se non riusciremo a traghettare la maggior parte del sistema sociale verso un pensiero più complesso, il rischio sarà enorme. Questo è il vero nodo della questione.
E attenzione: il sabotaggio, oggi, non si manifesta più con un gesto fisico come gettare uno zoccolo in una macchina. Oggi assume forme molto più sottili ma altrettanto distruttive: può essere il rifiuto passivo di apprendere, l’inerzia organizzativa, la rinuncia a cambiare, l’ostilità verso ciò che non si comprende. È un sabotaggio silenzioso, diffuso, a volte persino inconsapevole, ma non per questo meno pericoloso.
Non sto parlando di una rivolta, non immagino barricate. Sto parlando piuttosto dei tanti fenomeni regressivi che già osserviamo nella nostra società. Pensiamo, ad esempio, all’atteggiamento nei confronti dei migranti. Oppure alle resistenze verso il cambiamento culturale, tecnologico o generazionale. Tutti segnali di una difficoltà più profonda: facciamo fatica a gestire la complessità, perché siamo ancora troppo abituati a ragionare in termini lineari, semplificati, binari.
Ed è proprio questa la sfida della formazione continua oggi: aiutare le persone a sviluppare strumenti per comprendere e abitare la complessità, piuttosto che temerla o rifiutarla.
Ci troviamo, improvvisamente, di fronte al rischio concreto di non sapere più cosa fare. Questa incertezza diffusa, questa paura strisciante, non ci aiuta a entrare con lucidità nella modernità: al contrario, genera tensione, disorientamento, insicurezza. E questi si riflettono inevitabilmente nei comportamenti quotidiani, nelle dinamiche sociali, nelle scelte politiche.
Ci sono, in atto o in potenza, molte forme di nuovo luddismo — non quello delle macchine distrutte con la forza, ma quello più subdolo del rifiuto, del ripiegamento, della rinuncia alla comprensione. Se non interveniamo con decisione e lungimiranza su questi processi educativi, rischiamo davvero di perdere una partita fondamentale.
Questa grande emergenza educativa può alimentare il rischio di una frattura reale e profonda tra élite e popolo — quella famosa spaccatura di cui si parla tanto in sociologia e nella letteratura contemporanea — diventa oggi sempre più concreto. È una spaccatura che sta segnando il nostro tempo e che rischia di compromettere la coesione sociale.
In questo contesto, la formazione continua può certamente offrire un contributo importante. Non è una panacea, ma è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione per contrastare questa deriva. Naturalmente, a patto che venga ripensata profondamente perché, se continuiamo a immaginare la formazione come un accumulo di nozioni — come una corsa a “riempire” le teste — difficilmente sarà efficace. Dobbiamo davvero a occuparci della costruzione di “teste ben fatte”, come diceva Montaigne, allora la formazione continua potrà diventare un presidio di democrazia, un ponte tra saperi e mondi diversi, uno spazio di riconoscimento e di inclusione. Una formazione continua che ci aiuti a sviluppare una capacità finora riservata alle élite, ovvero il pensiero critico.
È necessario, quasi urgente, ripartire dalle basi, da una lezione antica e attualissima: quella di Eraclito, secondo cui “il polemos è padre di tutte le cose”. Con questo non si intende l’idea di conflitto distruttivo, ma di confronto, di dialettica, di messa in discussione dell’ovvio. Dobbiamo tornare a considerare la discussione pubblica come lo spazio essenziale della democrazia, dove i problemi si analizzano, si soppesano, si ridefiniscono collettivamente. Il vero ostacolo, oggi, è la tendenza a “fissare” il sapere, a standardizzarlo, e soprattutto a costruire la formazione continua secondo un pensiero esecutivo, lineare, adattivo. Questo approccio ha prodotto una formazione che tende a istruire più che a educare, a prescrivere più che a sollecitare.
Oggi più che mai, serve un’inversione: una formazione che renda possibile e legittimo il dubbio, il confronto, la pluralità delle interpretazioni. Solo così la formazione continua potrà diventare un’opportunità autentica di crescita individuale e collettiva.
Certo, il nodo cruciale è proprio il superamento del pensiero addestrativo — quello che si limita a fornire istruzioni operative, a preparare le persone a risposte standard in contesti prevedibili. Ma oggi il mondo non è più prevedibile, ed è qui che entra in gioco la varianza: l’imprevedibilità dei contesti, dei problemi, delle interazioni. E proprio sulla gestione della varianza sarà chiamato a intervenire l’umano, come ha ben sottolineato Antonello Calvaruso anche in questi giorni, quando sostiene che occorre lavorare su modelli didattici e pedagogici coerenti con questa visione, che non si limitino a formare per l’occupabilità immediata, ma per la sostenibilità cognitiva e sociale delle persone nel tempo lungo della loro vita attiva. Riprendendo alcune riflessioni preziose che ci ha lasciato, in particolare nel libro “Cosa abbiamo nella testa” scritto insieme a Edoardo Boncinelli, quando illustra in modo molto chiaro come i meccanismi dell’apprendimento siano strettamente connessi alla struttura e al funzionamento del nostro sistema neuronale.
Il futuro dell’apprendimento
L’apprendimento, ci ricorda Calvaruso, non è un processo astratto, ma ha basi neurobiologiche precise: si attiva con l’esperienza, con la curiosità, con l’esplorazione, e soprattutto con il significato. Il cervello apprende con difficoltà ciò che non emoziona, ciò che non ha senso, ciò che non coinvolge. Ed è da questa consapevolezza che dobbiamo ripartire per ripensare la formazione continua.
Se vogliamo davvero accompagnare le persone in un processo di crescita che le renda capaci di affrontare la complessità, dobbiamo lavorare con ciò che attiva la loro mente, non solo con ciò che la riempie. È una lezione scientifica, pedagogica e, direi, anche profondamente politica. Ci spiegano Calvaruso e Boncinelli che dimenticare è un bene. In realtà, dimentichiamo continuamente: ogni notte il nostro cervello ‘muore un po’’, potremmo dire, proprio per selezionare cosa conservare e cosa lasciar andare.
Se non dimenticassimo, se trattenessimo ogni informazione, ogni stimolo, ogni dettaglio, avremmo bisogno di un cervello talmente grande da non riuscire più nemmeno a camminare. È la selezione – e quindi anche l’oblio – che rende possibile l’apprendimento e la vita quotidiana. Per questo, non possiamo più puntare sulla quantità, sull’accumulo nozionistico, ma dobbiamo concentrarci su ciò che davvero merita di restare e di essere trasformato in conoscenza utile, viva e significativa.
Ed è anche per questo che abbiamo costruito le macchine: perché non possiamo portare tutto nella nostra testa. C’è un limite biologico invalicabile. Già così, come specie, facciamo fatica. Il nostro cervello non è completamente formato fino ai vent’anni. E questo ha un motivo ben preciso: al contrario degli altri animali, noi nasciamo con una testa ancora in formazione, perché se fosse già completamente sviluppata, al momento del parto metteremmo a rischio la vita della madre.
Il nostro limite è chiaro: non possiamo contenere tutto. Per questo dimenticheremo ancora tante cose in futuro. Ma non sarà un dramma. Avremo le macchine – i nuovi archivi – che conserveranno al posto nostro le informazioni e sapranno indicarci cosa fare, aiutandoci così a concentrare le nostre energie su ciò che conta davvero: pensare in modo critico, creativo e complesso.
Le macchine possono fare tutto ciò che noi diciamo loro di fare. Sono strumenti che ci permettono di non dover più occuparci di certe attività, liberandoci dal peso del fare ripetitivo. Possiamo dimenticare – e questa è la chiave – per fare spazio a cose nuove. È questa la sfida fondamentale.
Dobbiamo liberarci per concentrarci su ciò che davvero conta: tutte quelle competenze sociali e relazionali, quelle che oggi chiamiamo soft skill, che possono aiutarci a costruire una società più moderna e un sistema produttivo al passo con i tempi. Abbiamo però bisogno di dimenticare molto. Per esempio, dobbiamo iniziare a dismettere l’aggressività strutturale che ha caratterizzato il sistema sociale del Novecento. E questa, mi permetto di dire, è una questione che dobbiamo cominciare seriamente a studiare. Dobbiamo cominciare – o forse sarebbe meglio dire ricominciare – a studiare seriamente come funziona il cervello in relazione ai processi di apprendimento. Oggi, le neuroscienze rappresentano una risorsa fondamentale anche per chi si occupa di formazione. Un contributo prezioso per chi vuole ripensare seriamente la formazione alla luce delle nuove conoscenze scientifiche.
Insomma, come formazione continua abbiamo davanti a noi un enorme lavoro da fare. Ma prima di tutto, dobbiamo anche noi – come formatori – dimenticare alcune cose, abbandonare certi automatismi, certe convinzioni del passato. Dobbiamo accettare l’idea che è arrivato il momento di imparare a insegnare cose nuove. Solo così potremo davvero accompagnare le persone nella gestione consapevole dei nuovi strumenti che abbiamo contribuito a creare.
Dobbiamo rimetterci a studiare, riscoprire come avviene l’apprendimento oggi, approfondire l’interazione tra esseri umani e tecnologie, comprendere quali siano le nuove competenze realmente necessarie. E, soprattutto, dobbiamo essere disponibili a metterci in gioco, a imparare a nostra volta, per poter guidare con serietà ed efficacia questo passaggio cruciale.
I Calvaruso, durante il workshop caprese, ci hanno dimostrato che i sistemi di setting sono luoghi fondamentali per sviluppare l’apprendimento. Il setting didattico è infatti centrale in un disegno formativo come quello in cui siamo stati inseriti in questi giorni: un percorso in cui il formatore, pur apparentemente defilato, “scompare” nel senso tradizionale del termine, ma rimane pienamente attivo nel costruire e guidare un processo strutturato. Nulla è lasciato al caso: ogni passaggio, ogni interazione è pensata e programmata per condurre a determinati output, frutto di un progetto educativo preciso. Il formatore non impone, ma orienta; non dirige, ma prepara il terreno affinché l’apprendimento possa emergere con forza, autenticità ed efficacia.
L’arte del formatore, oggi più che mai, è anche l’arte di scomparire: l’arte del vuoto. Un’arte antica, profondamente radicata nei processi educativi e nel pensiero orientale, dove il maestro è guida silenziosa, presenza discreta che crea lo spazio per l’autonomia dell’altro. Una prospettiva che la nostra cultura, fondata sull’impianto aristotelico e sul primato della trasmissione diretta, ha per lungo tempo trascurato, se non addirittura dimenticato.
Eppure, proprio oggi, in un contesto sempre più complesso, questa arte del vuoto si rivela estremamente attuale ed efficace: lasciare spazio significa non solo fidarsi del processo, ma riconoscere la capacità di ciascuno di generare apprendimento, di trovare senso, di attivare risorse. È così che la formazione continua può evolvere davvero: non come imposizione di contenuti, ma come costruzione condivisa, attivazione di energie, apertura a nuove forme del sapere.
Non è assenza, ma presenza discreta. Non è rinuncia, ma responsabilità condivisa. Una pedagogia che non impone, ma orienta; non istruisce, ma accompagna. E che oggi, nella formazione continua, può diventare una leva decisiva di trasformazione.
Ecco, dentro tutto ciò che abbiamo detto — e che attiene a una visione filosofica della formazione e dell’apprendimento — è necessario anche inserire delle politiche concrete. Perché senza politiche, tutto questo resta appunto filosofia: una cosa preziosa, fondamentale — soprattutto per chi, come me, l’ha studiata e continua ad amarla — ma che, da sola, non cambia il mondo.
Occorre dunque uno sforzo per tradurre questa visione in azioni, strumenti, decisioni operative. Abbiamo un bel po’ di problemi da affrontare, il primo dei quali è proprio gestire questa transizione culturale e cognitiva nel modo in cui approcciamo il mondo, il lavoro, la formazione.
E dobbiamo farlo ricordando che coloro che più hanno bisogno di essere accompagnati in questo passaggio sono proprio le persone più numerose e, spesso, più fragili del nostro tessuto sociale — quel “corpo grande” evocato da Romano Benini nel suo intervento. È lì che si gioca la vera sfida democratica della formazione continua: non solo innovare, ma includere.
Cioè, stiamo parlando di quel numero significativo di persone — tra i 12 e i 15 milioni in Italia — che oggi sono inserite in un processo lavorativo e al tempo stesso fortemente esposte ai rischi connessi a questa fase di regressione culturale. La si può chiamare “faglia tra élite e massa”, oppure “smarrimento”, ma la verità è che siamo di fronte a qualcosa di più profondo: una diffusa sensazione di spaesamento, di disorientamento rispetto ai nuovi modi di pensare, apprendere, lavorare, convivere con la tecnologia.
Gestire questo “pubblico” vastissimo — e culturalmente, generazionalmente, territorialmente eterogeneo — è, a mio parere, una vera emergenza sociale. Non è solo una questione formativa: è una questione di coesione, di futuro del lavoro, di cittadinanza. E proprio perché si tratta di una sfida di queste proporzioni, richiede investimenti. Tanti investimenti. In risorse economiche, ma anche e soprattutto in risorse cognitive, metodologiche e organizzative. Perché senza un progetto serio di accompagnamento e rigenerazione culturale, il rischio è quello di perdere una parte importante del nostro capitale umano nel momento in cui ne abbiamo più bisogno.
Un’ efficace gestione delle risorse
Riprendendo il filo del discorso: abbiamo di fronte un numero enorme di persone coinvolte, quindi servono sì tante risorse, ma soprattutto serve una gestione più intelligente e coordinata di quelle che già oggi abbiamo a disposizione. Prima ancora di chiedere ulteriori fondi o stanziamenti, dobbiamo cominciare a porci seriamente la domanda: come stiamo utilizzando le risorse attuali? Serve una vera e propria spending review del sistema formativo e delle sue modalità di finanziamento.
Il rischio concreto è che, se non interveniamo sulla tenuta dell’impianto, cioè sull’efficacia della governance e sull’efficienza nell’uso delle risorse, finiremo per aumentare la pressione – cioè l’investimento economico – senza risolvere i problemi di fondo. Anzi, rischiamo di amplificare le perdite, come in un sistema idraulico pieno di falle: più acqua introduciamo, più pressione generiamo, più le falle si allargano, e meno acqua arriva dove dovrebbe arrivare.
Per questo motivo è urgente rivedere l’architettura complessiva del sistema: dalle politiche di formazione continua alla distribuzione dei fondi, dai criteri di accesso ai meccanismi di valutazione dell’impatto. Serve un ripensamento radicale, altrimenti corriamo il rischio di disperdere ulteriormente energie, risorse e tempo. Questo è il nodo fondamentale: a fianco di una politica giustamente orientata all’incremento delle risorse, deve esserci una revisione seria e coraggiosa degli strumenti, delle politiche e soprattutto delle procedure.
Dobbiamo tutti noi smettere di pensare che l’efficienza si giochi solo sul piano burocratico-amministrativo. Non basta una macchina che “funziona”: serve una macchina che serve davvero, che sia mirata all’efficacia, cioè alla capacità concreta di generare cambiamento, impatto, apprendimento, inclusione, sviluppo.
Per questo è necessario semplificare le procedure, rendendole funzionali agli obiettivi, ma anche educare tutti gli stakeholder del sistema a comprendere le regole in funzione della loro sostanza, piuttosto che del rispetto della forma. Il valore delle politiche dovrà essere valutato sempre più in base al valore generato per le persone, per i territori, per il lavoro piuttosto che in base alla spesa effettuata.
Solo così riusciremo a coniugare più risorse con più impatto reale. Altrimenti continueremo a irrigare un terreno che non assorbe più acqua.
Quello che serve, quindi, è un vero meccanismo di monitoraggio e valutazione della spesa pubblica nella formazione continua — costante, consapevole e generativo, capace cioè di produrre effetti retroattivi sul sistema, non solo fotografie statiche. Un sistema valutativo che non si limiti a finalità “contabili”, ma che produca statistiche in grado di orientare le decisioni, la programmazione, la revisione degli strumenti. Un meccanismo che sulla base della distribuzione territoriale delle risorse produca informazioni sui risultati effettivamente conseguiti, sulla qualità dell’apprendimento generato e sul valore formativo aggiunto prodotto dal formatore, dall’ente, dal progetto.
Oggi, troppo spesso, il finanziamento della formazione si riduce a pagare numeri: ore erogate, partecipanti presenti, checklist formali. Spero che quei numeri siano veri (e spesso non lo sappiamo davvero), ma non abbiamo alcuno strumento che ci dica quanto valore è stato generato. Nel sistema attuale, in buon formatore viene retribuito allo stesso modo di un cattivo formatore, sulla base di presenze e rendicontazioni, non in base all’efficacia formativa.
Questa è la distorsione da affrontare: introdurre una valutazione di qualità, che riconosca il merito didattico, la capacità trasformativa, la rilevanza per i territori e i settori produttivi. Senza questo, non c’è differenza tra chi insegna bene e chi no, e la formazione resta una spesa passiva invece che un investimento attivo.
Per lo stesso motivo per cui serve un sistema di monitoraggio continuo, è necessario anche sviluppare strumenti di valutazione qualitativa degli effetti della spesa pubblica in formazione. Non basta sapere quanto si spende o quante ore si erogano: dobbiamo iniziare a chiederci come si forma, quanto valore si genera, chi lo produce meglio.
Serve un cambio di paradigma: spostare il focus sulla qualità e non solo la quantità.
Questo significa anche, in modo molto concreto, “snellire un po’ il mercato”, per usare una formula chiara: oggi il sistema è congestionato da una presenza eccessiva di soggetti formativi. Sono oltre 7.000 in Italia, con punte altissime in alcune regioni. È evidente che questo genera frammentazione, disomogeneità e difficoltà di controllo.
Ecco perché occorre un intervento serio di qualificazione dei soggetti formativi. Il lavoro è stato avviato, insieme al Ministero, sul fronte della formazione dei formatori, e qualcosa si sta muovendo. Ma bisogna accelerare e consolidare.
Accanto a questo, però, c’è un altro nodo fondamentale: la vigilanza.
Oggi, il sistema è spezzettato: ogni ente controlla “il proprio gregge”, ognuno stabilisce standard e criteri autonomi. Questo favorisce distorsioni, rivalità poco trasparenti, e quella logica per cui “il mio modello è sempre migliore di quello degli altri”.
È indispensabile unificare la vigilanza, centralizzarla o quanto meno armonizzarla, per garantire regole comuni, controlli omogenei, eque condizioni di qualità. Solo così potremo trasformare davvero la formazione continua in un motore di sviluppo inclusivo, e non in un sistema autoreferenziale e opaco.
Serve un organismo terzo, autorevole e indipendente, che sia in grado di esercitare una vigilanza sistemica sull’intero comparto della formazione, anche attraverso pratiche ispettive puntuali ed efficaci. Un soggetto che non appartenga né ai soggetti formativi né ai finanziatori, ma che assicuri trasparenza, equità, rigore e qualità, contribuendo a fare ordine in un sistema oggi troppo frammentato e autoreferenziale.
Accanto a questo, è ormai evidente — ed è emerso con chiarezza anche nel corso di questi giorni di lavori — che è necessario avviare un vero processo di governance condivisa, che coinvolga tutti gli attori del sistema: ministeri, regioni, fondi interprofessionali, enti formativi, imprese, parti sociali.
Non possiamo più attendere grandi riforme istituzionali, i cui tempi non sono compatibili con l’urgenza delle sfide che abbiamo di fronte. Serve il coraggio di praticare il riformismo possibile, qui e ora, introducendo cambiamenti concreti, mirati e fattibili all’interno degli spazi normativi e amministrativi già esistenti. Solo così sarà possibile affrontare, con efficacia e responsabilità, i problemi reali del sistema della formazione continua.
Per guardare l’intervento di Amarildo Arzuffi al Workshop di Capri
CLICCA QUI
Scopri le proposte per il futuro del lavoro e della formazione. Clicca qui per prenotare la tua copia del Libro Bianco 2025.