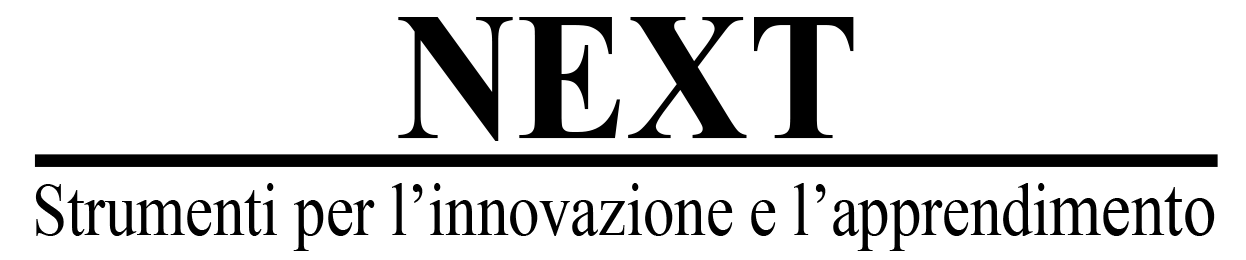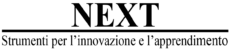Gruppo di lavoro coordinato da Antonio Capone
Sintesi di Eleonora Pisicchio e Fortunato Varone dal Prologo del Workshop di Capri (15-16-17 maggio 2025)
Partiamo da un assunto di base: le imprese non hanno bisogno che qualcuno dica loro di cosa hanno bisogno. Lo sanno perfettamente. Semmai, sono gli enti di formazione, le istituzioni e gli attori delle politiche attive ad avere bisogno di strumenti adeguati a comprendere le loro reali esigenze.
Il nostro Paese continua a essere competitivo nell’export, e questo non è per caso. Qualcosa di profondo è accaduto e continua ad accadere. Il sistema delle imprese italiane non è affatto in declino. Anzi, i dati dimostrano che, nonostante condizioni strutturali complesse, le nostre imprese esprimono eccellenze straordinarie, spesso non intercettate dai sistemi standard di classificazione.
Il sistema produttivo italiano, caratterizzato da una rete di piccole e medie imprese, si distingue per la sua flessibilità e capacità di adattamento. A differenza di modelli più standardizzati, come quello tedesco, l’Italia valorizza l’artigianalità e l’autonomia personale, elementi che contribuiscono al successo del Made in Italy. Questo approccio ha permesso al paese di mantenere una posizione competitiva nell’export, dimostrando che il sistema non è in declino, ma necessita di adeguamenti per affrontare le sfide future.
È corretto dire che il sistema è inadeguato, ma lo è nel senso che non si adatta facilmente alla logica centralizzata e standardizzata dei modelli di riferimento dominanti, come quello tedesco. Non possiamo misurare il nostro sistema produttivo – basato su alta artigianalità, creatività diffusa e microimprese capaci di innovare – con gli stessi parametri di chi ha costruito un’industria fondata sulla grande scala e sulla specializzazione verticale.
Il made in Italy non nasce da un modello fordista. Nasce dalla capacità di integrare competenze tradizionali e innovazione, in contesti dove l’autonomia personale, il saper fare e l’inventiva sono centrali. Pretendere che questo tessuto produttivo si conformi a un sistema uniforme e rigido, privo di riconoscimento della soggettività dei lavoratori e degli imprenditori, significa non capire ciò che ha reso l’Italia una potenza manifatturiera.
Questa consapevolezza deve guidare le politiche attive, formative e di sviluppo: non adattare le imprese ai dispositivi, ma adattare i dispositivi alla realtà viva delle imprese, facendo leva sull’ascolto, sulla personalizzazione, sulla costruzione di un sistema che valorizzi la nostra diversità strutturale come punto di forza, e non come anomalia da correggere.
Non possiamo dimenticare che accanto all’alta artigianalità e alla manifattura di eccellenza, l’Italia esprime anche competenze elevate in settori strategici come l’agricoltura, dove l’innovazione tecnologica e la qualità delle produzioni stanno ridisegnando le filiere. Il nostro sistema agricolo è un attore fondamentale della transizione ecologica e digitale.
Tuttavia, occorre evitare un atteggiamento di autoflagellazione quando confrontiamo singole imprese o modelli produttivi nazionali. Non serve paragonarsi costantemente ad altri contesti industriali, magari più centralizzati o normati, perché il nostro modello è diverso: diffuso, relazionale, integrato nei territori, e spesso fondato sulla resilienza più che sulla scala.
Il tema delle competenze è il vero nodo. Le innovazioni in corso – soprattutto quelle legate alla transizione digitale e all’intelligenza artificiale – non stanno generando problemi occupazionali in senso stretto. La sfida non è nella perdita dei posti di lavoro, ma nella mancanza di competenze adeguate ad affrontare i nuovi contesti produttivi.
E non si tratta di un problema generalizzato: le competenze mancanti sono prevalentemente in ingresso. I profili più giovani, o comunque non ancora formati, faticano ad allinearsi alle esigenze attuali del mercato. Ma chi già opera nei contesti produttivi ha dimostrato di sapersi adattare e aggiornare, spesso con una velocità superiore a quella delle istituzioni.
Infine, va chiarito un punto importante: l’intelligenza artificiale non stravolge i processi produttivi in modo radicale. Non sostituisce, ma integra. Non elimina le competenze di processo: le arricchisce, chiedendo ai lavoratori di saper interpretare, governare e utilizzare nuovi strumenti digitali, ma all’interno di logiche operative che restano ancorate al saper fare e all’esperienza.
In questo senso, il vero salto di qualità è culturale: costruire politiche formative e orientative che valorizzino ciò che c’è già e accompagnino i nuovi ingressi, evitando sia la retorica della discontinuità totale, sia quella dell’immobilismo.
L’intelligenza artificiale come leva di miglioramento
L’adozione dell’IA nell’industria italiana sta crescendo, con un mercato che ha raggiunto i 760 milioni di euro nel 2023, segnando un aumento del 52% rispetto all’anno precedente. L’IA contribuisce a migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare i processi produttivi e ridurre i costi, senza stravolgere radicalmente le competenze esistenti. In particolare, l’IA supporta la gestione dei big data, la manutenzione predittiva e la segmentazione del mercato, offrendo strumenti per una produzione più intelligente e reattiva.
Nonostante i benefici apportati dall’IA, molte imprese italiane, soprattutto le PMI, affrontano difficoltà nell’adozione di queste tecnologie a causa della mancanza di competenze adeguate. Solo l’8% delle PMI utilizza l’IA nella produzione, mentre nelle grandi aziende la percentuale sale al 26%. È fondamentale investire nella formazione e nello sviluppo di competenze digitali per colmare questo divario e sfruttare appieno le potenzialità offerte dall’IA.
Per affrontare le transizioni in corso, è necessario superare il concetto tradizionale di politiche attive del lavoro e adottare un approccio orientato all’attivazione. Ciò implica la creazione di sistemi di orientamento che non siano più deterministici, ma che supportino le persone nella progettazione del proprio futuro, tenendo conto delle competenze richieste dal mercato e delle aspirazioni individuali.
È importante costruire un sistema coerente che integri governance, misure di supporto e formazione per gestire le transizioni lavorative e rigenerare la popolazione attiva. È essenziale promuovere un dialogo sociale costruttivo, valorizzare le risorse esistenti e sviluppare modelli di cooperazione tra pubblico e privato. Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile affrontare le sfide future e garantire una crescita sostenibile per il sistema produttivo italiano.
La vera emergenza è la trasmissione del sapere nei processi produttivi. Nel ragionamento sulle competenze per le transizioni, è emerso un dato cruciale che riguarda non tanto le nuove competenze da acquisire, quanto quelle che rischiamo di perdere.
Il problema non sta esclusivamente nei profili professionali emergenti legati alla digitalizzazione, ma in ciò che accadrà quando usciranno dal sistema produttivo migliaia di lavoratori e lavoratrici con competenze tacite e artigianali che costituiscono la spina dorsale di molte filiere del Made in Italy. Stiamo parlando di maestranze, tecnici di produzione, operatori esperti di manifattura, agricoltura avanzata, lavorazioni artistiche e industriali.
Questo sapere, spesso non formalizzato, non può essere trasferito semplicemente con corsi standardizzati. La trasmissione intergenerazionale deve diventare un obiettivo esplicito delle politiche attive.
Il dato anagrafico lo conferma: la coorte centrale dei lavoratori, tra i 35 e i 50 anni, è oggi la meno numerosa. Eppure, è proprio questa fascia che dovrebbe assumere il testimone dalle generazioni in uscita. Se non agiamo in fretta, si produrrà un vuoto di competenze strutturale, difficilmente colmabile.
Che fare? Alcune proposte operative
Costruire percorsi di “eredità produttiva” nelle imprese, in particolare nelle PMI e nelle imprese artigiane, con incentivi alla trasmissione interna del sapere tramite affiancamento generazionale, apprendistato evoluto e tutoraggio.
Valorizzare le competenze tacite con meccanismi di riconoscimento e certificazione flessibile (es. micro-credential, badge professionali) che possano trasformare il sapere esperienziale in patrimonio comune.
Riprogettare l’offerta formativa non solo sulle nuove tendenze tecnologiche, ma anche sulle competenze a rischio di estinzione, favorendo ibridazioni tra tradizione e innovazione.
Creare un “osservatorio delle competenze in uscita”, nazionale e territoriale, capace di mappare e anticipare dove si stanno formando i vuoti di competenze per tempo.
Questa è la sfida di fondo per la sostenibilità del nostro sistema produttivo: non solo anticipare il futuro, ma non disperdere il meglio del passato. Come è emerso chiaramente al Net Forum, la transizione non è solo digitale o verde, ma anche umana e generazionale. E va affrontata con strumenti nuovi, visione sistemica e una forte alleanza tra imprese, istituzioni e territori.
Rivalutare i mestieri che rendono distintivo il Made in Italy
Uno dei temi centrali emersi nel gruppo è la necessità di ridare appetibilità sociale, formativa e professionale a quei lavori che, pur non essendo legati all’intelligenza artificiale o alle tecnologie di frontiera, sono fondamentali per l’identità e la competitività del Made in Italy. Si tratta di mestieri manuali, artigianali, tecnici, sartoriali, spesso non brevettabili, ma che generano valore, occupazione e reputazione internazionale.
C’è un paradosso: da un lato l’Italia è debole sull’intensità brevettuale, segnale che ci potrebbe far pensare a un arretramento innovativo; dall’altro, abbiamo il più alto tasso di fatturazione elettronica d’Europa, segno che la digitalizzazione dei processi c’è ed è matura, ma è integrata in un tessuto produttivo che resta prevalentemente relazionale, artigianale, a misura di persona.
Questo tessuto è unico. Eppure, si sta modificando: la forza lavoro si sta spostando dalle microimprese verso le grandi imprese, attratta da migliori condizioni contrattuali, salariali o di stabilità. Questo fenomeno, se non governato, mette a rischio quella “sartorializzazione” del prodotto che ci distingue nel mondo.
È quindi errato e fuorviante parlare di declino del sistema produttivo italiano. Non siamo davanti a un sistema decadente, ma a un sistema diverso, che non può essere letto con le stesse lenti con cui si interpreta il modello tedesco o francese, basato su filiere verticali, standardizzazione produttiva e forte intensità brevettuale.
In Italia il brevetto spesso non serve: il valore è nel maestro, nel “come” si fa, non solo nel “cosa”. È un sapere incarnato, relazionale, situato, difficilmente replicabile. Per questo le politiche attive e formative devono saper valorizzare anche queste eccellenze, e non cadere nella trappola dell’omologazione dei modelli.
Per affrontare le transizioni, dobbiamo saper leggere la nostra struttura produttiva con occhi nuovi, riconoscendo le specificità territoriali, le vocazioni settoriali e la natura fortemente umana e qualitativa del nostro sistema economico. L’intelligenza artificiale e i dati sono strumenti preziosi, ma non possono e non devono sostituire ciò che rende il nostro sistema produttivo unico: il capitale umano, la cultura del lavoro e il saper fare italiano.
Questa consapevolezza è il punto di partenza per progettare una formazione realmente orientata, un orientamento realmente informato, e una governance realmente integrata, che tenga insieme tradizione, innovazione e persone. Solo così potremo trasformare le transizioni in opportunità e non in minacce.
Il tema delle competenze non può più essere affrontato con la sola lente della formazione occorre sviluppare una narrazione, una nuova grammatica che supporti la comprensione delle competenze presenti nei territori. Occorre spostare il baricentro sulla narrazione, ovvero sulla capacità di generare visioni condivise, percorsi di senso e sistemi orientativi solidi, radicati nei territori. L’obiettivo non è “formare per formare”, ma attivare processi generativi di valore, che mettano in connessione reale e operativa tutti gli attori dell’ecosistema: centri di competenza, enti di trasferimento tecnologico, fondi interprofessionali, enti di formazione, imprese, scuole e università.
Oggi manca ancora un raccordo strutturato tra questi soggetti, in particolare con il mondo scolastico e accademico, e ciò comporta una incertezza diffusa su come agire efficacemente sulle competenze in ingresso. Questo vuoto si traduce in una debolezza sistemica: troppa offerta “a monte”, poca capacità di leggere ciò che serve “a valle”.
Per questo motivo non si può più partire dal presupposto che qualcuno debba spiegare alle imprese cosa fare. L’approccio va rovesciato. Bisogna sviluppare una competenza maieutica nei soggetti intermedi — pubblici e privati — che sia in grado non di prescrivere, ma di ascoltare, far emergere, interpretare i fabbisogni. Accompagnare le imprese a riflettere sui vantaggi della formazione, in termini di produttività, qualità, innovazione e attrattività per i giovani.
La sfida è individuare target group ben definiti, e costruire interventi concreti che rendano operativa la collaborazione tra fondi, enti di formazione e territori, tenendo conto delle specificità territoriali e metodologiche. Non ha senso proporre modelli unici: le regioni del Sud, ad esempio, sono caratterizzate da una forte presenza di microimprese, che necessitano di approcci più agili, relazionali, e non standardizzati.
Allo stesso tempo, va riconosciuta anche l’eterogeneità dei fondi interprofessionali: ciascuno con un’identità, una storia e una platea di riferimento differenti. Ma è proprio in questa varietà che può nascere un sistema delle competenze territoriali, capace di articolare soluzioni formative pertinenti con i bisogni reali dei sistemi produttivi, soprattutto in relazione all’inserimento qualificato dei giovani e al miglioramento continuo dei processi produttivi.
La tecnologia, da sola, non salva il mondo. Può essere un acceleratore, ma non sostituisce il ruolo strategico degli asset territoriali, né la centralità del genius loci: quell’insieme di cultura produttiva, tradizione, relazioni e saperi locali che ancora oggi rappresenta il vero vantaggio competitivo dell’Italia nelle nicchie di alta qualità.
Non servono solo algoritmi, ma sistemi cognitivi complessi, capaci di affrontare la varianza dei contesti attraverso la capacità di riconoscere e proteggere le invarianti, cioè i tratti identitari, i valori condivisi, la cultura produttiva locale. È qui che si gioca la vera sfida: coniugare flessibilità e radicamento, innovazione e tradizione, competenze emergenti e competenze da trasmettere.
Serve un nuovo paradigma di policy making formativo, che sia narrativo, relazionale, partecipativo. Che ascolti prima di progettare, analizzi prima di normare, con una regia pubblica capace di promuovere collaborazioni virtuose e non modelli uniformi. La formazione torna a essere ciò che è sempre stata nei momenti di svolta: una leva di rigenerazione culturale, sociale ed economica. Ma solo se saprà partire dalle persone, dai territori, dalle imprese vere.
Il gruppo di lavoro ha sviluppato il proprio confronto a partire da due suggestioni chiave proposte nella fase introduttiva: da un lato, la crescente frequenza e rapidità dei cambiamenti nei processi produttivi – rispetto al passato – che impongono un costante adattamento; dall’altro, la necessità di non leggere automaticamente le transizioni (ecologica, digitale, demografica) come minacce occupazionali, ma come opportunità da governare con consapevolezza.
Uno dei primi elementi emersi è stato il confronto con il “Sistema Italia”, un ecosistema produttivo fatto di piccole e medie imprese, molto diverso da quello di altri Paesi europei come la Germania. Le nostre imprese, spesso caratterizzate da lavorazioni non replicabili e da competenze tacite non brevettabili, esprimono una ricchezza che non può essere catturata con i soli indicatori tradizionali, ma che va riconosciuta e valorizzata anche in chiave intergenerazionale.
In particolare, si è riflettuto sul rischio concreto di perdere saperi artigianali e professionalità storiche non trasferite alle nuove generazioni. In questo senso, l’intelligenza artificiale – più che sostituire – può aiutare a valorizzare e diffondere tali competenze, purché le politiche attive sappiano accompagnare le transizioni.
Da qui, è emersa una proposta di cambio di paradigma: passare da “politiche attive del lavoro” a “politiche di attivazione”, che mettano la persona al centro, non come destinatario passivo ma come protagonista capace di progettare il proprio futuro. L’orientamento, allora, non può più essere deterministico – “ti dico cosa devi fare” – ma deve diventare accompagnamento alla costruzione consapevole del proprio percorso.
Una riflessione molto concreta ha riguardato anche i giovani: da una ricerca UGL-LUISS è emerso che il 60% è preoccupato per le scelte universitarie e il 40% chiede più informazione sul mercato del lavoro. Sviluppo Lavoro Italia ha presentato in questo senso uno strumento importante: una piattaforma nazionale che integra dati ISTAT, Atlante del lavoro e informazioni sulle competenze richieste per ogni unità professionale. In futuro, questa sarà arricchita anche con le job vacancies analizzate in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale, costruendo un ponte tra linguaggio delle imprese e classificazioni ufficiali.
Nel gruppo è stata anche ribadita l’importanza di rafforzare le competenze di base e trasversali – soprattutto per i giovani – per renderli capaci di adattarsi ai cambiamenti. Le soft skills diventano fondamentali, così come l’ascolto delle imprese nella progettazione formativa. Non possiamo più imporre dall’alto ciò che secondo noi va fatto: occorre ribaltare la piramide e partire dai fabbisogni reali.
Infine, il gruppo ha sottolineato il valore della flessibilità come parola chiave. Flessibilità normativa, flessibilità nell’offerta formativa, flessibilità nella governance: servono “spinte gentili” che attivino le persone, senza rigidità eccessive. In un mercato del lavoro in continuo mutamento, solo un approccio adattivo e dinamico può risultare efficace.
Fortunato Varone, Direttore del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria
Il direttore Varone ha aggiunto una considerazione molto importante ai risultati espressi dai gruppi di lavoro, restitutendo alcune osservazioni puntuali sul tema:
- Modelli di riferimento: sarebbe utile evitare una contrapposizione troppo netta con il modello tedesco, sottolineando invece la necessità di indicatori più adatti alla specificità del sistema produttivo italiano, senza sminuire altri approcci.
- Brevetti e saperi taciti: laddove si evidenzia il valore del “come si fa” rispetto al “cosa si fa”, si potrebbe rafforzare il messaggio affermando che brevetti e competenze tacite non sono alternativi, ma complementari e entrambi rilevanti.
- Intelligenza artificiale: viene giustamente detto che l’IA non stravolge radicalmente i processi, ma suggerirei di specificare che si tratta di una fotografia attuale, lasciando aperta la riflessione sugli effetti più dirompenti che potrebbero emergere a medio termine.
- Ruolo delle imprese: il richiamo al fatto che le imprese “sanno già di cosa hanno bisogno” è condivisibile, ma si potrebbe rafforzare il concetto di accompagnamento e interpretazione da parte dei soggetti pubblici e intermedi, più che di semplice ascolto.
- Competenze a rischio di estinzione: sarebbe interessante inserire uno o due esempi concreti (settori, mestieri) per rendere ancora più tangibile il tema della trasmissione intergenerazionale dei saperi.
Infine, suggerisco di valorizzare ulteriormente il passaggio sulle “politiche di attivazione”, chiarendo che si tratta di un modello centrato sulla persona e sull’emersione delle aspirazioni individuali, ben distinto da approcci più prescrittivi o condizionanti.
Rinnovo i miei complimenti per l’organizzazione e la qualità del percorso, e confermo con piacere la disponibilità a partecipare al Summit di Roma il 23 settembre.
Scopri le proposte per il futuro del lavoro e della formazione. Clicca qui per prenotare la tua copia del Libro Bianco 2025.