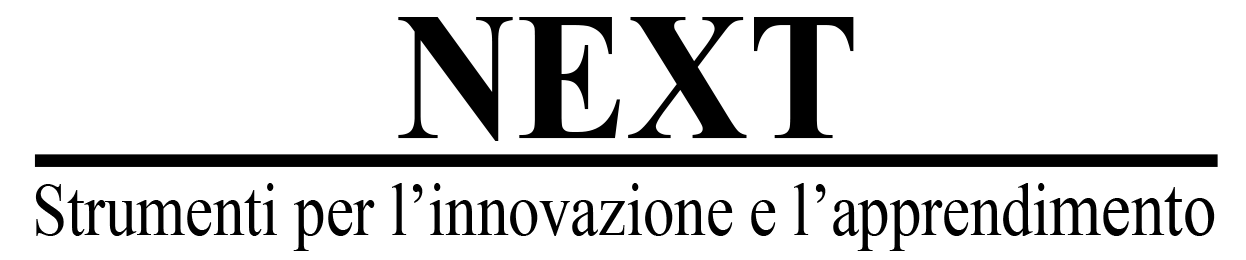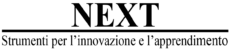di Enrico Cardillo, amministratore delegato di Stoà
Nel mondo in cui viviamo, la capacità di adattamento ai cambiamenti è sicuramente una chiave di successo. Il mix del lavoro, i processi di produzione, le competenze necessarie, sono in continuo cambiamento. Ecco perché, secondo un’indagine di Pwc, il 77% degli adulti è disposto ad acquisire nuove competenze. L’innovazione può accompagnarsi a benessere e sostenibilità, affrancamento dal bisogno e l’insicurezza di futuro. Non è solo un driver di cambiamento tecnologico e organizzativo, piuttosto che un modo per accrescere i profitti. Ma non c’è dubbio che, in Italia, la contemporaneità è caratterizzata da un lato dal veloce cambiamento dei lavori e dall’altro da un contraddittorio funzionamento del mercato del lavoro. In Italia non si riescono a coprire 1,2 milioni di posti di lavoro per mancanza di competenze. E vantiamo anche il triste primato di ben 3 milioni di Neet, giovani che non lavorano e non studiano, e un tasso di abbandono scolastico stabilmente a doppia cifra.
Da tempo, specie nel Mezzogiorno, appare indispensabile un cambiamento epocale delle politiche pubbliche di istruzione e formazione caratterizzate da due storici punti deboli: la distanza tra imprese e scuola, e un impiego inefficace di ingenti risorse pubbliche. Un’inefficienza pesante sul sistema delle imprese che devono (fino a un certo punto) porvi rimedio. Eppure, tutti sanno che le competenze sono una risorsa per la competitività italiana influenzandone la qualità dello sviluppo e la sintonia con i nuovi paradigmi dei processi produttivi. Il Pnrr ha destinato ben 19 miliardi di euro al potenziamento dell’education facendone un punto centrale di cambiamento per il nostro Paese e per generale innalzamento delle capacità delle risorse umane. Da troppo tempo l’Italia soffre di un’assurda contraddizione del mercato del lavoro: imprese che vogliono assumere ma non trovano giovani dotati di competenze e giovani che cercano lavoro e non lo trovano. È il «mismatch» che segnala l’abnorme forbice tra domanda e offerta di lavoro.
Si tratta, certamente, di un fenomeno mondiale considerando che riguarda oggi – secondo un’indagine di Boston Consulting – 1,3 miliardi di persone (nel 2030 1,4 miliardi). Nel nostro Paese lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro è del 40%, non si trovano 4 lavoratori su 10! Uno scenario davvero preoccupante. Nel solo settore della meccatronica e robotica non si trova il 49% del personale. Inoltre, nel periodo 2023-27 si sono affacciati e si affacceranno sul mercato del lavoro un milione e centromila giovani usciti da un percorso di formazione tecnico-professionale. Ma questa offerta riuscirà a soddisfare solo il 60% della domanda potenziale del quinquennio.
Oggi, si stima in 37,7 miliardi di euro il costo del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Un costo enorme che pesa sulle aspettative delle nuove generazioni, sulle imprese, sul nostro Paese che deve affrontare le impegnative sfide della transizione energetica ed ecologica. Siamo in forte ritardo nell’affrontare le conseguenze della rivoluzione digitale che ha riscritto i termini della produzione, della sua organizzazione e della intera catena del lavoro. Fino a pochi decenni fa, negli anni Ottanta del ‘900, gli operai rappresentavano il 70% dei lavoratori e i colletti bianchi il 30%. Ora, nel settore metalmeccanico la percentuale operaia si attesta al 46,8% (-25,3% rispetto agli anni ’80) e quella impiegatizia oramai al 46,8% (Raffaele Morese, «Nuovi Lavori»).
Il cambiamento che impatta sulle persone non è solo figlio delle trasformazioni digitali ma anche di quelle climatico-ambientali e demografiche. La rilevanza di questi cambiamenti, oltre a produrre incrinature e inefficienze sul corretto funzionamento del mercato del lavoro, chiama in causa, come già detto, un radicale cambiamento delle politiche pubbliche. La riscrittura della loro «grammatica» deve poggiare sull’importanza sempre più evidente dell’Ed Tech, delle nuove tecnologie, dell’Intelligenza artificiale, di offerte formative botton-up, della diffusione dei Moocs (ovviamente di qualità), di incroci tra soft skill e competenze specialistiche, divisione politecnica. Le imprese, per migliorare adattabilità ai cambiamenti, migliorare il clima delle proprie organizzazioni e il business, devono continuamente alimentare processi di coaching e leadership di qualità senza più supponenze di imprenditori e management. È la parte alta della governance delle organizzazioni che, inavvertitamente, può essere il primo e più letale tappo al cambiamento! Infine, la vera frontiera da varcare per ridurre l’ampiezza del «mismatch» è considerare davvero la formazione una risorsa fondamentale per produrre valore e non un costo come, purtroppo, ancora attecchisce in settori imprenditoriali segnati da miopia di visione.
Direttore generale Stoà
Istituto di studi per la Direzione e Gestione di Impresa S.c.a.r.l.