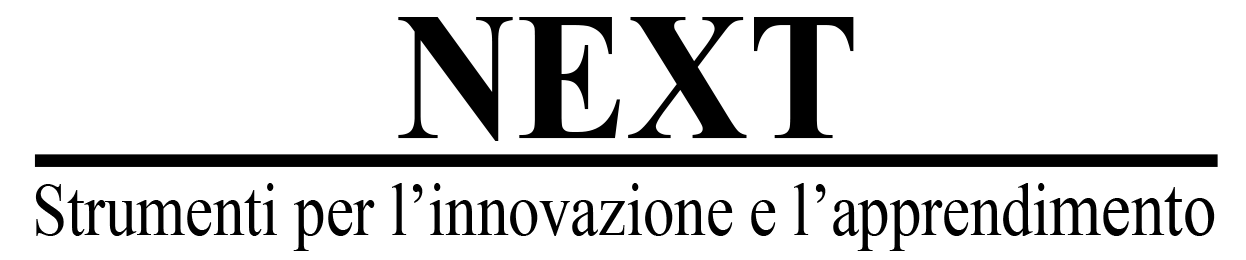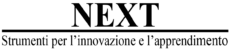di Giulia Calvaruso
Il territorio italiano, a forma di stivale, stretto, lungo, montano, collinare, marittimo, isolano, rurale, forestale… è composto al più di 70% da borghi con annessi parchi naturali e aree protette e per il restante da grandi città con le loro periferie. Spesso le due facce della medaglia non riescono a comunicare, a connettersi e a trovare quei collegamenti necessari per diventare ecosistema e organismo pulsante. È così che i cosiddetti borghi rappresentano la vasta e multipla identità del territorio italiano e sono anche simbolo del boom economico che, durante l’Italia del secondo dopo guerra, ha spinto le persone verso le città in un grande esodo ancora oggi in corso. La desertificazione e l’abbandono dei piccoli paesi ci ha fatto dimenticare di quanto essi siano risorse per nuove prospettive economiche e sociali e per modelli di vita più sostenibili, da tutti i punti di vista.
Il turismo sostenibile dell’albergo diffuso
A far «sentire» per la prima volta le grida disperate di queste realtà ci voleva un disastro ambientale. Nel 1976 i paesi montani del Friuli-Venezia Giulia devastati da un terremoto divennero oggetto di una nuova prospettiva di sviluppo pensata dal professore Giancarlo Dall’Ara: l’«albergo diffuso». Il modello dell’albergo diffuso trasforma un paese in un’attività ricettiva con camere dislocate e fa vivere a chi ci alloggia l’esperienza di vita lenta, genuina e sostenibile che è propria di questi paesaggi, in ottica prettamente turistica e in alcuni casi più attuali di permanenza con co-working per «lavoratori nomadi».
Oggi in Italia ci sono circa 140 alberghi diffusi. La Sirena Filicudi, frazione di Lipari in Sicilia, Omu Axiu in provincia di Nuoro in Sardegna, Borgo dei Corsi in provincia di Arezzo in Toscana fino ad arrivare ad Alberobello con i suoi Trulli e a Matera con i suoi Sassi, sono tutte realtà rinate grazie a una leva di sviluppo economico basata sul modello turistico dell’albergo diffuso, più sostenibile e attento all’ambiente.
Uno degli esempi più famosi è Santo Stefano di Sextantio in Abruzzo, un progetto che riutilizza edifici originali e recupera la cultura identitaria del territorio proponendo servizi della tradizione come biancheria in lana fatta a mano con telai in legno e colori naturali o la produzione di saponi artigianali. Dai tratti di suggestive esperienze immersive, gli alberghi diffusi sedimentano la memoria dei luoghi facendo spettacolo delle loro identità e manifestando quanto siano possibili modelli di vita alternativi che prendono insegnamento dal passato per andare verso il futuro.
Tuttavia, questo sviluppo economico basato su un modello turistico più sostenibile e attento all’ambiente rischia di ricadere in un approccio conservativo tipico delle città d’arte, trasformando i borghi in piccoli gioielli. Non basta, insomma, puntare sulla mera attrattività turistica. Le realtà dei borghi sono immense e il loro valore culturale sta proprio nella valorizzazione della molteplicità. Le distanze vanno accorciate, i servizi vanno connessi e le comunità vanno riattivate.
Un borgo, un modello di vita
In quest’ottica nasce l’Ecovillaggio di Torri Superiore in Liguria. Il progetto dell’Ecovillaggio fa tesoro degli insegnamenti del passato come l’impianto urbano originario e le architetture con materiali oggi affini alla bioarchitettura e li accosta alle tecnologie più moderne per far nascere una nuova comunità abitativa stabile. L’intervento fatto a Torri Superiore ha generato un aumento del valore degli immobili del 500% e soprattutto (insieme ad altri esempi di «comuni rinnovabili» come San Lorenzo Bellizzi nel Parco nazionale del Pollino in Calabria che fa utilizzo massiccio di fotovoltaico), ci insegnano che le piccole organizzazioni possono applicare tutti i principi della sostenibilità, economica, sociale, ambientale e culturale, tanto auspicate da grandi progetti nazionali, internazionali, mondiali. Creare un modello di vita totalmente sostenibile è possibile proprio quando lo sguardo al passato si unisce con il presente, spingendosi oltre.
Così come Torri Superiore, ci sono tantissimi altri esempi di realtà rinate «dal basso», dalle persone o da progetti di diffusione del sapere e condivisione della cultura. Castelbasso, in Abruzzo, è diventata luogo di importantissimi eventi grazie alla fondazione Malvina Menegaz che promuove cultura e arte contemporanea. Erice in Sicilia è oggi conosciuta come «città della scienza» per il Centro di cultura scientifica Ettore Majorana creato dal fisico Antonino Zichichi nel 1963, che attira ogni anno tantissimi studiosi e scienziati, tra cui premi Nobel. Calcata nel Lazio, come anche Bussana Vecchia in Liguria, Castelbasso in Abruzzo, Terravecchia in Calabria, Aliano e Grassano in Puglia, Montisi in Toscana e Provvidenti in Molise sono stati luoghi di rifugio per tantissimi artisti e oggi portano avanti eventi stagionali come festival o fiere che riescono a generare valore per gli abitanti e per i nuovi ospiti.
Altrettanti sono i paesi che hanno dato vita a iniziative che innovano la tradizione e valorizzano ad esempio le proprie specialità enogastronomiche come San Felice in provincia di Siena o del Borgo Cerquelle in provincia di Benevento, o anche che rinascono con imprese che riprendono le tradizioni produttive e manifatturiere come il «borgo del cashmere» di Solomeo, in provincia di Siena. Il profilo dell’Italia è costellato da paesi ricchi di identità, già riscoperte o ancora dimenticate.
Possibilità e sviluppi verso il futuro
Molte iniziative di riscoperta sono state possibili per investimenti privati e, almeno fino al 2021, anche grazie a fondi europei o ad alcune risorse nazionali stabilite dalla legge 158/2017 per la valorizzazione dei Piccoli Comuni (legge «Salva borghi»). Dal 2022 a oggi il Piano Nazionale Borghi, e altri progetti nati nell’ambito del Pnrr offrono opportunità per partecipare a bandi e ottenere finanziamenti. Spesso questi investimenti stimolano i borghi a trasformarsi in destinazioni alternative di flussi turistici per decongestionare le tappe usuali del turismo di massa garantendo una promessa valida in termini di benessere, bellezza, autenticità e qualità. Ma il vero obiettivo della riqualificazione di queste infinite identità di cui l’Italia è piena è quello di manifestare il valore che la differenza, la discrepanza, l’eterogeneità riescono a generare, facendoci vedere nuove prospettive di sviluppo per tutto il Paese. Lo sguardo che la rivalorizzazione dei territori deve tenere ben fisso è quello puntato alla costruzione di un ecosistema complesso in cui possono vivere tutte le identità italiane imparando l’una dall’altra e individuando i modelli di sviluppo economico e sociale che si possono davvero attuare.
Il collegamento tra tutte le realtà italiane, la creazione di infrastrutture e relazioni sono le premesse per far emergere le possibilità infinite dei territori e per cogliere le occasioni di crescita sia per le città sia per i paesi stessi. È così i paesi ultraperiferici oggi ancora fin troppo lasciati andare a sé stessi, abbandonati, desertificati ci insegnano soprattutto che una realtà come l’Italia deve puntare su un modello che allarga gli spazi e accorcia le distanze. Ci insegnano che è importante connettere le diversità e non schiacciarle in unico contenitore, ci insegnano che far emergere le caratteristiche specifiche dei territori crea valore, benessere diffuso, sostenibilità. Riattivare desideri collegati ai bisogni dei territori, dell’ambiente e delle persone e creare connessioni economiche, sociali, infrastrutturali sono chiavi fondamentali per una crescita onnicomprensiva di paesi, grandi città, periferie in cui c’è la forte necessità di ripensare gli spazi, riprogettare l’ambiente secondo i principi dell’abitare armonico.